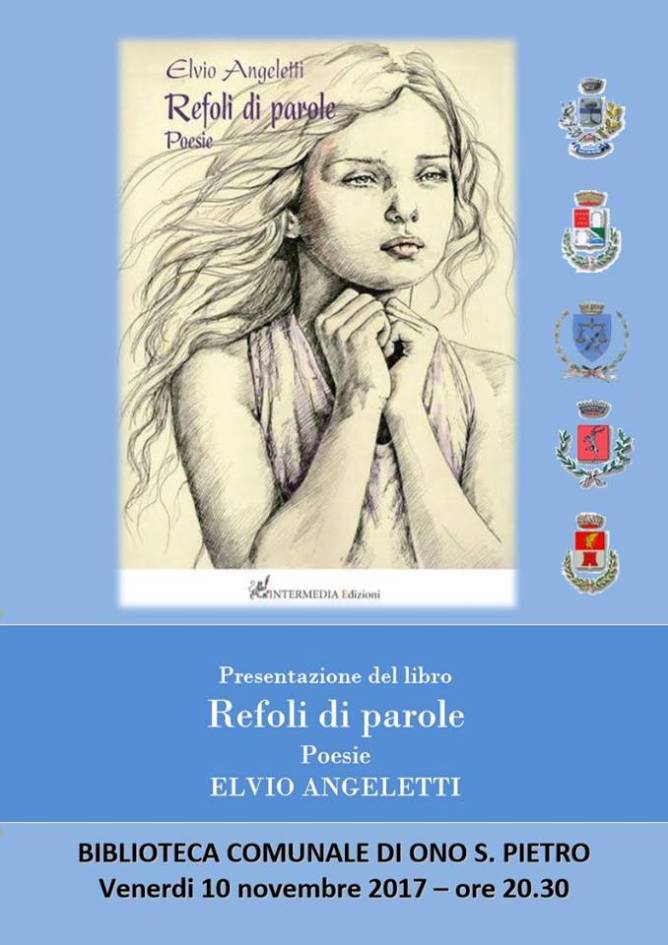Intervista a Irma Kurti
A cura di Lorenzo Spurio
L.S.: In quale città/zona dell’Albania sei nata e vissuta? Puoi raccontarci qualche episodio della tua infanzia?
I.K.: Sono nata a Tirana ma ho passato l’infanzia a Elbasan, una città situata nella zona centrale del paese. I ricordi dell’infanzia, anche se priva di tanti giochi e gioie, sono sempre coperti da un velo di nostalgia. Ricordo gli attimi in cui salivo sul palcoscenico a cantare, le domeniche quando le donne pulivano il cortile e la polvere copriva tutto, anche i nostri pensieri, le passeggiate nella via principale costeggiata dagli alberi vicino ai marciapiedi. Provo ancora una specie di ansia quando mi vengono in mente le corse che facevamo per rifugiarci nel tunnel sotterraneo davanti al palazzo per proteggerci “dall’attacco nemico”. Erano simulazioni che venivano fatte per simulare un’eventuale invasione: momenti difficili che incutevano angoscia e paura. Sentivamo la sirena dell’allarme a qualsiasi ora della notte. Ci alzavamo di fretta, i nostri genitori ci preparavano, ci vestivano come delle bambole. Eravamo addormentati e terrorizzati, ma non c’era tempo di fare domande perché dovevamo scendere velocemente. Il volume della sirena era forte ed era minacciosa, come se appartenesse a un’altra epoca. Sento ancora oggi il velocizzarsi dei battiti cardiaci di quella bambina spaventata che ero, che fissava con occhi spalancati scene reali e irreali al tempo stesso, che la circondavano.
L.S.: Che ricordo hai del tuo paese?
I.K.: Ricordi vividi e altri sfocati. Non dimentico ore e giorni interi passati al buio per la mancanza dell’energia elettrica. Il festeggiamento del Capodanno al freddo, sotto la tenue luce della candela, il terrore di vedere per strada persone armate con kalashnikov che sparavano all’impazzata, le notti passate in bianco a causa dagli spari che mi uccidevano la serenità, la preoccupazione e la tristezza negli occhi dei miei genitori mentre invecchiavo anch’io con loro.

L.S.: Come era la vita durante la dittatura comunista di Hoxha?
I.K.: Una vita non vissuta direttamente, in prima linea, ma dettata dagli altri che ti infondevano perfino i pensieri. Eravamo soltanto degli automi in un sistema che ci aveva rubato l’anima. Giorni colmi di demagogia. L’arte e la letteratura erano completamente politicizzate. Nei festival, per esempio, c’era l’obbligo di presentare canzoni dedicate al partito del lavoro e al suo leader. Ciò succedeva anche con le opere poetiche. Qualche anno fa ho trovato un block notes con delle poesie scritte per un pubblico infantile durante gli anni 1986-1990. In un verso c’era scritto: “Quando ci chiama la patria/siamo tutti i suoi soldati”. E in un altro: “Ogni giorno cresciamo felici/sotto il sole del Partito”.
L.S.: Quali restrizioni e negazioni hai sofferto principalmente?
I.K.: Ho fatto la scuola media superiore a Tirana perché nella città natale non c’era la scuola delle lingue straniere. Il primo anno ho vissuto al convitto, ma ho dovuto abbandonarlo perché le condizioni sanitarie erano scarse: non c’era acqua calda e la qualità del cibo era scadente. Mi ha ospitato mio zio. Dormivo poco, mi svegliavo alle tre o alle quattro di notte dalle voci della gente in coda per comprare latte, uova e yoghurt. A volte chiacchieravano semplicemente, altre discutevano a chi toccava per primo il turno. Quelle voci le sento ancora. Nella camera dove studiavo e mi svegliavo senza più riuscire a dormire, si è plasmato il mio carattere. Da ragazza vivace, alla quale piaceva scherzare, imitare amici o insegnanti davanti alla classe, che prendeva l’iniziativa, recitava e cantava sul palcoscenico, sono diventata timida, riservata e malinconica.
L.S.: Quando e perché sei giunta in Italia?
I.K.: Sono arrivata in Italia nel 2006. La procedura per ricevere il permesso di soggiorno sarebbe terminata l’anno dopo. In quel periodo a mia madre, che nel frattempo soggiornava a Bergamo, venne diagnosticata una malattia grave e così decisi di raggiungerla per starle vicino.
L.S.: Quali sono le immagini che più ti legano al tuo paese natale?
I.K.: L’immagine più cara è il nostro piccolo appartamento a Tirana. Lì respirano i ricordi e i sogni di quando eravamo una famiglia. Non c’erano luce, acqua, riscaldamento, ma avevamo l’uno e l’altra e quel grande affetto che ci aiutava a sopravvivere nelle situazioni difficili. Penso a quell’appartamento come a un essere umano. Quando piove, nevica o in un giorno normale il mio pensiero corre lì: “Si bagneranno i vetri, il balcone cadrà a pezzi dalla nostra mancanza?”.
 L.S.: Quali spazi (mare, collina, etc.) hanno contraddistinto la tua infanzia/adolescenza e quale ricordo hai di essi?
L.S.: Quali spazi (mare, collina, etc.) hanno contraddistinto la tua infanzia/adolescenza e quale ricordo hai di essi?
I.K.: Un palazzo a forma di L mi suscita sempre una nostalgia indescrivibile. Lì, nell’angolo, dove si incontravano le due ali della L, si trovava il mio appartamento. Dietro l’edificio si estendeva un parco immenso dove giocavamo o passeggiavo con i miei. A volte provo il desiderio irrefrenabile di andare e bussare in tutte le porte dei vicini, ma temo l’assenza di quelli che non troverò: persone care che non potrò mai più riabbracciare, perché se ne sono andate per sempre. Non avevo giocattoli, non avevo una camera tutta mia, non avevamo televisore e quando l’abbiamo comprato guardavamo un solo canale; abbiamo vissuto con poche cose, con tante carenze, ma tenevamo le porte spalancate nel vero senso della parola. Entravamo senza bussare a casa dei vicini. Quella sensazione di farne parte di una grande famiglia non l’ho più provata e credo che non la proverò mai più nella vita.
L.S.: Torneresti a vivere in Albania?
I.K.: No. Solo le situazioni della vita dovessero riportarmi lì per qualche ragione.
L.S.: L’Albania di oggi è un paese vivibile? Che futuro intravedi?
I.K.: Conosco emigrati che sono tornati o che vogliono tornare al loro paese d’origine. Conosco italiani che amano l’Albania e hanno programmato di andare a vivere lì. Tante cose sono cambiate, ma altre sono ferme o si trascinano com’erano. Anche se sono passati ventisette anni dall’apertura delle frontiere, l’economia non si è sviluppata granché, c’è tanta povertà e il sogno di tante persone resta ancora quello di emigrare. Intravedo un’Albania invasa dai turisti, a ragione delle sue bellezze naturali e genuine ma anche per l’ospitalità e la cordialità della gente.
L.S.: Cosa c’è, nell’anima del popolo albanese, nel suo modo di fare, nel suo atteggiamento che ti manca e che non c’è nel popolo italiano?
I.K.: In Albania non esistono gli orari e, di conseguenza, neanche l’ansia perché si è in ritardo. La gente sta seduta per ore davanti a una tazza di caffè, il tempo non ha il valore che gli diamo in Italia e i giorni non sono così frenetici.
L.S.: Quando scrivesti la prima poesia e perché? Ricordi di quale testo si tratta?
I.K.: Avevo dieci anni quando scrissi la prima poesia. Quel giorno semplicemente “mi sono espressa” diversamente. La poesia era dentro di me. Mio papà faceva il medico ma era un amante della letteratura ed è stato lui a svegliare e coltivare in me la passione per la scrittura. Si trattava di una poesia dedicata ai bambini felici, come noi pensavamo di essere.
 L.S.: Quando iniziasti a scrivere poesie e poi a pubblicarle, nel tuo paese natale, come vennero accolte?
L.S.: Quando iniziasti a scrivere poesie e poi a pubblicarle, nel tuo paese natale, come vennero accolte?
I.K.: Le prime poesie vennero pubblicate sulla rivista “Pionieri” e ciò era già considerato un successo. Negli anni dell’adolescenza e dell’università iniziai a scrivere i testi musicali che vennero poi accolti molto bene: premiati dalla critica, ma soprattutto dalle persone semplici che tuttora conoscono a memoria tutti i miei versi, forse anche meglio di me.
L.S.: Quali sono i poeti della tradizione classica che preferisci? Perché?
I.K.: Sono cresciuta con i poeti russi: Aleksander Puskin, Sergej Esenin, Vladimir Majakovskij e altri come Adam Mickiewicz, Heinrich Heine, Mihai Eminiescu. Li ho adorati. Anche adesso mi vengono in mente i loro componimenti. I poeti letti durante l’adolescenza non si dimenticano mai perché sono legati a quel periodo in cui la vita ti sembra magica e piena di infinite possibilità. Ammiro anche le poesie di Pablo Neruda, Nazim Hikmet, Raymond Carver e Herman Hesse perché rispecchiamo il mio stato d’animo e quella malinconia che m’insegue.
L.S.: Come consideri lo stato della letteratura e della poesia albanese contemporanea? Vi sono intellettuali di spicco? Parlaci di alcuni poeti e scrittori del tuo paese che hai letto e/o conosciuto.
I.K.: La letteratura di oggi è un vero caos. Ci sono migliaia di persone che scrivono, non esiste la critica professionale e tutti si credono scrittori e poeti; questa forma è divenuta una specie di nebbia che spesso copre il valore delle opere qualitative. Le opere di Ismail Kadare, Dritero Agolli, Fatos Arapi, Fatos Kongoli sono tradotte anche in altre lingue e rimangono all’apice della classifica.
L.S.: Sei in contatto, qui in Italia, con poeti albanesi che continuano a vivere lì?
I.K.: No. Ci sono dei poeti che conosco di nome che mi contattano per avere più che altro informazioni riguardo la pubblicazione di un loro libro in italiano, ma … niente di più.

L.S.: Alcuni poeti stranieri che sono emigrati in Italia hanno deciso di continuare a esprimersi solo nella propria lingua d’origine e scrivono e pubblicano nel loro idioma, non sentendo necessità di essere tradotti in italiano. Che cosa ne pensi di questa cosa?
I.K.: Scrivono solo in madrelingua perché si sentono più sicuri. Ma spesso non hanno altra scelta: non è facile tradurre le proprie opere in italiano o trovare qualcuno che lo può fare per te; tutto ciò ha un costo.
L.S.: Per quali ragioni, invece, tu hai deciso di pubblicare anche in italiano?
I.K.: Scrivere solo in madrelingua per me era un’esistenza a metà. Non mi sentivo integra. Avevo una marea di sensazioni e di sentimenti da condividere con la gente del paese che mi ha ospitato.
L.S.: Nel caso delle poesie che compongono l’ultimo libro “Senza patria” (Kimerik, 2016) queste sono nate direttamente in italiano o prima in albanese e le hai tradotte?
I.K.: Le bozze delle poesie nascono sempre in lingua albanese. Più volte mi capita di pubblicare per primo il libro in italiano. È successo così anche con la raccolta di poesie Senza patria. Ho tradotto le bozze preliminari in italiano e poi ho iniziato a elaborare le poesie. Il libro in albanese è stato pubblicato nel corso di quest’anno. Ho dovuto tradurlo dall’italiano perché le poesie erano ormai realizzate. Un po’ complicato, no?
L.S.: Ti avvali di traduttori professionisti oppure preferisci, pur con qualche aiuto e supporto, dedicarti tu alla traduzione delle tue poesie?
I.K.: Non ho trovato nessuno che mi potesse aiutare con la traduzione del primo libro, Tra le due rive. Sono stata obbligata a farlo da sola. Continuo a tradurre le mie opere; ora ho più dimestichezza con la lingua e non mi sembra così difficile come nei primi anni.
L.S.: Che cosa rappresenta per te la poesia?
I.K.: Voglio citare il poeta e il filosofo libanese Khalil Gibran: “La poesia è il salvagente/cui mi aggrappo/ quando tutto sembra svanire”. Ed è così anche per me.
L.S.: Quando, invece, ricorri alla narrativa?
I.K.: La narrativa è un’esigenza che sorge quando la poesia non basta.
L.S.: Se dovessi descrivere l’Albania con tre parole quali useresti?
I.K.: L’Albania è ostaggio dei politici senza scrupoli e di un popolo inerme che guarda come spettatore lo spettacolo vergognoso di interessi e avidità che si ripete continuamente.
L.S.: E l’Italia, invece?
I.K.: L’Italia, paese di rara bellezza, ha bisogno di una classe politica onesta e di persone che lo amino di più.
Bergamo, 3 Settembre 2017
Questa intervista è stata precedentemente pubblicata sulla rivista di letteratura “Euterpe”, n° 25, Novembre 2017.
La riproduzione del presente testo, in forma di stralcio o integrale, non è consentita in qualsiasi forma senza il consenso scritto da parte dell’autore.


 Vincenzo Monfregola, da poeta e narratore, in tale pubblicazione si mostra anche quale analista di una società in sfacelo, come un reporter che denuncia le difficoltà, gli stati di miseria: la sua voce – pur rivestita da quel suo tono pacato e gentile che sembra percepirsi nella lettura, per chi lo conosce – contiene messaggi assai taglienti atti a denunciare l’inclemenza e l’offesa di vedersi cittadino di una terra che non esiste se non pensata come proprietà dei potenti. Così, con il monito di ribellione che nasce internamente e che prende man mano forma con la formazione scolastica “guard[a] [verso] un mondo che finge di evolversi” (24) eppure, nell’insalubrità dello spazio affossato dai drammi atavici ai quali nessuno sembra particolarmente interessato a porre sano rimedio, intravede luce e speranza proprio nella potenzialità della parola che comunica, fa riflettere, interpella, indaga e confida: “Nessun attimo/ viene vissuto/ più d’una volta sola,/ eppure la gente/ non si accorge/ che la poesia rinasce sempre” (25).
Vincenzo Monfregola, da poeta e narratore, in tale pubblicazione si mostra anche quale analista di una società in sfacelo, come un reporter che denuncia le difficoltà, gli stati di miseria: la sua voce – pur rivestita da quel suo tono pacato e gentile che sembra percepirsi nella lettura, per chi lo conosce – contiene messaggi assai taglienti atti a denunciare l’inclemenza e l’offesa di vedersi cittadino di una terra che non esiste se non pensata come proprietà dei potenti. Così, con il monito di ribellione che nasce internamente e che prende man mano forma con la formazione scolastica “guard[a] [verso] un mondo che finge di evolversi” (24) eppure, nell’insalubrità dello spazio affossato dai drammi atavici ai quali nessuno sembra particolarmente interessato a porre sano rimedio, intravede luce e speranza proprio nella potenzialità della parola che comunica, fa riflettere, interpella, indaga e confida: “Nessun attimo/ viene vissuto/ più d’una volta sola,/ eppure la gente/ non si accorge/ che la poesia rinasce sempre” (25).


 Neria De Giovanni
Neria De Giovanni Cinzia Demi
Cinzia Demi Roma, 2030. Nicola Balestrieri è un impiegato dell’Agenzia per il Controllo del Cittadino Europeo, ente nato a seguito della creazione di uno Stato Unito d’Europa per mettere in pratica le sue nuove leggi. Il turnover generazionale è favorito dalla “morte statale”, un processo obbligatorio che pensiona in anticipo i lavoratori costringendoli a morire una volta compiuti 70 anni. Chi non rispetta il patto viene considerato un emarginato e ricercato per essere ucciso. La Nuova Europa è anche lotta contro lo straniero: le frontiere chiuse si spostano in mare per bloccare i migranti e i musulmani europei rischiano di ripercorrere il destino degli ebrei della Seconda Guerra Mondiale. Col passare del tempo, Nicola si rende conto di essere dalla parte sbagliata della storia: costretto ad accompagnare alla morte suo padre e a vivere i primi rastrellamenti, deve decidere se difendere i diritti dei cittadini o essere un servitore dello Stato.
Roma, 2030. Nicola Balestrieri è un impiegato dell’Agenzia per il Controllo del Cittadino Europeo, ente nato a seguito della creazione di uno Stato Unito d’Europa per mettere in pratica le sue nuove leggi. Il turnover generazionale è favorito dalla “morte statale”, un processo obbligatorio che pensiona in anticipo i lavoratori costringendoli a morire una volta compiuti 70 anni. Chi non rispetta il patto viene considerato un emarginato e ricercato per essere ucciso. La Nuova Europa è anche lotta contro lo straniero: le frontiere chiuse si spostano in mare per bloccare i migranti e i musulmani europei rischiano di ripercorrere il destino degli ebrei della Seconda Guerra Mondiale. Col passare del tempo, Nicola si rende conto di essere dalla parte sbagliata della storia: costretto ad accompagnare alla morte suo padre e a vivere i primi rastrellamenti, deve decidere se difendere i diritti dei cittadini o essere un servitore dello Stato.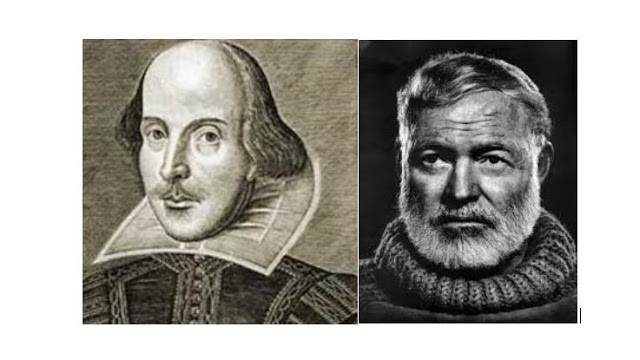

 Don Giuseppe Diana nasce il 4 luglio del 1958 a Casal di Principe (NA). Nel 1968 si licenzia in Teologia Biblica nel Seminario di Aversa e si laurea in Filosofia all’Università Federico II di Napoli. Nel 1978 entra nell’Agesci divenendo capo scout di Aversa, e nel 1982 prende i voti da sacerdote. Insegna Letteratura presso il Seminario Francesco Caracciolo, Religione Cattolica presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Volta” e all’Istituto Professionale Alberghiero di Aversa. Il 19 marzo 1994, nel giorno del suo compleanno, muore a Casal di Principe in un attentato di matrice mafiosa, per opera di Giuseppe Quadrano che gli sparò vari colpi in faccia, aiutato da Mario Santoro e Francesco Piacenti, sotto la commissione della famiglia camorristica dei De Falco, i quali per scagionarsi dall’omicidio cercarono di far cadere la colpa sulla famiglia camorristica degli Schiavone. La lotta che Don Giuseppe Diana condusse contro la Mafia, gli fece conquistare la medaglia d’oro al valore civile. Pur essendo lucidamente cosciente dei pericoli che correva, non rinunciava a esporsi pubblicamente contro la camorra, fino a cadere in un brutale omicidio nella sacrestia, mentre si preparava per celebrare la Messa.
Don Giuseppe Diana nasce il 4 luglio del 1958 a Casal di Principe (NA). Nel 1968 si licenzia in Teologia Biblica nel Seminario di Aversa e si laurea in Filosofia all’Università Federico II di Napoli. Nel 1978 entra nell’Agesci divenendo capo scout di Aversa, e nel 1982 prende i voti da sacerdote. Insegna Letteratura presso il Seminario Francesco Caracciolo, Religione Cattolica presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Volta” e all’Istituto Professionale Alberghiero di Aversa. Il 19 marzo 1994, nel giorno del suo compleanno, muore a Casal di Principe in un attentato di matrice mafiosa, per opera di Giuseppe Quadrano che gli sparò vari colpi in faccia, aiutato da Mario Santoro e Francesco Piacenti, sotto la commissione della famiglia camorristica dei De Falco, i quali per scagionarsi dall’omicidio cercarono di far cadere la colpa sulla famiglia camorristica degli Schiavone. La lotta che Don Giuseppe Diana condusse contro la Mafia, gli fece conquistare la medaglia d’oro al valore civile. Pur essendo lucidamente cosciente dei pericoli che correva, non rinunciava a esporsi pubblicamente contro la camorra, fino a cadere in un brutale omicidio nella sacrestia, mentre si preparava per celebrare la Messa.



 L.S.: Restando nella componente figurativa delle opere quali sono i soggetti principali?
L.S.: Restando nella componente figurativa delle opere quali sono i soggetti principali? Come gli orologi che si squagliano nella bottega ci sono anche altre opere curiose come è il caso di quella intitolata “Noi stessi” che Leonardo mi consiglia su come è possibile vederla e concepirla. Opera unica che racchiude una triade di dimensioni: donna, uomo e bambino. Della donna il seno prominente, accentuato (un unico seno), dell’uomo, il muscolo ben tirato del petto, del bambino lo sguardo pacioso e ridanciano, quasi. Opera anfibia e in sé assai compatta che consacra l’esistenza dell’uomo nelle sue varie forme: dalla genitrice, al pater familias, all’infante. Ciclo di vita e rinascita che Leonardo Longhi sintetizza in un’opera di indubbia presa ed efficacia. Leonardo si dice d’accordo con me quando gli parlo di “sentimento di universalità” provato dinanzi a un’opera così complessa e onnicomprensiva nella quale il contenuto si fa contenitore e l’immagine dell’uno diventa contesto e proiezione dell’altro.
Come gli orologi che si squagliano nella bottega ci sono anche altre opere curiose come è il caso di quella intitolata “Noi stessi” che Leonardo mi consiglia su come è possibile vederla e concepirla. Opera unica che racchiude una triade di dimensioni: donna, uomo e bambino. Della donna il seno prominente, accentuato (un unico seno), dell’uomo, il muscolo ben tirato del petto, del bambino lo sguardo pacioso e ridanciano, quasi. Opera anfibia e in sé assai compatta che consacra l’esistenza dell’uomo nelle sue varie forme: dalla genitrice, al pater familias, all’infante. Ciclo di vita e rinascita che Leonardo Longhi sintetizza in un’opera di indubbia presa ed efficacia. Leonardo si dice d’accordo con me quando gli parlo di “sentimento di universalità” provato dinanzi a un’opera così complessa e onnicomprensiva nella quale il contenuto si fa contenitore e l’immagine dell’uno diventa contesto e proiezione dell’altro.
 Un altro tema di vitale importanza è quello dell’omicidio, che simboleggia il caos, da Betti raffigurato come un organismo logicamente e linguisticamente inspiegabile. Tragedia e allo stesso tempo non tragedia, ma più precisamente, dramma. Un dramma privo di impavidi, in grado di mutare il destino oscuro degli Uomini. Seppur l’impavido esiste nel teatro bettiano, è un personaggio che non ha coraggio, persuasione, né gloria, ma solo una forte esigenza di compassione e benignità. Altri tema del suo teatro sono quelli della sconfitta o caduta della legalità, della verginità, della libertà/pace e della compassione. In questa sconfitta, o caduta che a dir si voglia, l’uomo conosce se stesso e incontra Dio. Da questo incontro si abbevera di commiserazione.
Un altro tema di vitale importanza è quello dell’omicidio, che simboleggia il caos, da Betti raffigurato come un organismo logicamente e linguisticamente inspiegabile. Tragedia e allo stesso tempo non tragedia, ma più precisamente, dramma. Un dramma privo di impavidi, in grado di mutare il destino oscuro degli Uomini. Seppur l’impavido esiste nel teatro bettiano, è un personaggio che non ha coraggio, persuasione, né gloria, ma solo una forte esigenza di compassione e benignità. Altri tema del suo teatro sono quelli della sconfitta o caduta della legalità, della verginità, della libertà/pace e della compassione. In questa sconfitta, o caduta che a dir si voglia, l’uomo conosce se stesso e incontra Dio. Da questo incontro si abbevera di commiserazione.