Buonanotte […]
alla voce che cercava di dirmi
addio mentre gli occhi
ripetevano rimani, premi le dita
sulla pelle ancora.
Ricevo con particolare piacere Breve inventario di un’assenza (Samuele Editore, 2017), il nuovo lavoro poetico di Michele Paoletti, autore che considero uno dei poeti più validi e interessanti del nostro panorama poetico odierno. Lo dico con onestà intellettuale e con cognizione di causa avendo seguito sino a oggi il suo percorso letterario snodatosi attraverso varie pubblicazioni che ho avuto modo di leggere e commentare e premi di prestigio (come “L’Astrolabio” di Pisa) che gli sono stati attribuiti. Parimenti non vi sono intenti di subdola piaggeria o di viziato compiacimento non avendo ancora mai avuto l’occasione di conoscere di persona l’autore e volendo il mio discorso riferirsi alla sua sola opera poetica, alla sua grande capacità immedesimativa che riesce a far figurare nelle menti di chi si appropria della sua opera.
Vorrei ricordare, allora, in questo breve ma – credo – utile excursus il percorso poetico dell’autore piombinese che ha esordito con l’opera, dal titolo di per sé istrionico e non ben decodificabile a una prima vista, Come fosse giovedì (puntoacapo, 2015) della quale avevo commentato rilevando la “meticolosa tecnica sintetica [atta a] provvede[re] a una disanima curiosa e singolare del mondo di fuori”. Il prefatore al testo, l’insigne Mauro Ferrari, aveva giustamente notato l’importanza del mondo teatrale, con le sue luci e ombre; la poesia di Paoletti ha – sempre e comunque – una pacata nota di drammaturgia: di vita in quanto tale ma anche quale trasposizione scenica, rappresentazione, mistificazione di un vissuto in quanto l’atto scrittorio non è mai in grado di uguagliare l’esistenza (per leggere la mia recensione a questo volume è possibile cliccare qui). A pochi mesi di distanza da Come fosse giovedì l’autore ha pubblicato La luce dell’inganno (puntoacapo, 2015) opera facente parte di un progetto visivo elaborato e molto apprezzato per mezzo dell’accostamento alle sue poesie di fotografie di Andrea Cesarini, così efficaci nel cogliere gli “attimi” impressi nei versi. La nota critica d’apertura, questa volta affidata alla sagace penna di una poetessa d’alto calibro, la pesarese Lella De Marchi (autrice di Stati d’amnesia, 2013 e Paesaggio con ossa, 2017), ci informa in merito alla ‘linearità’ da lei scovata nella poesia di Paoletti parlando anche di “una possibile liberazione-redenzione” che iscrive a piè pari la poesia del Nostro all’interno di un filone – se questo effettivamente esiste o può essere identificato – personale, intimo, sottaciuto, della sfera emotiva che fa i conti con le proprie riflessioni, di un sentimento ripiegato e analizzato, col quale colloquia nelle vaste stanze dell’interiorità. Una poesia personale, che raramente travalica intendimenti di carattere etico-civili intenti a condannare realtà fastidiose, a denunciare la propria appartenenza ideologica, difendere minoranze e metter fine a qualsiasi tipo di minoranza ed emarginazione. Una poesia intima eppure condivisa, plurale, aperta alle intricate potenzialità del sentimento che è di tutti e dunque non meno condivisibile, propria e universale imperniata sui toni del dolore, del tormento, dello struggimento ma anche del sano utilizzo della coscienza che spesso duella con i fantasmi del passato riuscendo a giungere a tregue, più o meno stabili.

Se in Come fosse giovedì l’autore aveva parlato del “mio ottuso male” e della solitudine nei termini di un “freddo di ceramica sbeccata/ ramo conficcato controvento”, in La luce dell’inganno – nel cui titolo si percepisce un amalgama di rimorso e amara scoperta – non aveva eluso, ancora, di riferirsi a un’angoscia di fondo ben delineata nel verso “la muffa del mio male”. La muffa, per sua natura, è la produzione di materiale in forma di spore, polvere e filamenti, su un materiale organico, alimentare o meno, che si è rovinato a causa della sua non buona conservazione o per il fatto che, nelle circostanze ambientali nelle quali viene a trovarsi, si degrada fermentando. Sostenere che il male abbia la muffa significa poter avere la volontà di alludere a un tormento che continua, degenera, si sviluppa nel tempo causando il decadimento, la denutrizione, il marciume dello stesso sino a decretarne lo stato di morte. Nella recensione a La luce dell’inganno (che si può leggere per intero cliccando qui) ho avuto modo di scrivere: “In questo percorso tra elementi che marciscono, presenze vacue e pensieri grevi, la convivenza con uno stato di desolazione interiore finisce per mostrarsi assai accentuata e le poche immagini lievi e pregne di colore qua e là nel corso dell’opera non sembrano capaci del tutto a risollevare l’amarezza di fondo”.
Arrivo al fine alla nuova opera poetica dopo queste brevi note critiche anticipatorie che non hanno da essere intese come preambolo annunciatorio che pronostica già, nei temi e nelle forme, ciò che sarà sviluppato nel terzo volume. Piuttosto può esser utile per avvicinarsi in maniera più fedele e illuminata alla sua opera poetica permettendo al lettore di trarre da sé – laddove sia possibile e nel caso i pochi elementi forniti lo consentano – le increspature più caratterizzanti che rendono la poetica di Paoletti tale per com’è e la conosciamo.
 Il Breve inventario di un’assenza (Samuele Editore, 2018) che poi così breve non è (sessantasei pagine di lunghezza che, per una silloge poetica, sono senz’altro buone e rispettabilissime!) è breve nella forma (sono liriche che, tranne pochissimi casi, non superano i dodici versi) e in quel dire doloroso che ha la forma di un commiato che si è compiuto nell’intensità di un istante breve. L’autore ha scritto queste liriche in memoria della figura paterna recentemente scomparsa che, oltre a lasciare una debordante assenza, ha reso edotto il figlio del carico emotivo degli oggetti. Così la camicia lasciata appesa, le scarpe, la manica scucita di una giacca, sono i segni evidenti di una vita che s’è compiuta e che, pur circondata dall’opprimente aria che non ha forma, è ancora lì presente, circolante negli angoli della casa, così come è onnipresente nella mente e nel cuore di chi la porta con sé. L’assenza, dunque, è catalogata (inventariata, per l’appunto) mediante i tratti del mondo fisico, gli utensili, gli oggetti d’accompagnamento che definivano l’attore dell’assenza che, fuggendo per sempre, li ha però lasciati lì nel suo luogo ancestrale. La prefatrice Gabriela Fantato, in riferimento a questa operazione di raccolta e repertazione degli oggetti operata da Paoletti, parla di “alfabeto della perdita”. In effetti pare di comprendere che l’amplificazione dolorosa si crea nell’io lirico dinanzi all’evidenza di quel mondo fisso e ormai insignificante, dominato da quegli emblemi, simboli e feticci che ormai hanno perso rapporti di appartenenza e usi pratici per divenire mere entità residuali.
Il Breve inventario di un’assenza (Samuele Editore, 2018) che poi così breve non è (sessantasei pagine di lunghezza che, per una silloge poetica, sono senz’altro buone e rispettabilissime!) è breve nella forma (sono liriche che, tranne pochissimi casi, non superano i dodici versi) e in quel dire doloroso che ha la forma di un commiato che si è compiuto nell’intensità di un istante breve. L’autore ha scritto queste liriche in memoria della figura paterna recentemente scomparsa che, oltre a lasciare una debordante assenza, ha reso edotto il figlio del carico emotivo degli oggetti. Così la camicia lasciata appesa, le scarpe, la manica scucita di una giacca, sono i segni evidenti di una vita che s’è compiuta e che, pur circondata dall’opprimente aria che non ha forma, è ancora lì presente, circolante negli angoli della casa, così come è onnipresente nella mente e nel cuore di chi la porta con sé. L’assenza, dunque, è catalogata (inventariata, per l’appunto) mediante i tratti del mondo fisico, gli utensili, gli oggetti d’accompagnamento che definivano l’attore dell’assenza che, fuggendo per sempre, li ha però lasciati lì nel suo luogo ancestrale. La prefatrice Gabriela Fantato, in riferimento a questa operazione di raccolta e repertazione degli oggetti operata da Paoletti, parla di “alfabeto della perdita”. In effetti pare di comprendere che l’amplificazione dolorosa si crea nell’io lirico dinanzi all’evidenza di quel mondo fisso e ormai insignificante, dominato da quegli emblemi, simboli e feticci che ormai hanno perso rapporti di appartenenza e usi pratici per divenire mere entità residuali.
Alcuni brevi versi della poetessa romana Amelia Rosselli fanno da puntuale apripista al percorso poetico che Paoletti ci propone di fare seguendo le varie composizioni che compongono il volume. La Rosselli, una delle maggiori voci poetiche del Secolo scorso, parla di “Un dolore nella stanza/ [che] è superato in parte: ma vince il peso/ degli oggetti, il loro significare/ peso e perdita”. Ritorna la correlazione di difficile sperimentazione e impossibile fuga tra oggetti e assenza dove quest’ultima è immagine e sinonimo di dolore. In termini aritmetici potremmo allora dire che la somma dei pesi dei vari oggetti lasciati che abbiano una qualche traccia di ricordo o di legame affettivo equivale al peso dell’assenza. L’assenza è chiaramente una lontananza, ma anche uno stato apparentemente irreale di sospensione, di progressiva ampiezza di un varco la cui attraversata è patentemente impossibile.
Nella casa-santuario dove gli oggetti-icone divengono emblemi di ricordo irrinunciabili, strumenti di connessione con un’entità altra e blando motivo di persuasione che sì, i bei momenti ci sono stati eccome!, il pensiero s’erge dal canto desolato di un uomo che di colpo nel mare più ampio ha perso la sua ancora al desiderio di un ritorno, pure se non materiale: “Tornerà il vento a scompigliare/ le cicale”; “Torneranno le giornate lunghe”: il sollievo può forse derivare non dalla pervasiva e dolente tribolazione nella venerazione degli oggetti, piuttosto in un tentativo ideale di fuga da quello spazio che ha addosso i segni del tempo. L’anelito al ritorno, infatti, non è tanto espresso nei termini di un ritorno del corpo del padre, vicenda impossibile nella realtà della cui impossibilità l’autore è ben conscio, quanto delle condizioni esogene (il tempo, la ritualità delle stagioni, le abitudini) ed endogene (il ritrovamento di una pace e una felicità interiori) nell’uomo. Pur flebili vi sono squarci d’apertura all’asfissia delle giornate improntate alla considerazione della desolante situazione d’assenza come il pensiero che è in grado di evocare la possibilità di una primavera esistenziale, dettata da necessità di andare avanti e resilienza: “Domani il rumore quotidiano/ spingerà la vita un po’ più avanti”.
Oggetti-simulacro quelli che “ci stanno intorno”, in sé addirittura malevoli, perché duplici nella loro forma: appartenenti a un’età felice e rassicurante quando l’unità era ingrediente delle giornate e ora, entità prive del suo possessore, in balia di se stessi, innocui e addirittura inutili ma capaci di incutere soggezione e dolore in chi, rimasto, non può non concepirli disgiunti da chi ne faceva uso e ne caratterizzava le giornate. Oggetti che, in quanto tali, non hanno un’anima e non avrebbero nulla di buono o di non buono ma che, rivestiti dei significati personali e intimi di chi li ha sperimentati, fungono da imprecisati avanzi ma anche da resti memoriali. Difatti per il Nostro essi risultano nulli per la loro funzionalità (la camicia da indossare, etc.) e divengono emblema di una traccia di passato: “ascolto gli oggetti respirare da lontano/ l’aria che muovono i ricordi/ quando si staccano da noi”.

Quell’inventario che è difficile da eseguire e che mai, forse, verrà veramente portato a compimento non essendo possibile catalogare le emozioni, situarle in cartelline, organizzarle in faldoni e tenerle lì belle precise, è esso stesso ragione e motivo di quel “nodo sottile di dolore” che annebbia la ragione, inquieta l’animo e non fa altro che produrre il caotico “sbilancio dei giorni/ che spesso si confondono”.
C’è poi la sezione del libro intitolata “Muri”, quelle pareti divisorie delle stanze della casa-culla che “hanno la pazienza/ grigia delle cose,/ raccolgono la nostra polvere/ che si disperde in fretta”. Muri che, come silenti protagonisti delle nostre case, assistono alle vicende in esse sviluppatesi, ai dialoghi, ai momenti di gioia, depressione e dolore, quali custodi autentici di un vissuto intimo che nella casa si esplicita e lì rimane. Sostegni averbali, curiosi protettori di intere esistenze che ha visto nascere, crescere, maturare per poi sfiorire e perdere la vita. Presenze continue e rassicuranti, sodali nel pianto e nella lotta con noi stessi, eppure così riservati e taciturni da non aiutare a risolvere i drammi, ma neppure a ostacolare il felice svolgimento dei giorni gaudiosi. Essi, nell’età in cui Paoletti ce li descrive, sono sintomo di passato, di un’età che tutto ha visto passare serbandone il ricordo sulla quale sembra calare una cortina di dubbio, di polverosa reticenza: “I muri/ gettano un’ombra sulle cose/ rendendole più dure”. Muri che sembrano stringersi su se stessi, ridurre spaventosamente la superficie calpestabile delle stanze, come se l’io lirico si sentisse progressivamente privato d’aria da respirare, quasi strozzato, ammorbato, rinchiuso e impossibilitato a muoversi, finanche a far utilizzo della ragione. Muri che ingabbiano i ricordi, polvere che ammanta gli oggetti, aria che si fa pesante, dolore che si fa estremo e cronico in quegli spazi una volta animati e vissuti da esistenze ora non più qui: “I muri affondano radici di cemento,/ si abbarbicano al resto delle cose”.
Tutto ciò accade mentre il pensiero sull’assenza del padre s’irrobustisce nella mente del Nostro da diventare un dilemma insondabile, un rovello che fiacca e fa star male tanto da condurlo a divagazioni atipiche e in sé surreali come quando dice “perdo/ tempo a indovinare la forma/ delle stelle”; altre volte la cappa di stordimento è meno accentuata e allora è in tali frangenti che, savio del tempo che gli è dato di vivere, riflette sul ciclo rituale di vita e morte: “il mondo vive/ nelle foglie mute, nel ricordo/ della terra intatta”. I muri, prima vetusti e freddi, stringenti e quasi fastidiosi, capaci solo di ottenebrare la mente e ostacolare la calma riflessione, divengono – nel ricordo mai domo della cara figura paterna – una sorta di propaggine tesa per trasmettere forza e amore: “lascio che il calore del muro/ si imprima sulla schiena/ prima di allacciare/ l’ultimo bottone del colletto”.
Jesi, 14-02-2018
La riproduzione del presente testo, in forma di stralcio o integrale, non è consentita in qualsiasi forma senza il consenso scritto da parte dell’autore.

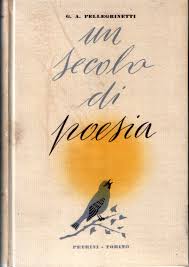

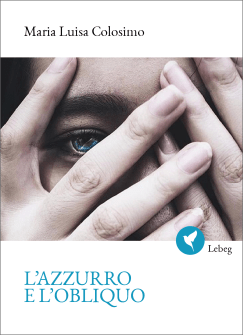 Titolo di per sé ambiguo e che apre alle possibilità, a una fertile evocazione, questo dell’opera poetica di Maria Luisa Colosimo, L’azzurro e l’obliquo (Lebeg, Roma, 2017). Il volume, che si apre con una perspicace ed esaustiva nota critica firmata da Giovanni Perrino, si mostra formato da due comparti in sé ben definiti: un poemetto iniziale che copre svariate pagine, una sorta di dialogo con sé stessa, e poi una serie di liriche dalla fattura per lo più affine, numerate in senso progressivo da numeri romani, delle quali si apprezza, invece, la brevità dei contenuti espressi.
Titolo di per sé ambiguo e che apre alle possibilità, a una fertile evocazione, questo dell’opera poetica di Maria Luisa Colosimo, L’azzurro e l’obliquo (Lebeg, Roma, 2017). Il volume, che si apre con una perspicace ed esaustiva nota critica firmata da Giovanni Perrino, si mostra formato da due comparti in sé ben definiti: un poemetto iniziale che copre svariate pagine, una sorta di dialogo con sé stessa, e poi una serie di liriche dalla fattura per lo più affine, numerate in senso progressivo da numeri romani, delle quali si apprezza, invece, la brevità dei contenuti espressi.

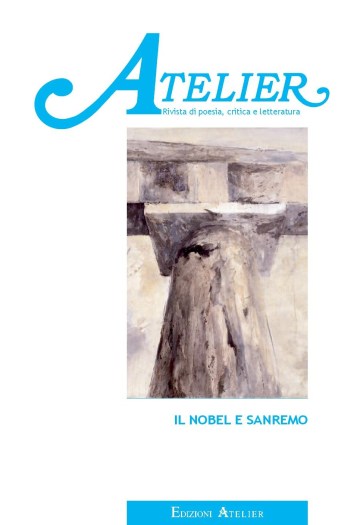


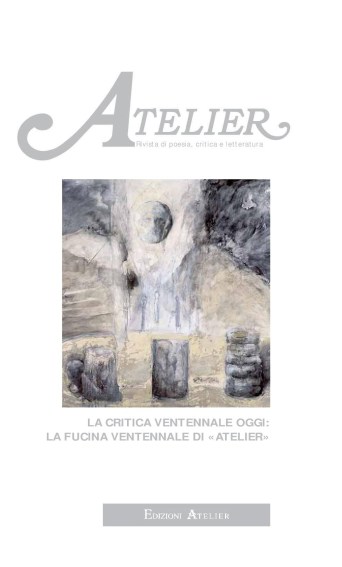

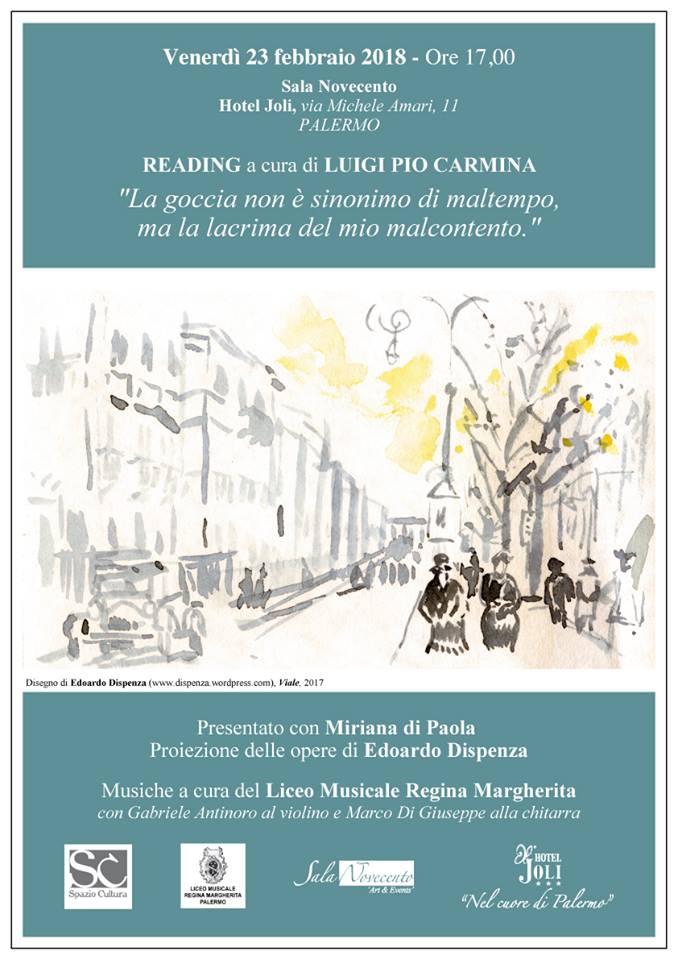
 Palermo, barocca e misera, potente e asservita ha storie da raccontare, di gente nota, i Ramacca, gli Agliata e di tanti di cui affiorano solo scarse testimonianze, come Lucia Salvo. La quotidianità che scorre monotona non ha fascino per chi compone un racconto, perciò la scrittrice ricerca quello che va al di là dell’apparenza, che sfiora il mistero del non detto e dell’inconsapevolezza, come il fatto che segna la vita di Lucia o la mutilazione che rende il castrato signorino Angelo, forse. Ma controvoglia. Sono due creature che contro il buon senso del tempo non reputano una fortuna essere spettatori delle ricchezze e degli eccessi dei nobili, ma le considerano semplicemente una dannazione e una complicazione dell’anima. Questa convinzione porta Lucia a respingere l’assalto amoroso del Conte figlio con un morso da furetto. Da qui il titolo del romanzo e la citazione in epigrafe da Giorno dopo giorno di S. Quasimodo in cui ricorre la parola morso. Nel romanzo Lucia morde per difesa, nella poesia il morso è inferto dal dolore, dalla violenza, dalla guerra. Ma identica è la separazione netta tra chi opprime e chi è oppresso, tra chi è nato per servire e chi deve essere servito. A servire è destinata Lucia Salvo, ma il fatto la rende intimamente libera, è la creatura più libera che io conosca, dice il conte figlio. La storia si svolge alla vigilia della rivoluzione siciliana del 1848 a Palermo, un’epoca che stava cambiando e che nessuno prendeva sul serio… Non la nobiltà, rammollita dalle decime e senza occhio analitico. Non la borghesia nascente, figlia povera della nobiltà stessa e già incline a imitarne tutti i vizi. Il popolo sì che, invece, fremeva. Di fame, di peste, di pidocchi e ansie. Nel groviglio dei fatti personali e politici che s’intrecciano e sfociano nella rivoluzione del 12 gennaio 1848 a Palermo viene inconsapevolmente coinvolta Lucia, che vi scoprirà per brevi istanti l’amore per lo sconosciuto prigioniero dagli occhi verdi, che la spinge a un generoso gesto di coraggio. Ma l’amore è un breve lampo e il suo destino di babba, pazza, non può che compiersi. A metà dell’Ottocento in Sicilia le donne di qualunque condizione sociale non riescono a sfuggire al loro destino di succube del mondo maschile. Neanche la giovane Assunta degli Agliata vi riesce.
Palermo, barocca e misera, potente e asservita ha storie da raccontare, di gente nota, i Ramacca, gli Agliata e di tanti di cui affiorano solo scarse testimonianze, come Lucia Salvo. La quotidianità che scorre monotona non ha fascino per chi compone un racconto, perciò la scrittrice ricerca quello che va al di là dell’apparenza, che sfiora il mistero del non detto e dell’inconsapevolezza, come il fatto che segna la vita di Lucia o la mutilazione che rende il castrato signorino Angelo, forse. Ma controvoglia. Sono due creature che contro il buon senso del tempo non reputano una fortuna essere spettatori delle ricchezze e degli eccessi dei nobili, ma le considerano semplicemente una dannazione e una complicazione dell’anima. Questa convinzione porta Lucia a respingere l’assalto amoroso del Conte figlio con un morso da furetto. Da qui il titolo del romanzo e la citazione in epigrafe da Giorno dopo giorno di S. Quasimodo in cui ricorre la parola morso. Nel romanzo Lucia morde per difesa, nella poesia il morso è inferto dal dolore, dalla violenza, dalla guerra. Ma identica è la separazione netta tra chi opprime e chi è oppresso, tra chi è nato per servire e chi deve essere servito. A servire è destinata Lucia Salvo, ma il fatto la rende intimamente libera, è la creatura più libera che io conosca, dice il conte figlio. La storia si svolge alla vigilia della rivoluzione siciliana del 1848 a Palermo, un’epoca che stava cambiando e che nessuno prendeva sul serio… Non la nobiltà, rammollita dalle decime e senza occhio analitico. Non la borghesia nascente, figlia povera della nobiltà stessa e già incline a imitarne tutti i vizi. Il popolo sì che, invece, fremeva. Di fame, di peste, di pidocchi e ansie. Nel groviglio dei fatti personali e politici che s’intrecciano e sfociano nella rivoluzione del 12 gennaio 1848 a Palermo viene inconsapevolmente coinvolta Lucia, che vi scoprirà per brevi istanti l’amore per lo sconosciuto prigioniero dagli occhi verdi, che la spinge a un generoso gesto di coraggio. Ma l’amore è un breve lampo e il suo destino di babba, pazza, non può che compiersi. A metà dell’Ottocento in Sicilia le donne di qualunque condizione sociale non riescono a sfuggire al loro destino di succube del mondo maschile. Neanche la giovane Assunta degli Agliata vi riesce. 

 Adua Biagioli Spadi, pittrice, Maestra d’arte e Operatrice Culturale opera a Pistoia. È presente in numerose pubblicazioni antologiche di premi letterari nazionali e internazionali, tra cui Ambrosia, presentata a EXPO’ 2015 – Milano e Novecento e non più. Verso il Realismo Terminale presentata alla Fiera di Roma 2016, in Agende Poetiche. Socia di diverse accademie letterarie, a Giugno 2015 ha pubblicato la sua opera prima: L’Alba dei papaveri” – Poesie d’amore e identità, vincitrice del 2° Premio Letterario Giovane Holden 2016 per la sezione poesia edita. Interessanti recensioni sul libro si trovano su riviste letterarie “La Nuova Tribuna Letteraria” e “Qui Libri”. A Maggio 2017 ha pubblicato il libro Farfalle, un piccolo libro d’Arte a tiratura contenuta di pezzi unici contenenti unica poesia e disegni dell’autrice. Da Luglio 2017 lo stralcio di una poesia tratta da “L’Alba dei papaveri” viene scolpito su stele in pietra serena e ubicato in località San Pellegrino di Sambuca Pistoiese per la valorizzazione della cultura e della montagna (Progetto culturale Parole di Pietra). Il suo sito internet è
Adua Biagioli Spadi, pittrice, Maestra d’arte e Operatrice Culturale opera a Pistoia. È presente in numerose pubblicazioni antologiche di premi letterari nazionali e internazionali, tra cui Ambrosia, presentata a EXPO’ 2015 – Milano e Novecento e non più. Verso il Realismo Terminale presentata alla Fiera di Roma 2016, in Agende Poetiche. Socia di diverse accademie letterarie, a Giugno 2015 ha pubblicato la sua opera prima: L’Alba dei papaveri” – Poesie d’amore e identità, vincitrice del 2° Premio Letterario Giovane Holden 2016 per la sezione poesia edita. Interessanti recensioni sul libro si trovano su riviste letterarie “La Nuova Tribuna Letteraria” e “Qui Libri”. A Maggio 2017 ha pubblicato il libro Farfalle, un piccolo libro d’Arte a tiratura contenuta di pezzi unici contenenti unica poesia e disegni dell’autrice. Da Luglio 2017 lo stralcio di una poesia tratta da “L’Alba dei papaveri” viene scolpito su stele in pietra serena e ubicato in località San Pellegrino di Sambuca Pistoiese per la valorizzazione della cultura e della montagna (Progetto culturale Parole di Pietra). Il suo sito internet è 

 Aforismi, poesie in un continuum emotivo-razionale che mette a nudo, senza pudicizia, l’anima di Letizia Tomasino. Il titolo della raccolta, L’impudicizia dell’anima (2017), stupisce e incuriosisce il lettore, inducendolo a congetturare contenuti scandalosi, osceni, ma di fatto, se il lettore si accosta all’opera con tale curiosità, alla fine resta profondamente deluso perché di fatto l’impudicizia a cui allude la poetessa-scrittrice è soltanto l’apertura totale del cuore e della mente, la schiettezza con cui si pone di fronte a se stessa e alla realtà, ai problemi dei nostri tempi, ora esponendo il suo sentire, quale, ad esempio, l’amore per il suo uomo (“Quannu mi chiami “Amuri” io mi sentu ricca,/nu tantu di ricchizzi dila terra/quantu di sentimenti e cosi duci”; in “Beddi paroli”, p. 24) o l’amarezza del suo abbandono (“Fino a ieri ero la tua stella, il tuo sole, il tuo tutto/e adesso mi butti via come si buttano delle ciabatte” in “Bugiardo amore”, p. 8), ora, facendo le sue riflessioni su tematiche etico-morali, quali la carità, la misericordia che dovrebbero caratterizzare i nostri comportamenti, a prescindere dalle religioni praticate e dall’epoca in cui si vive, perché espressione di civiltà e umanità. Così di fronte ad alcuni eventi tipici dei nostri tempi, ma anche ricorrenti nella storia dell’umanità, quale, ad esempio, l’emigrazione, la poetessa Tomasino si rivolge all’immigrante con questi versi: “inutilmente cavalchi l’onda,/la stessa che ti ricopre/Fuggi dalla tua terra/e sei merce in mano/a gente senza scrupoli/…smarriamo memoria di avi, migranti anche loro, come voi/…” in “Migranti”, p. 34).
Aforismi, poesie in un continuum emotivo-razionale che mette a nudo, senza pudicizia, l’anima di Letizia Tomasino. Il titolo della raccolta, L’impudicizia dell’anima (2017), stupisce e incuriosisce il lettore, inducendolo a congetturare contenuti scandalosi, osceni, ma di fatto, se il lettore si accosta all’opera con tale curiosità, alla fine resta profondamente deluso perché di fatto l’impudicizia a cui allude la poetessa-scrittrice è soltanto l’apertura totale del cuore e della mente, la schiettezza con cui si pone di fronte a se stessa e alla realtà, ai problemi dei nostri tempi, ora esponendo il suo sentire, quale, ad esempio, l’amore per il suo uomo (“Quannu mi chiami “Amuri” io mi sentu ricca,/nu tantu di ricchizzi dila terra/quantu di sentimenti e cosi duci”; in “Beddi paroli”, p. 24) o l’amarezza del suo abbandono (“Fino a ieri ero la tua stella, il tuo sole, il tuo tutto/e adesso mi butti via come si buttano delle ciabatte” in “Bugiardo amore”, p. 8), ora, facendo le sue riflessioni su tematiche etico-morali, quali la carità, la misericordia che dovrebbero caratterizzare i nostri comportamenti, a prescindere dalle religioni praticate e dall’epoca in cui si vive, perché espressione di civiltà e umanità. Così di fronte ad alcuni eventi tipici dei nostri tempi, ma anche ricorrenti nella storia dell’umanità, quale, ad esempio, l’emigrazione, la poetessa Tomasino si rivolge all’immigrante con questi versi: “inutilmente cavalchi l’onda,/la stessa che ti ricopre/Fuggi dalla tua terra/e sei merce in mano/a gente senza scrupoli/…smarriamo memoria di avi, migranti anche loro, come voi/…” in “Migranti”, p. 34).