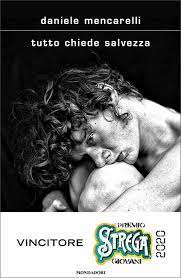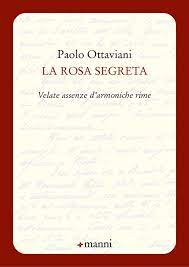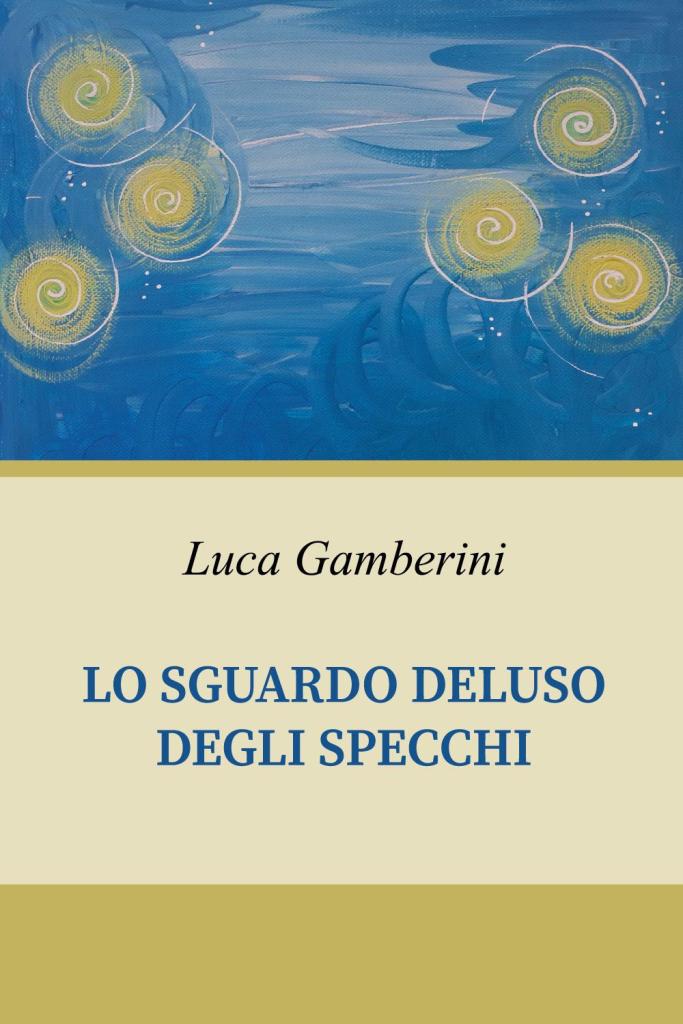Il mio amico e collega Giulio Ferroni, illustre italianista, ha certamente ragione quando parla della solitudine del critico, cui non è concessa nessuna sicurezza, ma solo un difficile sentiero tra leggere e interrogare. Nascono da questa consapevolezza le mie divagazioni, appunti di viaggio, approssimazioni, angolazioni particolari di lettura in questi orribili anni, sempre cercando autori e libri capaci di restituire la complessità del fare e scrivere di letteratura, perfino scelte narrative che mi hanno condotto a creare un mio personaggio nell’ambito del genere che mi piace definire “noir”e su cui poi mi soffermerò in chiusura delle mie divagazioni. Amo alla follia Jorge Luis Borges e il suo procedere per ampi cerchi fino a costruirsi labirinti e trappole “conoscitive”, non mi dispiacciono gli album di Simenon e i suoi reportage sul Mediterraneo(più che i suoi libri “gialli”), il piccolo bar tabacchi sul lungomare di Brindisi voluto e promosso da mia moglie Cristina è stato, in anni di segregazione e di paure oscure, il mio avamposto sul mare che non potevo percorrere se non sulle pagine dei libri o negli occhi furbi dei pescatori che venivano a vendermi pesce di dubbia provenienza. Gli appunti che seguono sono le testimonianze della affollata solitudine di un critico letterario e delle sue avventure di scrittura pubblicate nell’arco di anni che vanno dal 2018 al 2022.
Ieri sera mi sono lasciato catturare dalla tagliente ironia di Svevo e stavo rileggendo le avventure del suo “vecchione”, uno Zeno che trova nella letteratura uno strumento che idealizza la vita ,e, raccontandola, cerca di esorcizzarne la fine con un sorriso se non con una risata, dal momento che l’inconcluso celebra la sua apoteosi nello scrittore triestino ( Ettore era il suo vero nome), che amava scrivere nei caffè o nel retrobottega della libreria di Umberto Saba. Negli anni ’80 o ’90, non ricordo con precisione, mi trovavo a Bari e partecipavo, come consulente artistico, alle attività del Piccolo Teatro di Bari diretto da Eugenio D’Attoma e mi capitò di dare il mio piccolo contributo alla realizzazione di un meraviglioso testo di Arthur Schnitzler, Girotondo,che, della Vienna fin de siècle fu uno dei massimi interpreti con la grazia lieve ma graffiante delle sue “figurine. Un mondo stava finendo, ballando i valzer di Strauss, riscritti da Schonberg, la colonna sonora che il regista scelse per quello spettacolo. Da Schnitzler sono ritornato a Svevo e a Pirandello (presente nei miei studi e in tanti miei libri) e ai miei anni “anziani” che mi vedono davanti a quella “catastrofe inaudita” sulla quale si chiude La coscienza di Zeno e nel cui corso sprofonda l’isola della Nuova colonia pirandelliana. Il nostro mondo corrotto e ammalato si trova oggi davanti ad una catastrofe simile e dopo, forse, potremo ritornare a narrare un “ricominciamento” che non potrà più essere uguale a quello cui eravamo abituati. Non vorrei davvero che si avverasse la “profezia” sveviana ( “Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie”), ma, forse, è quello che tutti ci meriteremmo per aver contaminato di veleni il nostro pianeta azzurro!
Quest’anno ( il secondo, ormai della nostra vita “pestilenziale”) non avrei nessuna voglia di dare o ricevere auguri davanti alla nostra terra fresca ancora di sepolture di migliaia e migliaia di “non produttivi”, in stragrande maggioranza la nostra memoria storica, donne e uomini che hanno avuto emozioni e sentimenti, lottato e combattuto nell’illusione di rendere civile e abitabile la nostra Italia, dopo averla ripulita dall’indecenza della dittatura e di una guerra combattuta a fianco (sì, c’eravamo anche noi italiani, anche se non ci piace ricordarlo) delle orde hitleriane. . Stamattina provo difficoltà nel pensare di darmi la forza di sperare, mi sento solo di ricordarvi, davanti all’immane tragedia di un pianeta condannato dalla stoltezza e dall’avidità, due poeti, genia inutile, buona solo quando si “celebrano” i riti stucchevoli della “Cultura”. Mi vengono in mente due nomi, Jules Laforgue ( in vita pubblicò solo due raccolte di poesie tra il 1885 e il 1886) e Thomas Stearns Eliot. Laforgue è stato il primo delicato e coinvolgente creatore del Pierrot “lunaire”, che vorrebbe divenire leggendario sulla soglia d’età ciarlatane, esangue mandarino che esala dolci consigli da Crocifisso e disegna cerchi sull’acqua. Quanto ad Eliot, che amava Laforgue e ne lesse avidamente le opere a partire dalla primavera del 1909, trasformando l’appassionato e pur tenero antagonismo dandystico di Laforgue in uno spietato e freddo memoriale accusatorio contro l’immenso dolore del mondo, come non mormorare con lui, a fior di labbra, il cantico (1922) della terra desolata: “ Aprile è il più crudele di tutti i mesi. Genera lillà dalla terra morta, mescola memoria e desiderio, desta radici sopite con pioggia di primavera…Quali radici si afferrano, quali rami crescono su queste rovine di pietra? Figlio dell’uomo tu non lo puoi dire, né immaginare perché conosci soltanto un cumulo di frante immagini, là dove batte il sole. E l’albero morto non dà riparo e il canto del grillo non dà ristoro e l’arida pietra non dà suono d’acqua”.

La cultura classica, quella che stiamo stupidamente buttando al vento, ci addita e studia le radici del nostro vivere e del nostro parlare e ha conosciuto molte epidemie, pesti di cui già il grande Tucidide aveva studiato modi e forme e di cui aveva prontamente segnalato le devastanti conseguenze dovute non solo alla “novità” di quei mali, ma anche alla relativa imperizia di chi si proponeva di curarli. Qualche scarna citazione , tratta da “La guerra del Peloponneso”,opera scritta coniugando la sintomatologia della guerra con quella della peste,forse desterà in noi impreviste considerazioni, sull’uno e sull’altro evento, senza colpevolizzare nessuno:” …nulla potevano i medici, che non conoscevano quel male e si trovavano a curarlo per la prima volta – ed anzi erano i primi a caderne vittime in quanto erano loro a trovarsi a più diretto contatto con chi ne era colpito-, e nulla poteva ogni altra arte umana: recarsi in pellegrinaggio, consultare oracoli o fare ricorso ad altri mezzi di questo tipo, tutto era inutile…”. Luciano Canfora, proprio studiando il capolavoro tucidideo, ne ha sottolineato la riflessione sul fenomeno per cui “certe parole usuali nel linguaggio politico, indicanti valori quali amicizia, lealtà…fungono piuttosto da schermo che da rivelatore di determinati comportamenti” ed ha anche evidenziato l’attenzione verso la “propaganda” e le narrazioni strumentali, nelle quali, richiamando anche il latino Sallustio, “vera vocabula rereum amisimus”. E nell’Italia di Machiavelli e Guicciardini, questo mi pare un richiamo che, dal passato, precipita subito nel nostro dilaniato presente.
La peste che ci sta duramente colpendo non suscita, per buona sorte, soltanto le sempre più insopportabile pochezze della nostra classe politica ( i litigi continui e le sparate di “capetti” che dovrebbero avere ben altri pensieri per la testa e le richieste dell’opposizione, preoccupate soltanto dei clandestini e non dei disastri compiuti nelle regioni che amministrano) e i dibattiti televisivi altrettanto stucchevoli, ma ci spinge anche a fare letture interessanti. Devo confessarvi che sono, da moltissimi anni, un appassionato del fumetto d’autore e faccio solo i nomi di Alberto Breccia, Hector German Oesterheld, Francisco Solano Lopez, Hugo Pratt, José Munoz, Carlos Sampayo, Andrea Pazienza e Guido Crepax. Riflettendo sull’ansia che, in modo più o meno intenso, ci prende tutti, tra vaccini promessi e non ancora del tutto sperimentati e numeri terribili della strage italiana e mondiale, tra inutili discussioni sulle libertà negate e messe di Natale anticipate ( ma Dio baderebbe mai a tali sciocchezze, non nasce davvero in noi stessi, e non in ore fissate, il desiderio di un “ricominciamento” necessario del bene e della bellezza del mondo?), ho riletto un capolavoro , “L’Eternauta”, del fumetto di fantascienza, pubblicato a Buenos Aires tra il 1957 e il 1959 in episodi di tre, quattro pagine sulla rivista “ Hora Cero Semanal” , su testi di Héctor German Oesterheld e disegni di Francisco Solano Lopez, riedito opportunamente in Italia nel 2017, in una edizione speciale, splendida, in occasione dei 60 anni dalla sua prima apparizione argentina. Non dirò nulla sulla trama, perché non vorrei togliere al lettore il fascino delle continue sorprese narrative e dei colpi di scena che si susseguono. Dirò solo che si tratta di una situazione estrema in cui tutto il mondo umano sembra traballare e perdere le certezze di sempre, davanti ad una catastrofe che inizia con una strana nevicata fosforescente e letale. Rileggendo “L’Eternauta”, ho provato la medesima angoscia di tutti, oggi, davanti a qualcosa che mette in gioco l’esistenza del nostro modo di vivere e contro cui possiamo davvero pochissimo, salvo sperare che la ricerca scientifica (quella su cui si sono accaniti i tagli di tutti i nostri “meravigliosi” governi) ci offra una credibile ( per ora non ancora chiara) via d’uscita, fatti salvi i sospetti su una colossale speculazione commerciale delle multinazionali farmaceutiche. I due autori furono perseguitati dalla dittatura militare argentina dopo il colpo di stato del 1976, Francisco Solano Lopez fu più fortunato e costretto, per salvare la vita a se stesso ed alla famiglia, all’esilio in Spagna, Oesthereld venne illegalmente deportato nei centri di detenzione e assassinato, non si è mai saputo dove, nel 1978. Il loro capolavoro del 1957-59 rimane una pietra miliare del fumetto d’autore e ancora oggi trasmette al lettore lo sgomento di fronte all’ignoto e insieme la necessità della lotta accanita per la sopravvivenza del genere umano. Rileggerlo a me ha fatto bene, mi ha dato coraggio!
Tra qualche giorno saranno passati quasi nove anni dalla scomparsa di Alberto Bevilacqua, avvenuta il 9 settembre 2013 a Roma. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, di presentare spesso i suoi romanzi in occasioni pubbliche o in premi letterari, di essergli amico e di averlo frequentato, insieme a Cristina, mia moglie, indispensabile dono che la sorte mi ha fatto, a Bari e a Brindisi. Stamattina vorrei ricordare, in particolare, un’occasione, una lettura di poesie di qualche anno fa, in estate, nel Chiostro dell’Archivio di Stato a Brindisi: Alberto, invitato su mio suggerimento dal Sindaco Mennitti, volle che fossi io non solo a presentarlo, ma anche a leggere le sue poesie. Teneva molto al suo esercizio poetico, consegnato in molte raccolte e lo considerava non una appendice della sua narrativa di successo, ma lo considerava come qualcosa a parte, uno scandaglio gettato nelle profondità del mistero del meno decifrabile, delle parole non dette. La poesia, apprezzata da Miguel Angel Asturias, Jorge Luis Borges, Giovanni Testori, gli serviva per costruirsi un archivio privilegiato della sua vita, una sorta di cosmico grembo, per dialogare con le voci delle persone care ( la madre, in particolare), una “camera segreta” da cui isolarsi per poi instaurare, tuttavia, un ponte relazionale su cui far transitare le domande ultime, “piccoli presagi”, così li chiamava, fra Dio e nulla. Ci capimmo subito, tra laici ansiosi di cercare e non paghi dei catechismi e dei precetti, tra uomini che amavano lo spettacolo e il dono prezioso di saper comunicare agli altri “emozioni”. Sapeva della mia passione per il teatro e perciò volle che fossi proprio io a leggere alcune sue poesie in quella magica serata estiva: esitai, per evitargli pessime figure con una mia lettura, ma non ci fu nulla da fare e così mi trovai non solo a parlare di lui e della sua poesia, cosa che rientrava nelle mie corde abituali, ma lessi anche i suoi versi. Non dimenticherò mai la sua voce che, dopo ogni poesia letta, mi chiedeva di leggerne ancora un’altra e mi sussurrava all’orecchio “leggi come un dio”, non lo dimenticherò mai. Così, oggi, col cuore gonfio per l’amico che ho perduto e per l’artista poliedrico (poeta, narratore, sceneggiatore, regista cinematografico) che non abbiamo più, vi trascrivo una sua poesia, lette da me quella sera,
“duetto per voce sola”, naturalmente rivolta alla madre, presente quasi sempre nelle sue pagine e nella sua mente : “ sono un tuo soprapensiero/ inseguendoti le ombre più lunghe/ dei platani/ col silenzio della pioggia che s’aggira, / il fischio/ lungo, modulato, prima di raggiungerti, / mia memoria reciproca, mia speculare / confidenza col tempo, / ci siamo sbagliati a disperare di noi, / siamo perfetti/ nel duetto per voce sola, / mia itaca perenne di tutte le mie vite / deviate dall’equivoco”.
Il periodo pandemico si trova a coincidere con la mia scelta di provarmi nel genere narrativo “noir”. Esiste , in Italia, un dibattito anche molto acceso tra quanti affermano che il “noir” sia un sottogenere del “giallo” e quanti, al contrario, con molta passione critica, ne rivendicano una sorta di autonomiaPartiamo da un dato che pare ormai acquisito, come scrive l’americanista Alessandra Calanchi sul blog Urbinoir: il “noir è più che altro una questione di atmosfera, di luoghi, di mood. In esso non è in primo piano il crimine e neppure la detection , la ricerca del colpevole, né il brivido, né il sangue, il “noir” non si accontenta di narrare una storia, ma cerca di trasmettere odori, sapori, suggestioni sui risvolti anche psicologici di un delitto che, forse, tutti potrebbero commettere in un momento particolarmente teso della loro vita, magari in circostanze di esclusione e difficoltà, forse non nelle metropoli in cui il “giallo” classico è nato e si è ambientato (la Londra di Conan Doyle e di Sherlock Holmes, la Parigi di Simenon e di Maigret o l’America di Chandler), ma nelle degradate periferie del nostro vivere quotidiano. Forse l’aggettivo “mediterraneo” potrebbe spiegarci la qualità di quello sguardo nel quale la violenza, innegabile, si lega inestricabilmente alla bellezza di uno spazio mediterraneo in una narrazione alla Braudel, in cui aspetti letterari e culturali si legano a realtà storiche territoriali in una sequenzialità di grande respiro e durata. Anche la letteratura, nel corso dei secoli, a poco a poco, si spingerà fino ad indagare, come scelta di campo, lo spazio sociale e psicologico dove può nascere il crimine e autori come Dostoevskj, Poe, Stevenson, Dickens possono dirci molto su questo e come non citare le incursioni pirandelliane nel territorio mentale della rivolta contro la banalità e la crudeltà del “buon senso” e Leonardo Sciascia, figura centrale in questa storia, con la sua implacabile ricerca della verità in una società corrosa dalla mafia e la appassionata sua immersione nella malattia e nella morte, in cui naufraga ogni speranza di giustizia e di verità fino al “cancello della preghiera.
*
Questo testo viene pubblicato su questo dominio (www.blogletteratura.com) all’interno della sezione dedicata relativa alla rivista “Nuova Euterpe” a seguito della selezione della Redazione, con l’autorizzazione dell’Autore/Autrice, proprietario/a e senza nulla avere a pretendere da quest’ultimo/a all’atto della pubblicazione né in futuro. E’ vietato riprodurre il presente testo in formato integrale o di stralci su qualsiasi tipo di supporto senza l’autorizzazione da parte dell’Autore. La citazione è consentita e, quale riferimento bibliografico, oltre a riportare nome e cognome dell’Autore/Autrice, titolo integrale del brano, si dovrà far seguire il riferimento «Nuova Euterpe» n°01/2023, unitamente al link dove l’opera si trova.