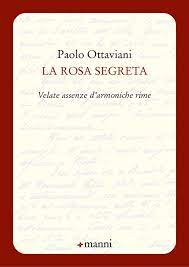Articolata e complessa è la poetica di Alfredo Pérez Alencart, nutrita nel contempo di profondità filosofica e di delicatezza descrittiva, di apparente semplicità strutturale (che in un’ideale evoluzione temporale sembra definirsi secondo uno schema di “contrazione” che non è certo quantitativo: non si tratta insomma del numero dei versi) e di profondità di pensiero (che tende al sacro nel senso più classico del termine e ne assume le “perimetralità” al di là della confessione in senso lirico ma ben radicata nella fede cristiana in senso umano e umanistico). Una affascinante dualità che fornisce o forse eredita la ricchezza dei germogli culturali radicati in due diversi emisferi del globo ai quali entrambi evidentemente il poeta appartiene, radici e rami, fiume e affluente, lucciola e lampo.
Fatto cento del supporto ideale e filosofico fondante la poetica di Alencart, non si vuole qui svelarne i percorsi generali in un tentativo di sintesi definitiva della stessa, per la quale invece si rimanda alle numerose letture che del poeta peruviano-salmantino sono state elaborate da più parti in tutto il mondo, certamente utili ad entrare nell’universo poetico del Nostro. Non ultime le pregevoli letture di José Luis Ochoa[1] e soprattutto la “grandangolare” rassegna di Yordan Arroyo sulla poetica Alencartiana[2], focalizzate sulla più recente pubblicazione dell’ultima fatica letteraria del poeta, dal titolo El sol de los ciegos, per i tipi del prestigioso editore Vaso Roto.
Senza intaccare i due valenti contributi appena citati, ai quali si rimanda comunque per una opportuna lettura d’insieme della poesia di Alencart, si vuole qui piuttosto evidenziare uno dei tanti possibili percorsi battibili, passeggiando attraverso i versi del Poeta, secondo come essi stessi ne suggeriscono la fruizione, l’elaborazione e l’assimilazione estetica e contenutistica, attraverso la selezione di alcune poesie seguendo le quali si è maturata la presente riflessione.
Ci sembra tratto distintivo di questo possibile percorso, un “sentiero” caratterizzato da alcuni dettagli, strutturali e non solo, nella composizione di una lirica, a cui l’Autore affida rimandi e richiami rendendo compartecipi del messaggio tutti gli elementi, anche appunto strutturali, che la compongono. Si veda per esempio, come utile punto di partenza, in una sorta di cammino al contrario, il tenero componimento Año nuevo recentemente composto per l’amata Jaqueline:
| AÑO NUEVO La orquídea que te ofrezco hoy, brotó el año pasado, princesa. Es flor cuidada en el invernadero de mi corazón. Acéptala. No importa que otros la estimen cosa de instantes. También la aurora lo es, pero renace siempre, como el amor que te entregué el siglo pasado, princesa. | ANNO NUOVO L’orchidea che oggi ti offro sbocciò l’anno passato principessa. È fiore ben curato dentro la serra del cuore mio. Accettala. Non importa che altri la considerino cosa passeggera. Lo è pure l’aurora però rinasce sempre come l’amore che ti ho dedicato nel secolo passato, principessa. |
Qui il titolo definisce in maniera chiara un locus temporale che lascia poco spazio a fughe diverse: è il nuovo anno! Eppure Alencart, attraverso la semplice evocazione del dono di un fiore e in meno di venti “semplici” versi, stabilisce legami temporali (e non solo!) che disvelano una continuità che è insieme di tempo, appunto, e sentimentale a dispetto della percezione del tempo ordinariamente considerato tale. Pare quasi che stia disegnando, con tratti estremamente delicati, un percorso di eternità che non può che essere il contesto privilegiato del sentimento d’amore, sancendolo attraverso due semplici richiami: el año pasado e el siglo pasado. Entrambi sono legati e sottolineati – casomai al lettore distratto sfuggisse – dalle uniche due invocazioni/identificazioni del destinatario della poesia: princesa. E la chiave interpretativa della poesia sta tutta nella parola instantes, al centro del componimento (qui tradotta con passeggero): non importa che gli altri considerino un fiore cosa passeggera. Lo è anche l’alba eppure sempre rinasce, stabilendo così quel continuum filosofico e sentimentale che travalica e trascende tutto ciò che definisce ordinariamente la condizione umana, percepita tale – come si diceva sopra – da “tutti gli altri”. E in questo senso stabilisce anche l’unicità del rapporto con l’amata – Jaqueline, ovviamente, per chi segue e conosce il poeta – sancito anche solo dalla semplice scelta dell’orchidea come oggetto del dono.
Nella tradizione occidentale, infatti, questo fiore, oltre ad essere simbolo di bellezza, eleganza e armonia, è anche il dono privilegiato riservato all’unica persona che sappiamo corrispondere l’amore e la passione con cui viene donato (l’etimo del nome del fiore la dice lunga sul valore “polisemico” di un simile dono) così come l’atto del dono stesso si configura, nella simbologia del fiore, come un devoto ringraziamento per la concessione dell’amore ricevuto.
Questa reciprocità e questo rapporto unico e unitario si pone, nella prospettiva di questa lirica, al di là del tempo, al di là dello spazio (en el invernadero / de mi corazón) e al di là della condizione umana, come legame fra anime che non possono che abitare l’eternità. Pare quasi voglia sottintendere che un fiore sbocciato nell’anno precedente stia a significare come, dal passato (rafforzato dalla presenza perfino del siglo, appunto, pasado) rifiorisca puntualmente come un’aurora fa ogni giorno, quasi a pesar del año nuevo, quasi nonostante il nuovo anno. Ed è splendida la forma con la quale Alencart racchiude all’interno di così pochi versi e così apparentemente semplici, un impianto di pensiero e di sentimento che frantuma la retorica abusata dell’amore, affidando mirabilmente l’originalità dell’elaborazione alla struttura e alla composizione stessa del testo poetico.
Oltretutto, il richiamo all’eternità, all’unione eterna, alla “vita” eterna non è solo dimensione lirica di un contesto d’amore ma pare arricchita, anche solo allusivamente, da un supporto ben più consistente, secondo un ottica che scopriremo più avanti. È nell’eternità che si compie il senso umano del passaggio sulla terra, sembra voler dire il poeta. «No es casual que el lenguaje de Pérez Alencart contenga un matiz religioso, y se nutra asimismo de la Biblia y la mística española para establecer un sistema de correspondencias y/o afinidades» (David Cortés Cabán)[3].
Ma pensare che l’apporto da un lato filosofico e dall’altro spirituale sia l’unica matrice della poesia di Alencart sarebbe completamente fuorviante. La capacità di fondere registri mantenendo vividi quei dettagli che consentono all’uno di fornire la cornice all’altro e viceversa, sembra quasi essere prerogativa del labor alencartiano.
Nella poesia che segue dal titolo Perfume, inclusa nella più recente silloge del Nostro, El sol de los ciegos (Vaso Roto, 2021), è impossibile non avvertire un afflato di sensualità vivida eppure delicata, coinvolgente e mai straripante, contenuta e mai smodata che incornicia richiami di natura diversa e possibilità interpretative, ermeneuticamente e direi perfino culturalmente (non a caso Juan Marez apre il suo commento con un richiamo geografico netto al Perù, terra natale di Alencart) ben più ampie dei soli testo e intertesto – esiste anche un metatesto, del tutto spalancato – qui così strettamente intrecciati. Una sensualità che “pretende” di stimolare perfino l’olfatto attraverso la parola e il linguaggio e che nel contempo lascia orizzonti spaziali immaginifici completamente “aperti” anche strutturalmente.
Consideriamo per qualche istante il bel commento, particolarmente lirico, a questa poesia, del colombiano Juan Marez che così scrive: «Himeneos de cantos antiguos amando la belleza, la que brota del alma y no se atrapa en el cuerpo. Dos estados diferentes para la amada eterna. “De cuerpo y alma”, vegetación de efluvios»[4].
Ancora una volta, contratti in un’affascinante fusione, elementi di natura diversa interagiscono su piani interpretativi differenti mantenendo intatta la semplice fruizione del verso in quanto tale. Non è difficile immaginare i due amanti stesi l’uno accanto all’altro attraverso pochissime semplici parole che evocano la scena senza descriverla, perimetrandola in una concretezza che slarga solo nel momento in cui vengono chiamati in causa i sogni, quel “luogo” fin dove il poeta ardisce a spingersi pur di raggiungere l’amata e dal cui momento in poi le immagini perdono concretezza per ampliarsi, mantenendo l’allusività, in voli di farfalle da selve lontane fino a diluirsi nella delicata percezione olfattiva e a rendere quasi evanescente il tutto senza mettere un punto, senza definire alcunché. Perché è un componimento che resta aperto, grazie a quel mientras la noche… la cui sapiente iterazione sul finale sorprendentemente chiude il cerchio strutturale della lirica lasciando aperti gli orizzonti ermeneutici della stessa. Ancora una volta significati e significanti giocano e compartecipano, a un livello diverso e più alto, alla costruzione minuziosa (ecco il senso della contrazione alencartiana! Che più consapevolmente ora possiamo definire concentrazione) dei tasselli ideali che si intersecano a rappresentare l’universo di Alencart.
| PERFUME Reconozco ese aroma próximo a mi almohada, en tu cuello, mientras la noche… Te alcanzo a cada respiración y me sumo a ti hasta en tus sueños, allí donde estamos a pie de vida, juntos, como dos mariposas que volaron desde selvas lejanas. El olfato también roza, meintras la noche… | PROFUMO Riconosco quest’aroma prossimo al mio cuscino, sul tuo collo, mentre la notte… Ti raggiungo in ogni tuo respiro e mi unisco a te fin dentro i tuoi sogni, lì dove stiamo percorrendo la vita, insieme, come due farfalle che hanno volato da selve lontane. L’olfatto pure sfiora, mentre la notte… |
La contrazione del significato dentro una struttura di significanti particolarmente ricca è ancora più evidente nella lirica del 2002 Presagios, appartenente alla silloge Madre Selva, dello stesso anno.
In questo caso Alencart non crea ex-novo una struttura di significanti come nel caso dell’orchidea del año nuevo ma parte da un’immagine la cui ricchezza simbolica deve essere data per assunta se si vuol godere a pieno della miglior comprensione della lirica. Il colibrì, infatti, ha un valore particolarmente pregno nelle culture latino-americane che hanno ereditato la “simbologia” di questo magnifico piccolo uccello dall’antica tradizione Maya poi arrivata fino a noi. In altri termini: se in año nuevo l’orchidea con tutto il suo apparato simbolico può rimanere anche un non-significante senza che sia compromesso (certo, impoverito) il senso ultimo della lirica che trova altri sbocchi e altre strade (quelle sopra citate) per giungere al medesimo risultato, senza il colibrì e il suo apparato allegorico, questa lirica Presagios che segue, resterebbe invece quasi completamente oscura. Sarà opportuno sintetizzare la leggenda antica e alla luce di quella rileggere i versi che seguono per riottenerne una intensità del tutto diversa.
Secondo i Maya, infatti, il colibrì aveva il potere di infondere gioia e amore negli umani al punto da essere ritenuto capace di poteri di guarigione e perciò stesso sacro.
«La leggenda Maya del colibrì inizia quando gli dei crearono ogni singolo animale con un compito specifico da svolgere sulla terra. Una volta finita la distribuzione, si resero conto che mancava un lavoro molto importante: serviva un messaggero per trasportare i loro pensieri e desideri da un luogo ad un altro. Ma non c’era più materiale per creare un nuovo animale.
Così gli dei, creatori del possibile e dell’impossibile, decisero di fare qualcosa di più speciale. Presero una pietra di giada e scolpirono una freccia, che simboleggia il viaggio.
Trascorsi un paio di giorni, soffiarono così forte che la freccia volò attraverso i cieli fino a diventare un bellissimo uccello multicolore. Così nacque x ts’unu’um , vale a dire il colibrì.
Il colibrì iniziò a trasportare pensieri e desideri, senza che gli uomini se ne rendessero conto. Ma a un certo punto questi iniziarono a catturare il bellissimo uccello, ammaliati dalla bellezze delle sue piume»[5].
Per quest’atto di hybris dell’uomo rispetto alla sacralità dell’uccello, gli dei si adirarono al punto di lanciare il proprio anatema: chiunque avesse catturato un colibrì sarebbe stato punito con la morte! Ma proprio perché sacro agli dei, il colibrì mantiene intatto il suo carico di positività giacché quando si vede un colibrì qualcuno – si dice, non a caso – da lontano manda auguri e amore. Foriero dunque di buona novella (buena nueva) e fausti presagi.
| PRESAGIOS A lo lejos, a la altura de las ramas estremecidas por el vuelo silencioso del colibrí, ofrecen su buena nueva los presagios. Crece algo así como un humo que el viento no voltea. Leo en el gran cielo un mensaje hecho de miel y de ceniza. Enardecidos amaneceres abren senderos para el retorno emprendido. Por mis venas ahora vuela el colibrí. | PRESAGI Lontano dall’alto dei rami tremanti al tacito volo del colibrì, offrono buone novelle i presagi. Così cresce qualcosa come fumo che il vento non mulina. Leggo nel cielo immenso un messaggio di miele e di cenere. Albe infuocate svelano sentieri per il ritorno intrapreso. Per le mie vene vola adesso il colibrì. |
Si recuperino pertanto tre dati importanti relativi a questo mito: il colibrì è messaggero del divino ed è così strumento di sacralità; è impossibile afferrarlo a meno che sua sponte non si approssimi ed anzi, catturarlo scatenerebbe le ire del divino; se avvistato il colibrì è portatore di auguri e buoni presagi. È evidente come la lirica abbia necessità di assunzione di questi dati per rivelare tutto il suo potenziale polisemico e tutta la sua carica spirituale. Rileggendola alla luce di questi sembra aprirsi ad orizzonti particolarmente carichi di quei significati che restano gli stessi fondamentali costituenti la poetica alencartiana.
Particolarmente affascinante il ritorno dell’immagine dell’alba. Se nella prima lirica era un semplice termine di paragone rispetto all’orchidea, ad indicare la possibilità della rinascita, qui è elemento attivo e didascalico, illuminante. È l’elemento della luce di questa lirica, che entra a svelare e chiarire percorsi già intrapresi quasi alla cieca, mostrandone in chiaro l’intera geografia. Così in qualche modo, la chiusa della poesia sembra confermare, col suo presagio positivo, che quella intrapresa è la strada giusta: il colibrì appartiene al poeta ormai come elemento intrinseco, fin nelle vene. E la maledizione divina è scongiurata dal fatto che non è l’uomo ad averlo catturato ma esso stesso a volargli – magnifica immagine – nelle vene.
Eppure proprio la chiusa mantiene un affascinante alone di ambivalenza che in qualche modo non esclude un umanissima riflessione rispetto alla morte, comprensibile ed ineludibile ma che, ancora una volta, lascia aperta la lirica e le possibilità di riflessione senza mettere un punto di chiusura oggettivo ma mantenendo integra la soggettività della posizione del poeta.
Un impianto elaborato in questo modo e orchestrato in una struttura particolarmente densa, esprime il meglio della propria carica emotiva ed intellettuale non tanto nella dilatazione polisemica del testo quanto piuttosto, al contrario – e parrebbe un paradosso ma cos’è la poesia se non anche un gioco che tende a stravolgere sistemi consolidati anche sul piano tecnico e strutturale? – nella concentrazione semantica del significante che meglio consente – e in questo senso la sinteticità dei testi diviene necessaria e al contempo ottimale – schemi immaginifici quasi a definire il percorso dell’acquisizione del significato da parte del lettore. Il poeta cioè si fa anche guida generosa nell’iter lirico delineato dai propri versi. Non è certo una pedante premura didattica: direi piuttosto una generosa preoccupazione contenutistica.

Di tutt’altra temperatura la poesia Luciérnagas, sempre del 2002 nella medesima raccolta Madre Selva. La inseriamo in questo contesto proprio per evidenziare un controcanto allo sviluppo di una poetica che parte da lontano rimanendo capace di registri differenti al punto, come in questo caso, da essere quasi completamente scevra da strutture significanti necessarie alla comprensione della lirica. Qui il testo sembra non essere più solo evocativo o per lo meno il registro preponderante non pare più solo questo. Né semplicemente descrittivo. Ricorda piuttosto la fascinazione sorpresa e sorprendente delle atmosfere di Juan Ramon Jiménez e il sapore dello stupore lorchiano, il bagliore quasi improvviso, l’incanto che non richiede neppure di essere compreso se non probabilmente solo goduto. L’intento didascalico si sfuma fino a divenire impercettibile quanto più il fermo-immagine definisce nel tempo e nella storia (anche la propria storia) una situazione connotata da dettagli che la identificano. Sebbene vada pure sottolineato che altrove la luciernaga si fa qualcosa di più nell’universo poetico alencartinao. Ma la luce… quella è tornata anche in questa lirica. E non a caso il tratto distintivo di questa poesia è proprio la luce che, nell’elaborazione stilistica del Nostro ridefinisce i contorni di una percezione attraverso una misura che restituisce il poeta, quasi “automaticamente”, di colpo, all’improvviso, al tiempo de la infancia. Non il contrario.
| LUCIÉRNAGAS Me acerqué al encantamiento. Vi farolas al crepúsculo, mecheros encendidos como fuegos aleteados. Dádivas volando, centellas delante de mis ojos. Fue en el tiempo de la infancia. Fue cuando se tejen asombros ante la luz de las luciérnagas. | LUCCIOLE Fui prossimo all’incanto. Al crepuscolo vidi lampioni, accendini infuocati come fiamme tremanti. Volavano doni, scintille davanti ai miei occhi. Fui nel tempo dell’infanzia. Era quando s’intrecciano stupori davanti alla luce delle lucciole. |
E quando si perde anche l’incanto? In questo mio breve e modesto percorso critico “discendente” (non certo in senso qualitativo se si continua a tener presente il punto di partenza di questa riflessione in riferimento alla produzione del poeta peruviano-salmantino, né certamente quantitativo, come si spera di dimostrare in chiusura) si giunge all’essenzialità dell’espressione poetica che non richiede più didascalie e spiegazioni, suggerimenti o indicazioni di percorsi intrapresi che solo “l’alba infuocata” restituisce alla vista e all’appropriazione.
Nella poesia Campo de refugiados si ha quasi l’idea di una dirittura d’arrivo, come una deriva che per un momento cede allo sconforto di una domanda insieme tragica e retorica: «quale guerra perdono certi bambini senza averla neppure provocata o voluta?». Si susseguono, così, dettagli su dettagli, estremamente concreti quasi tangibili, madri che sotterrano i corpi dei figli, anziani immobili quasi confusi al fango e alle polveri nelle quali giacciono, infermi che hanno perso persino la voglia di raccontare, di tramandare le proprie esperienze. È un panorama di desolazione tragico e assoluto, quasi come scena di una tragedia antica dove un autentico dolore è racchiuso magnificamente nella descrizione di una faida al centro del cuore, come se il poeta ne avvertisse i pugni. Eppure l’ultima strofa, pur non intaccando affatto le tinte fosche di questo scenario apocalittico, apre una feritoia ermeneutica in quel mea culpa la cui sola citazione, nonostante il sin entonar addita e mostra chiaramente (non è un caso che siano proprio le ultime parole nella chiusa della lirica, quelle che alla fin fine più restano) la strada, la via d’uscita, sebbene in questo contesto del tutto inattesa. Mette in atto Alencart un espediente che attraverso la negazione, tira invece in ballo proprio ciò che si sta negando, ciò che apparentemente resta occluso, nascosto, negato. Ripeterà questo stesso espediente letterario anche – e non solo – nella splendida poesia Incendios, a cui si rimanda a titolo esemplificativo. Intanto in un campo profughi…
| CAMPO DE REFUGIADOS Y estos niños ¿qué combate perdieron sin haberlos provocado? Mujeres que sólo esperan para enterrar a sus criaturas. Pues yo miraba ancianos entre el polvo o el barro de esos laberintos, hombres enfermos que ya ni cuentan lo que han vivido. Otra vez la gente agolpándose en el centro de mi corazón, otra vez la humanidad sin entonar su mea culpa. | CAMPO PROFUGHI E questi bimbi che guerra hanno perduto senza provocarla? Donne che aspettano soltanto di sotterrare le proprie creature. Così osservavo anziani fra la polvere e il fango di questi labirinti, uomini infermi neppure più raccontano quello che hanno vissuto. Di nuovo la gente s’accalca nel centro del cuore mio, l’umanità di nuovo senza intonare i suoi mea culpa. |
Alencart batte su diversi registri, suona diverse corde e, come un direttore d’orchestra, sa suonarle tutte e soprattutto sa armonizzarle in una sinfonia che declina in diverse stagioni un medesimo sentire e nella stessa stagione sentimenti diversi. Mi piace pensare a un sotteso dualismo che diviene ricchezza essenziale della poetica alencartiana nella preminente traduzione dell’opposizione fra l’essenza della luce e l’assenza di luce, la ceguera, che, citando nuovamente il più recente lavoro del Nostro, El sol de los ciegos, così efficacemente esprime Amarù Vanegas sulla rivista Nueva York Poetry: Alfredo Pérez Alencart «nos lleva al centro esencial de la poesía y nos enseña que las transformaciones se gestan en la luminiscencia a la que preceden las sombras, una experiencia donde el aprendiz se alumbra solo después de pasar por la ceguera para salir de allí “con las pupilas alucinadas»[6].
È sintomatico e quasi naturale che questo percorso porti inevitabilmente all’ultima opera di Alencart, maturata negli anni e che forse non a caso trova compimento solo ora. Il punto d’arrivo, cioè, di un percorso che fonde insieme questi registri attraverso i quali il poeta si è mosso durante tutta la sua lunga carriera letteraria. Ed è inevitabile che la sintesi di questo iter traduca proprio nella luce tanto gli intenti evocativi quanto quelli descrittivi, tanto gli intenti allegorici quanto i dati di denuncia più concretamente sociale. Non è un caso che il titolo dell’opera sintetizzi questo percorso in modo straordinariamente efficace: “il sole dei ciechi” lascia un evanescente quanto affascinante alone di ambiguità – che è pure l’anima stessa di quella luce – tra l’ambizione alla luce e l’alternativa alla luce per un cieco. Ma è pure sconfinamento di ambivalenza, mai alternativa sul senso stesso della cecità in quanto incapacità, impossibilità o mancanza di volontà a vedere. Ecco come anche l’intento didascalico rientra prepotentemente in gioco in una silloge da godere profondamente su tutti i livelli di fruizione che la stessa propone e con la quale si propone.
Si veda ancora una volta la poesia Incendios, per la prima volta in italiano (come tutte le poesie qui citate[7]) dove già dai primi versi tutti questi elementi trovano ordine quasi dichiarativo nella prima strofa: «Este mundo / es un incendio al que / muchos avientan / sal / con las manos / ahuecadas». Sono chiamati in causa elementi assolutamente realistici e tangibili a sintetizzare la metafora del mondo come elemento sociale, attraverso immagini di azioni concrete particolarmente affascinanti a descrivere gli effetti dell’azione umana tanto sul pianeta (non è una poesia ecologista) quanto sul mondo inteso come umanità. Ed ecco esplodere (anzi, direi implodere) la metafora della luce subito dopo, piegata ‘sta volta a farsi negazione di se stessa laddove quella presenza non è che sentenza, condanna che lascia il mondo nell’oscurità: «Este mundo / es morada oscura, / aunque / tenga hogueras listas / para sentencia». È certo un panorama sconfortante, anche di dolore, eppure… la poesia di Alencart non è mai nutrita da un pessimismo irreversibile: quei falò, quei fuochi, alzano un fumo (ricordate quel algo como humo della poesia Presagios?) al di là del quale, quasi senza voce, soffocano necessità di suppliche e quella luce non può che farsi essa stessa voce che denuncia e sancisce in qualche modo proprio quella necessità racchiusa e denunciata nelle parole se acallan afónicas. Un gioco ermeneutico, quello della doppia negazione (anche semantica), a cui Alencart ci ha già abituati e istruiti.
| INCENDIOS[8] Este mundo es un incendio al que muchos avientan sal con las manos ahuecadas. Este mundo es morada oscura, aunque tenga hogueras listas para sentencia. Tras el humo se acallan afónicas súplicas de purificación. | INCENDI Questo mondo è un incendio sul quale molti spargono sale con le mani a coppa. Questo mondo è dimora oscura sebbene abbia roghi pronti alla condanna. Al di là del fumo soffocano afoniche suppliche di purificazione. |
Sintesi di luce, dunque, che pure sul piano letterario trova nobili radici che opportunamente ed acutamente Yordan Arroyo evidenzia nel suo bel saggio sopra citato: «punto importante de este mismo pasaje de la Divina Comedia que se conecta con el poemario de Alencart se encuentra entre los versos 67, 68 y 69: “La luz la tienen los ciegos apagada: / y así a estas sombras, en su noche oscura, / de los cielos la luz está negada” (Trad. Bartolomé Mitre)». Allora non risulta più così complesso comprendere il valore di quella luce lungo tutto il percorso Alencartiano se possiamo considerare la Commedia una chiave d’accesso all’elaborazione lirica del sentire del Nostro: basti pensare al valore che “quella Luce” ha nel Paradiso dantesco. E forse –partendo da lì – non solo in quello.
[1] J. L. OCHOA, La luz salvífica, presente en ‘El sol de los ciegos’ in «TIBERIADES, Red iberoamericana de Poetas y Criticos Literarios Cristianos»
https://tiberiades.org/?p=5973&fbclid=IwAR0Rs0kvbsBeU1LjReL-VqjlAyEcCElmicfmplG3wHTYBR3mBJd-17u56ME
[2] Y. ARROYO, Sobre la poesía de Alfredo Pérez Alencart. Texto de Yordan Arroyo in «CÍRCULO DE POESÍA, Revista electrónica de literatura»
[3] «Non è un caso che il linguaggio di Pérez Alencart contenga una sfumatura religiosa e si nutra perciò stesso della Bibbia e della mistica spagnola per stabilire un sistema di corrispondenza e/o di affinità»: D. C. CABÁN, Un corazón, una historia: la poesía de Alfredo Pérez Alencart in «LETRALIA, Tierra de letras» del 29/11/2020.
https://letralia.com/lecturas/2020/11/29/encumbra-tu-corazon-alfredo-perez-alencart
[4] «Imene di antichi canti che amano la bellezza, quella che scaturisce dall’anima e non è intrappolata nel corpo. Due stati diversi per l’eterna amata. “Di corpo e anima”, vegetazione di effluvi».
[5] R. RAGNI, La leggenda Maya del colibrì in «Greenme» del 14/03/2017
https://www.greenme.it/vivere/mente-emozioni/leggenda-maya-colibri
[6] «A.P.A. ci riporta al centro essenziale della poesia e ci mostra che le trasformazioni si covano nella luminescenza alla quale si arriva dall’ombra, un’esperienza nella quale l’apprendista si illumina solo dopo essere passato per la cecità per risalire da lì “con le pupille allucinate”»: A. VANEGAS, El sol de los ciegos, Alfredo Peréz Alencart in «NUEVA YORK POETRY, Review» del 11/01/2022
[7] Tutte le poesie di Alfredo Pérez Alencart presenti in questo saggio, sono state qui tradotte per la prima volta in italiano ad eccezione della poesia Perfume che gode pure di una pregevole traduzione italiana precedente del poeta ed editore romano Beppe Costa edita in A. PÉREZ ALENCART, Encumbra tu corazon, Ed. Tiberiades – PellicanoLibri 2020, pp.46-47.
[8] L’ultima fatica letteraria del Nostro consta di ben 100 poesie, selezionate dall’autore all’interno di una produzione di oltre 200 componimenti di «temperatura affine» scritti nell’arco di oltre un decennio fino alla settimana precedente la pubblicazione. Riservandosi comunque per gli anni a venire la pubblicazione completa e definitiva de El sol de los ciegos.
Il suo nuovo poemario, è dedicato a Jaqueline, moglie e compagna di vita recentemente scomparsa, che da tempo insisteva affinché il poeta salmantino di origini peruviane accettasse di pubblicare con una casa editrice così prestigiosa. «E così feci – dichiara Alencart al periodico La Razón – solo poche ore prima della sua dipartita, dall’ospedale dove accompagnai i suoi ultimi istanti di vita. Però la porto sempre con me, allora e oggi, e anche per il futuro».
«Non é solo la fede cristiana ad unirci – aggiunge il poeta – quanto il fatto di percepirla davvero in una realtà altra dove nessuno può compromettere i desideri e le affinità. Oggi posso confermare la teoria di Platone per la quale dentro una caverna, attorno a un fuoco, gli astanti percepiscono solo le ombre di una realtà apparente».
*
Questo testo viene pubblicato su questo dominio (www.blogletteratura.com) all’interno della sezione dedicata relativa alla rivista “Nuova Euterpe” a seguito della selezione della Redazione, con l’autorizzazione dell’Autore/Autrice, proprietario/a e senza nulla avere a pretendere da quest’ultimo/a all’atto della pubblicazione né in futuro. E’ vietato riprodurre il presente testo in formato integrale o di stralci su qualsiasi tipo di supporto senza l’autorizzazione da parte dell’Autore. La citazione è consentita e, quale riferimento bibliografico, oltre a riportare nome e cognome dell’Autore/Autrice, titolo integrale del brano, si dovrà far seguire il riferimento «Nuova Euterpe» n°01/2023, unitamente al link dove l’opera si trova.