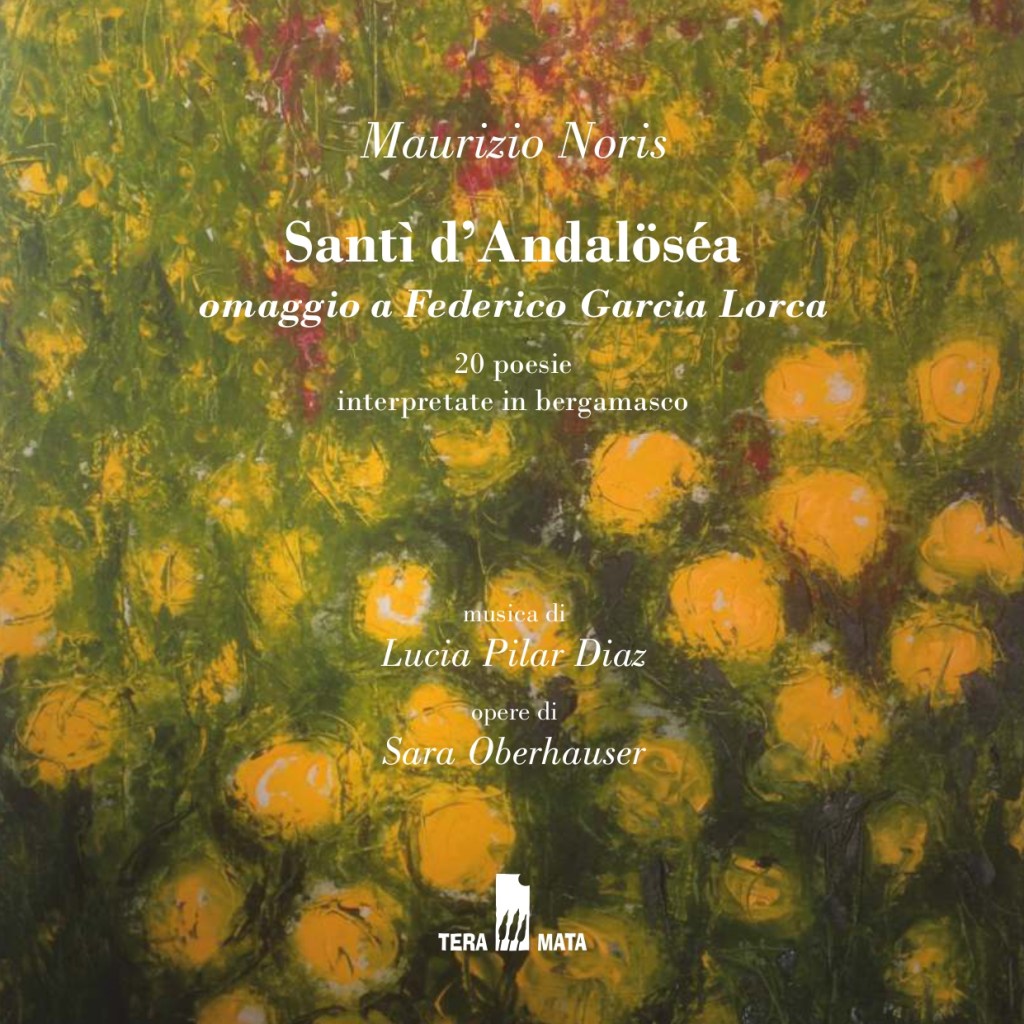Forse, nonostante la traduzione scialba
e il commento pedestre e frettoloso,
ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda,
che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie.
(P. Levi, Se questo è un uomo)
Dante Alighieri si innamorò di Beatrice Portinari quando lui stava per compiere i nove anni e lei gli otto, come racconta lo scrittore nella Vita Nuova[1]. Doveva essere il 1274 e, secondo quanto racconta Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante[2], l’incontro è avvenuto a Calendimaggio, cioè in occasione dell’arrivo della bella stagione che si festeggiava appunto il primo di maggio, organizzando in famiglia e nei quartieri banchetti e balli. Dante aveva accompagnato il padre Alighiero alla festa presso la casa di Folco Portinari, il padre di Bice, o Beatrice, come Dante la sentì chiamare. Ecco che Dante, colpito inspiegabilmente dalla bambina vestita di un abitino rosso sangue,[3] si innamora improvvisamente e perdutamente[4].
Non potremo mai sapere con certezza se si tratta di fatti realmente accaduti o di immagini ricavate dalla fantasia dell’autore prima e di Boccaccio poi, e arricchite dalla simbologia del numero nove che, multiplo di tre, si ripete in vari modi nella Commedia[5]. Un amore infantile e platonico, possiamo ipotizzare, tipico di quell’età che, sentito, percepito, vissuto interiormente o meno, ha condizionato tutta l’opera dello scrittore. E proprio l’idealizzazione di un amore nato da bambini ha aperto la strada alla dimensione mistica del sentimento d’amore di Dante per Beatrice.
Lo storico Alessandro Barbero, nella ricostruzione della biografia dell’autore e del suo tempo, evidenzia la differenza del rapporto che gli uomini medievali, rispetto a noi post-romantici, hanno con il sentimento d’amore, per noi di massima importanza e nobiltà, per loro visto quasi con sospetto e timore, data la dimensione irrazionale che inevitabilmente porta con sé. In un’epoca in cui la ragione era considerata fondamentale guida dei comportamenti umani, si discuteva se l’amore fosse qualcosa di buono o di terribilmente pericoloso. Dante sceglie Virgilio come suo duca, cioè guida spirituale, in nome di quei valori nobili e giusti che incarnò prima della nascita di Gesù, e lo rende non a caso allegoria della Ragione, e quindi faro per ritrovare la retta via e percorrere i primi due regni dell’Aldilà, ma anche per raggiungere la donna amata. Il poeta riprende il dibattito del suo tempo nel V canto dell’Inferno[6], dove vuole cogliere con esattezza i confini tra amore che eleva e amore che porta alla dannazione e quindi riflettere sulla pericolosità dell’amore stilnovista se non accompagnato dalla ragione, argine fondamentale di quella passione che, altrimenti, rischia di impadronirsi di ogni aspetto dell’esistenza. È proprio questo il peccato commesso da Paolo e Francesca, amanti sfortunati in un’epoca in cui l’amore vero era concepito al di fuori del rapporto coniugale, ma che appunto non ammetteva l’abbandono totale alla sua irrazionalità. Dante sembra risolvere questa contraddizione tra bisogno dell’esperienza amorosa e necessità di restare entro i limiti della ragione, rendendo Beatrice, oggetto già di un amore platonico, così nobile da poter ripetere dietro a Omero: «Ella non parea figliuola d’uomo mortale, ma di deo»[7] e rifacendosi così a quel filone di pensiero filosofico-teologico medievale secondo cui l’uomo è visto quale imago Dei, cioè immagine di Dio.
Lo stesso Guido Guinizzelli, padre del Dolce Stil Novo[8], nella parte finale della canzone Al cor gentile rempaira sempre amore, risponde a Dio che lo rimprovera di aver lodato la donna secondo gli attributi che spettano a Dio e alla Vergine Maria: «Tenne d’angel sembianza / che fosse del Tuo regno; / non me fu fallo, s’in lei posi amanza»[9]. Il poeta bolognese scambia la donna amata per un angelo del regno di Dio e lodando lei loda Dio. Così Beatrice da donna realmente esistita e amata in giovinezza dal poeta, evocata nella memoria nella Vita Nuova, diventa personaggio simbolico, trasfigurato, sublimato[10], un miracolo di cui si può parlare termini biblici[11]. Quell’«angiola giovanissima»[12], è talmente virtuosa e nobile che non può mai far vacillare «lo fedele consiglio de la ragione»[13], dichiara il poeta innamorato.
Così Dante rovescia la tragica visione cavalcantiana, secondo cui l’amore è desiderio dei sensi e sottratto alla ragione, e si rifà a una lunga tradizione che vede l’amore come pura contemplazione priva di piacere sensibile e contingente[14]. In questo modo la moralità è intrinseca all’amore che Dante prova per Beatrice, il cui saluto non solo è fonte di beatitudine, ma anche di salvezza[15]. L’amore non potrà mai distogliere Dante da Dio, a differenza delle anime di Paolo e Francesca che, cedendo a un’emozione incontrollata, hanno rinunciato alla sua dimensione contemplativa e sono pertanto condannati per l’eternità al turbine del secondo cerchio dell’Inferno. Paolo e Francesca sono «i peccator carnali»[16], i lussuriosi, cioè coloro «che la ragion sommettono al talento»[17] e così facendo non hanno visto altro che l’amore, cedendo all’illusione secondo cui tutta la vita si può ridurre alla sola esperienza amorosa. Francesca che, mentre Paolo piange, racconta a Dante come lei e il suo amante si accorsero di essere innamorati, ha commesso l’errore di aver escluso ogni altro aspetto della persona per trasformare il sentimento d’amore in un’ossessione e se stessa in una schiava d’amore incapace di ragionare, come evidenzia l’anafora nel cosiddetto teorema amoroso di Francesca: «Amor, ch’al cor gentile ratto s’apprende, […] Amor, ch’a nullo amato amar perdona, […] Amor condusse noi ad una morte»[18].
Tuttavia, la forza dell’opera di Dante non risiede nell’impeccabilità di un pellegrino che, guidato dalla sua donna-angelo, dall’amata sublimata e trasformata in allegoria della fede e della teologia, si purifica da tutti i suoi peccati partendo dal basso, dal buio dell’Inferno e, ascendendo, arriva fino a Dio. La critica afferma che il personaggio di Dante non potrebbe purificarsi senza prima attraversare tutti i suoi peccati immedesimandosi nei vari personaggi che sceglie a rappresentarli, ma se ci accontentassimo solo di questo, continueremmo a vedere Dante come freddo e teorico teologo e non potremmo trovare la sua opera così contemporanea.
La potenza dei versi del poeta fiorentino, il coinvolgimento emotivo del lettore, la commozione del suo pubblico derivano dall’estrema umanità del Dante uomo, prima che scrittore, poeta, personaggio, ravvisabile nel protagonista, che di fronte alle fragilità dell’umanità peccatrice e condannata, prova pietà. Si tratta di una pietà terrena, non metafisica[19], che in qualche modo ricorda la pietas di Enea, quel misto di dovere, devozione, amore, rispetto verso gli avi, i genitori, i figli, le tradizioni, la patria, gli dèi, in nome della quale l’eroe virgiliano abbandona Didone e risponde alla missione che gli è stata affidata. La pietà di Dante è angoscia, smarrimento, commozione, turbamento e, osa Borges, invidia[20]. Invidia di quegli amanti che, pur nel peccato, pur avendo compiuto il «doloroso passo»,[21] pur lontano da Dio, sono destinati insieme per l’eternità. Invece Dante rinuncia a Beatrice, come Enea aveva rinunciato a Didone, e inventa la Commedia in qualche modo per, dice ancora Borges, introdurvi quell’incontro, l’incontro, almeno nella sua immaginazione, con la donna amata e sempre perduta. Eppure, quando arriva alla presenza di Beatrice, qualcosa non torna, la donna è raffigurata dallo scrittore severissima, lontana, inarrivabile, come inarrivabile era stata in vita, addirittura si prende gioco di Dante, lo umilia[22]. Dopo aver vissuto paura e angoscia nella selva oscura, dopo aver attraversato le pene nel regno delle ombre, aver osservato figure mostruose e aver assistito a punizioni terrificanti, dopo aver imparato la forza del pentimento e essere asceso cornice dopo cornice al monte del Purgatorio, dopo aver costruito un tale mondo dell’aldilà perfettamente coerente a se stesso esattamente per ritrovar la donna amata, ecco che l’incontro con Beatrice, tanto agognato, tanto anelato, è deludente, sembra difettare di qualcosa.

Non per il pellegrino Dante che raggiunge la salvezza – «tu m’hai di servo tratto in libertate»[23] –, ma per l’uomo innamorato che non raggiunge, neanche nella fantasia, ciò che gli è sempre mancato, la realizzazione dell’amore, il sentimento soddisfatto da Paolo e Francesca. Ecco che l’ultimo sorriso di Beatrice tradisce una certa malinconia, una tale tristezza, un senso di vuoto. Dante si rivolge a Beatrice, ma non la trova, è volata nella Rosa dei Giusti, è al massimo della sua esaltazione, eppure è sfuggente, distante, addirittura distoglie lo sguardo[24]. Dante l’ha persa per sempre. Paolo e Francesca resteranno abbracciati per l’eternità. Più Beatrice è esaltata, più Dante è vicino alla salvezza, più la soddisfazione del sentimento amoroso è lontano. In questo tratto di malinconia risiede la profondissima umanità della Commedia e con essa di tutta l’esperienza biografica e letteraria di Dante.
Se l’Inferno è un luogo «sanza stelle»[25] dove il desiderio permane, ma non può essere soddisfatto, (desiderio da de-, che è il prefisso privativo, e sidereus, cioè gli astri), è dunque un luogo della mancanza, della mancanza di Dio. Questa situazione però sembra rovesciarsi dal punto di vista del Dante scrittore e innamorato, il cui obiettivo principale era quello di rincontrare la donna amata, e come abbiamo visto la mancanza, la perdita di Beatrice avviene nel Paradiso, luogo pieno di stelle, dove «l’amor che move il sole e l’altre stelle» è l’amore del Divino.
La lettura che ne fa Borges ci aiuta a riportare lo scrittore vicino alla nostra umanità psicologicamente fragile, fisicamente debole, a volte disperata, smarrita. Dante nel poema, così come nella sua vita, trema, piange, si intimidisce, è fortemente impressionabile, è ansioso, sviene. Dante resta un vinto, come Enea, ma in Dante in quell’essere vinto e naufrago si scorge «la sua spaventosa inconciliabilità con il mondo»[26]: tutto il disagio vissuto nei confronti della vita, i suoi fallimenti in campo amoroso, in campo politico, nel rivestire un ruolo sociale, la difficoltà di trovare il suo posto[27]. Tutto questo diventa poesia e la poesia è al tempo stesso fragilità umana e cura dell’umana vulnerabilità.
Per conservare questo elevatissimo grado di umanità nella sua opera, Dante autore si distacca dal giudizio di Dio che non sempre coincide con il suo sentire, Dio che è al di là di ogni giudizio umano e al di là del bene e del male. Dio è definito nell’opera per la sua giustizia – «Giustizia mosse il mio alto fattore»[28] – e risulterebbe falso se replicasse la posizione di Dante, il quale accetta quel Dio, ma comprende l’uomo, delega alla Divinità la giustizia, ma mantiene per sé i sentimenti. Come se avesse spezzettato in migliaia di parti la sua persona e avesse fatto incarnare ognuna di queste parti a un personaggio del suo universo immaginario, Dante sceglie questa apparente contraddizione[29] anche come stratagemma narrativo, come tecnica di costruzione, come gioco illusorio utile al racconto, delegando quello che Borges chiama «il Terzo Personaggio»,[30] cioè Dio, per far dimenticare che dietro a ogni destinazione nel poema c’è sempre lui, come in un rimando di giochi di specchi.
A conclusione di questo ragionamento, due episodi realmente accaduti lontani nello spazio, più che nel tempo, confermano la profondissima umanità dell’opera dantesca e come la poesia sia l’unica cura possibile[31]. Umanissimo è il Dante che, nel 1938, un poeta deportato da Stalin per attività controrivoluzionaria nel gulag di Vtoraja rečka, nei pressi di Vladivostok, traduceva a memoria per i suoi compagni di sofferenza e di morte, insieme a Petrarca e Ariosto. È Osip Mandel’štam, che nel 1933 aveva scritto Conversazione su Dante, «un poema critico. Un poema sulla poesia di un grande del Medioevo, di un grande del Novecento – sulla poesia»[32].
È il 1944 quando ad Auschwitz, la «gran macchina per ridurci a bestie», l’ebreo italiano Primo Levi sceglie di recitare a memoria il canto XXVI dell’Inferno, quello di Ulisse, ammettendo con rimprovero, qualche errore o qualche lacuna, pur di ritrovare brandelli di quella umanità che i nazisti cancellavano nei prigionieri insieme al loro nome. Primo Levi in quell’inferno[33] comprende e lotta per non cedere ogni pezzetto di umanità ai nazisti, si impone di continuare una serie di gesti, si lava la faccia senza sapone nell’acqua sporca, si asciuga alla giacca, per non lasciare andare anche «il nostro consenso»[34], per conservare una briciola almeno di dignità. In un contesto che mira alla «demolizione di un uomo»[35] Levi recita l’esortazione dell’Ulisse dantesco ai suoi compagni e a tutti gli uomini: «Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza»[36]. Queste parole, risuonano forti come non mai, come se le sentisse per la prima volta, sono uno squillo di tromba che lo riporta alla vita, sono la voce di Dio che risveglia in lui il senso di civiltà scomparso nel lager[37]. Scegliendo la strada indicata da Ulisse e da Dante, dimentica per un momento «chi sono e dove sono»[38]. È il potere curativo della poesia[39]: recitando la Commedia, segue la strada «per restare vivi, per non cominciare a morire»[40].
Bibliografia
Alighieri Dante, La Commedia. Inferno, a cura di Bianca Garavelli, supervisione di Maria Corti, Bompiani, Firenze, 2001
Alighieri Dante, La Divina Commedia. Paradiso, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier, Firenze, 2002
Alighieri Dante, La Divina Commedia. Purgatorio, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier, Firenze, 2002
Alighieri Dante, Vita Nuova, Feltrinelli, Milano, 2021
Barbero Alessandro, Dante, Editori Laterza, Bari-Roma, 2020
Borges Jorge Luis, Nove saggi danteschi, Adelphi, Milano, 2021
Levi Primo, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 1989
Mandel’štam Osip, Conversazione su Dante, Adelphi, Milano, 2021 Stassi Fabio, E d’ogni male mi guarisce
[1] Cfr., Dante Alighieri, Vita Nuova, Feltrinelli, Milano, 2021, pag. 35: «[…] quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi da la fine del mio nono».
[2] Cfr., A. Barbero, Dante, Editori Laterza, Bari-Roma, 2020, p. 72 e G. Boccaccio, Trattatello I, 30-31.
[3] Cfr., Dante Alighieri, Vita Nuova, op. cit., pag. 35: «Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e orata a la guisa che la sua giovanissima etade si convenia».
[4] Cfr., ibidem, pp. 35-36: «In quello punto dico veracemente che lo spirito de la vita, lo quale dimora ne la secretissima camera de lo cuore, cominciò a tremare sì fortemente, che apparia ne li menimi polsi orribilmente; e tremando disse queste parole: “Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur michi”».
[5] Cfr., A. Barbero, op.cit., p. 72.
[6] Dante affronta anche il tema del rapporto tra letteratura e morale centrale nella cultura medievale.
[7] Cfr., Dante Alighieri, Vita Nuova, op. cit., pag. 38.
[8] Cfr., id., Purgatorio, XXVI, vv. 97-98.
[9] G. Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore, in Poesie dello stilnovo, a cura di M. Berisso, BUR, Milano, 2006, pag. 79.
[10] Sublimato, agg., usato qui nel significato di “esaltato”, “reso sublime”.
[11] Cfr. in particolare il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare, vv. 5-6 («e par che una cosa venuta / da cielo in terra a miracol mostrare»), dove Beatrice palesa la sua essenza miracolosa, e Purgatorio XXX, vv. 19-21 («Tutti dicean: “Bendeictus qui venis!”, / e fior gittando e di sopra e dintorno, / Manibus, oh, date lilia plenis»), dove, evocata l’apparizione di Beatrice, ella viene identificata con Cristo poiché nella vita di Dante la donna amata ha assolto per il poeta la stessa funzione di Cristo nella storia dell’umanità.
[12] Cfr., Dante Alighieri, Vita Nuova, op. cit., pp. 37-38.
[13] Ibidem, pag. 38.
[14] Cfr., ibidem, pag. 38, nota 45.
[15] Beatrice è signora che concede il saluto (it. antico “salute”) e insieme fonte di salvezza (it. antico “salute”). L’etimologia delle parole è la stessa, dal latino salus, salutis che vuol dire “salute”, “salvezza”. Beatrice quando saluta Dante gli dà anche salvezza: «conobbi ch’era la donna de la salute, la quale m’avea lo giorno dinanzi degnato di salutare». Cfr., Dante Alighieri, Vita Nuova, op. cit., pag. 38 e nota 30.
[16] Id., Inferno, V, v. 38.
[17] Ibidem, v. 39. Talento: latinismo per “passione”, tutto ciò che è emozione incontrollata; in riferimento all’amore non acceso da virtù e non indirizzato a Dio.
[18] Ibidem, vv. 100-106.
[19] Cfr., F. Stassi, E d’ogni male mi guarisce un bel verso, Sellerio, Palermo, 2023, pag. 21.
[20] J.L. Borges, Nove saggi danteschi, Adelphi, Milano, 2021, pag. 128.
[21] Dante Alighieri, Inferno, V, v. 114.
[22] Cfr., id., Purgatorio, XXX, in particolare vv. 55-57: «“Dante, perché Virgilio se ne vada, / non pianger anco, non piangere ancora; / che pianger ti conven per altra spada”», e Purgatorio XXXI.
[23] Id., Paradiso, XXXI, v. 85.
[24] Ibidem, vv. 91-93: «Così orai; e quella sì lontana / come parea, sorrise e riguardommi; / poi si tornò a l’etterna fontana».
[25] Id., Inferno, III, v. 23.
[26] F. Stassi, op. cit., p. 44.
[27] Cfr., ibidem, pag. 44.
[28] Dante Alighieri, Inferno, III, v. 4.
[29] Cfr., J.L. Borges, op. cit., pag. 53 e ss.
[30] Ibidem, pag. 128.
[31] F. Stassi, op. cit., pag. 23.
[32] S. Vitale, «Io pur sorrisi…», in O. Mandel’štam, Conversazione su Dante, Adelphi, Milano, 2021, p. 9.
[33] «Questo è l’inferno. Oggi, ai nostri giorni, l’inferno deve essere così, […] e noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile e non succede niente e continua a non succedere niente». P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 1989, pag. 19.
[34] P. Levi, op. cit., pag. 36.
[35] Ibidem, pag. 23.
[36] D. Alighieri, Inferno,XXVI, vv. 118-120.
[37] Cfr., P. Levi, op. cit., pag. 35: «Anche in questo luogo si può sopravvivere, e perciò si deve voler sopravvivere, per raccontare, per portare testimonianza; e che per vivere è importante sforzarci di salvare almeno lo scheletro, l’impalcatura, la forma della civiltà».
[38] P. Levi, op. cit., pag. 102.
[39] Cfr., ibidem, pag. 102: «Si è accorto che mi sta facendo del bene».
[40] Ibidem, pag. 36.
Questo testo viene pubblicato nella sezione “Rivista Nuova Euterpe” del sito “Blog Letteratura e Cultura” perché selezionato dalla Redazione della Rivista “Nuova Euterpe”, n°02/2024. L’autrice ha autorizzato alla pubblicazione senza nulla avere a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro.