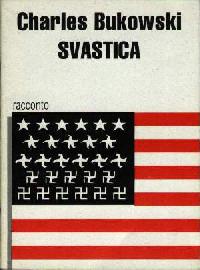“Vita, morte e miracoli di un uomo qualunque” di Matteo Deraco, recensione di Lorenzo Spurio
La gente è solo capace a etichettarti, spremerti, prendere e prendere e prendere, e se prendi prima o poi devi pure dare. Al contrario, quando dai non sempre arriva qualcosa.
 La narrazione si apre con il protagonista alle prese con due gravi disdette dalla vita: l’abbandono della compagna e l’esser licenziato. I due fatti chiarificano da subito l’animo deluso e scoraggiato del protagonista che deve fare i conti, più che con un semplice licenziamento lavorativo, con un vero e proprio “licenziamento dalla vita”: privato di amore e lavoro, infatti, si sente deluso e questa condizione anima in lui una serie di pensieri e convincimenti con i quali sembrerebbe chiudersi a riccio dal mondo. In realtà la fine del suo rapporto di lavoro non è vissuta come dramma dato che subito, con chiari ed espliciti riferimenti a Bukowski e alla beat generation, osserva «ma davvero non me ne fregava poi molto del lavoro».
La narrazione si apre con il protagonista alle prese con due gravi disdette dalla vita: l’abbandono della compagna e l’esser licenziato. I due fatti chiarificano da subito l’animo deluso e scoraggiato del protagonista che deve fare i conti, più che con un semplice licenziamento lavorativo, con un vero e proprio “licenziamento dalla vita”: privato di amore e lavoro, infatti, si sente deluso e questa condizione anima in lui una serie di pensieri e convincimenti con i quali sembrerebbe chiudersi a riccio dal mondo. In realtà la fine del suo rapporto di lavoro non è vissuta come dramma dato che subito, con chiari ed espliciti riferimenti a Bukowski e alla beat generation, osserva «ma davvero non me ne fregava poi molto del lavoro».
E’ palpabile l’intenzione di Deraco di raffigurare nel romanzo il senso di incertezza lavorativa della nostra attualità e infatti nelle prime pagine osserva: «Anzi, con la depressione galoppante, il senso d’inutilità e di precariato, il senso d’immobilismo e di fallimento, di volta in volta facevi un passetto indietro.» Quadretto quanto mai realistico e deprimente della nostra realtà dove il precariato, la disoccupazione e il tormento sono manifestazioni comuni ed universali. Deraco vede la vita attraverso il lavoro o, meglio, attraverso la mancanza di esso e la descrive come una serie di vicende momentanee che hanno un inizio e una fine (lavori per un po’, poi ti cacciano) che descrivono ciclicamente l’impegno dell’uomo nel darsi da fare, cercare lavoro e a volte addirittura inventarselo, farsi “la gavetta”, anche se spesso neppure questa conta.
Il linguaggio colorito e giovanile (la parola “cazzo” ricorre con una smodata frequenza) si sposa con una narrazione che non ha grandi pretese se non quella di un giovane di guardare con i suoi occhi il mondo che lo circonda, in maniera sfiduciata e poco combattiva, dopo tante “sconfitte” subite, provate sulla propria pelle. I rimandi, sia tematici che linguistici, a Bukowski, il padre della letteratura contemporanea che con spregiudicatezza e sagacia sconfessò le difficoltà, i drammi, le collusioni del mondo lavorativo, sono palpabili a più livelli e in maniera chiara. Lo stesso titolo del romanzo nel quale si dice “di un uomo qualunque” vuol forse sottolineare la specificità di un essere vivente garantendone l’anonimato che, però, vive una condizione che non gli è esclusiva e che, invece, è generalizzata e abbastanza comune. L’uomo qualunque, dunque, siamo noi e tutte quelle persone che possono ritrovarsi nei pensieri che l’io narrante fa.
Vi sono considerazioni anche piuttosto forti come quella ai nostri padri, che hanno fatto il ’68 e si ritrovano ora, nella loro attualità a “fregarsene” che non mi sento di condividere, ma che può essere una lecita osservazione o lo sguardo critico e a tratti sfrontato nei confronti della religione: « Dio non c’era, e per quel che mi riguardava non c’era mai stato. Dio era solo una stampella psicologica da tirare fuori nel momento del bisogno, e poi rimettere via quando non serviva più». Il protagonista vedrà Dio nell’immagine della suora che condivide con lui lo scompartimento del treno, nel Cristo di Maratea, ma anche nelle valige, nell’alcool, in episodi di fortuna e tanto altro, chiarificando il suo panteismo laico e l’utilizzo di “Dio” quale personaggio sui generis al quale demandare fortune/sfortune (si ricordi, ancora, Bukowski).
Il protagonista è un uomo arrabbiato, che non crede nei compromessi e nelle bieche leggi dell’oggi, ma finisce per apparire poco combattivo e partecipativo: l’unico gesto di tutto il romanzo in cui sembra prendere una decisione realmente importante è quando decide di lasciare la sua ragazza. Per il resto si gongola nel disprezzo verso il mondo, nella critica e nell’autocritica, nell’analisi della tragica condizione del momento, descrivendola, schifandosene senza, però, “attuare” in una qualche maniera significativa sulla sua esistenza. E’ un osservatore del mondo, a distanza, quasi un vouyer, ma raramente entra in quel mondo per agire da protagonista con consapevolezza.
Animo inquieto e sprezzante, indifferente agli altri e soprattutto ai giudizi del mondo, ricorda appunto il celebre Chinaski: «Me ne fregavo, come me ne fregavo di tutto il resto»; il protagonista nutre un atteggiamento sconsiderato, narcisista e violento tanto da arrivare a sviscerare nelle prime pagine del libro la sua indisposizione e animosità nei confronti dell’intero mondo (misantropia): «Avrei sterminato tutti i commessi delle poste lenti, tutti gli stronzi che suonavano il clacson, tutte le vecchie in fila alla cassa al supermercato. Mi toglievano aria, mi levavano vita». Il lettore pagina dopo pagina si chiede se in realtà il comportamento ossessivo e meticoloso del ragazzo nei confronti di Chiara, l’ex-ragazza, non sia eccessivo e preoccupante e se la sua narrazione sia vagliata da una mente instabile, che vede le persone/la società in maniera distorta che allo stesso tempo imputa l’errore negli altri facendo poca autoanalisi. E’ lo stesso ragazzo ad osservare nel cuore della narrazione: « Fondamentalmente ero un egocentrico del cazzo e un sociopatico».
Domina un linguaggio giovanile, scanzonato e molto colorito con chiari e continui rimandi alla “poetica” di Bukowski e una serie di modi di dire e “frasi fatte” sgranate con gratuità al lettore; numerose anche le citazioni a pezzi di canzoni e ad autori italiani e stranieri (Ligabue, Vasco, Negramaro, Fabrizio De André, Radiofreccia, Guccini, Guns’n’roses), come pure ai film (L’ultimo bacio, V per vendetta).
Un romanzo atipico ed effervescente di un giovane e delle sue visioni sul mondo. Un’analisi nelle pieghe del proprio io che, al termine delle vicende narrate, lo porterà ad osservare il mondo con uno sprizzo di lucidità: «Fino a quel momento non ne avevo fatto entrare poi molte, di persone, all’interno del mio mondo».
Una scrollata al sé, e una maggiore consapevolezza del vivere nel hit et nunc.
(scrittore, critico-recensionista)
Jesi, 4 Luglio 2013
E’ SEVERAMENTE VIETATO DIFFONDERE E/O PUBBLICARE LA PRESENTE RECENSIONE SENZA IL PERMESSO DA PARTE DELL’AUTORE.
“Pulp, una storia del XX secolo” di Charles Bukowski, recensione di Lorenzo Spurio
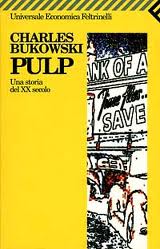 Se qualcuno ci regalasse questo libro privato della copertina e quindi del nome dell’autore, non faremmo nessuna difficoltà, già a partire dalla prime pagine, a capire che lo scrittore è Charles Bukowski. Non tanto perché lo scrittore americano, uno dei più popolari e contestati degli ultimi trenta anni, sia facilmente individuabile per la presenza di una serie di topos che ricorrono nelle sue opere ma è la sua scrittura fredda, diretta, concisa, tagliente, sviluppata soprattutto al livello dell’oralità, del parlato, che ci rendono palese la paternità dell’opera.
Se qualcuno ci regalasse questo libro privato della copertina e quindi del nome dell’autore, non faremmo nessuna difficoltà, già a partire dalla prime pagine, a capire che lo scrittore è Charles Bukowski. Non tanto perché lo scrittore americano, uno dei più popolari e contestati degli ultimi trenta anni, sia facilmente individuabile per la presenza di una serie di topos che ricorrono nelle sue opere ma è la sua scrittura fredda, diretta, concisa, tagliente, sviluppata soprattutto al livello dell’oralità, del parlato, che ci rendono palese la paternità dell’opera.
Pulp (letteralmente “pasticcio”) è un romanzo pubblicato nel 1994. Si tratta di una narrazione un po’ diversa da quelle di Post Office (1971) o Factotum (1975), che potremmo definire più tipicamente bukowskiane per diversi motivi. Il protagonista non è il beone, burlone e spregiudicato Henry Chinaski, alter ego dell’autore presente nelle sue più grandi narrazioni ma un certo Nick Belane. Belane è un agente delle investigazioni segrete e, benché agli occhi di tutti sia un completo inetto, si definisce «il detective più dritto di Los Angeles e Hollywood» (32-33). Nel romanzo ci vengono descritte le varie peregrinazioni, appostamenti, incontri, che Belane fa su commissione da parte di tre clienti che lo chiamano in aiuto. Alla maldestrità del personaggio, al poco rispetto per le leggi, alle ubriacature e alla sua facilità di venire alle mani si sommano così tre microstorie che riguardano tre diverse investigazioni, tutte al limite del surreale: una donna che viene fatta seguire perché il marito teme che lo tradisca; un uomo disperato che chiede a Belane di dare alla caccia all’alieno donna che lo perseguita e le ricerche per un certo Passero Rosso. Tutte e tre le ricerche sembrano non portare a nessun risultato e Belane si troverà spesso alle prese con minacce, ricatti, tradimenti, estorsioni, imbrogli, vendette e veri e propri scenari violenti: scazzottate e sparatorie (si ricordi che l’edizione originaria del romanzo aveva in copertina raffigurata una pistola fumante). Lo stesso Belane, in quanto agente privato, dispone di una sua arma e sembra essere sempre troppo facile a sfoderarla per finir poi per subire i soprusi o gli inganni degli altri.
Belane è un inetto in tutto: ha alle spalle tre matrimoni che, a detta sua, sono finiti per semplici incomprensioni, ma nemmeno il ritorno sulla scena di una sua ex moglie sembra tirarlo fuori da quel clima di depressione e vittimismo che si è creato addosso, arrivando persino a considerare il suicidio. Non mancano le amate scommesse ai cavalli, marchio di fabbrica di Bukowski e i riferimenti al bere, all’ubriacarsi, all’alcolismo mentre il sesso, tema da sempre caro a Bukowski è sì presente, ma in forma diversa. Belane, infatti, non è un donnaiolo, non è uno ossessionato dal sesso, pronto a corteggiare una donna oppure a prendersela per sé con la forza. Riferimenti al sesso sono sparsi qua e là nel romanzo, ma Belane non è mai coinvolto in un amplesso amoroso. Neppure quando l’ex moglie gli propone, in cambio di 20 dollari, una prestazione orale lui accetta. Sotto questo punto di vista Belane è un Chinaski molto più cauto e meno ossessionato dal tema. Non mancano però riferimenti ad un sesso perverso quando l’autore, ricordando un episodio del passato con alcune prostitute, osserva: «Le avevo portate tutte a casa mia e una di loro aveva masturbato il mio cane» (16). Il sesso in questo romanzo, sembra suggerire Bukowski, riguarda gli altri, quelli che circondano il personaggio, ma non lui come quando osserva due mosche che stanno copulando.
Con molta difficoltà e con una serie di episodi altamente pericolosi, carichi di violenza, Belane riuscirà nelle sue tre investigazioni ma l’ultima, la più difficile, quella del Passero Rosso, gli costerà la vita. Ecco perché si diceva all’inizio della recensione che questo romanzo si distanzia da quelli tipicamente bukowskiani: abbiamo un personaggio poco legato al mondo del sesso, è un incapace, non riesce a far valere le sue ragioni, non predomina sugli altri e, al contrario, è un debole e finisce lui per esser sopraffatto. E’ Belane stesso a riconoscersi come «un investigatore privato che era dritto ma non risolveva niente» (52). Alla fine, come si è detto, riesce nei suoi scopi, ma al prezzo della sua propria vita. Non è un eroe né un martire, rimane un poveraccio qualsiasi, senza un soldo né un affetto. La sua morte, più che esser un fatto tragico, viene così ad essere una sorta di salvataggio di Belane da quel mondo degradato, triste, desolato e crudele del quale ha fatto parte.
E così Bukowski ci consegna, forse, uno dei romanzi più interessanti ed intrecciati, stanco forse dell’invincibile e sfrontato Chinaski per presentarci, invece, un uomo che, pur incapace, si dà da fare per riuscire in qualcosa e fronteggiare quel mondo dove domina violenza e logica del denaro. Non è forse un caso che Pulp sia l’ultimo romanzo dell’autore, pubblicato appena pochi mesi prima del sua decesso, quasi che l’autore abbia voluto scherzare con la propria morte. Lo scrittore ci consegna questo “pasticcio” curioso in cui, a certi livelli ha condensato tutti i temi a lui carichi costruendo una storia che è semplice ma, paradossalmente, allo stesso tempo complessa.
E’ SEVERAMENTE VIETATO DIFFONDERE E/O RIPRODURRE LA PRESENTE RECENSIONE SENZA IL PERMESSO DELL’AUTORE.
“Stabili Equilibri Precari” di Francesco Montalto
 Il libro d’esordio di Francesco Montalto “Stabili Equilibri Precari” è da qualche giorno online. E’ un libro di poesie, che racchiude, come lui stesso dice, i tre ultimi anni della propria vita e le sensazioni che questi hanno portato dietro. Si respira un’atmosfera cupa, di perenne instabilità, inquietudine e turbamento, tra i versi di Stabili Equilibri Precari, ma anche di estrema consapevolezza. Versi che lasciano trasparire tutto l’ignoto che le varie esperienze di vita portano con se. C’è l’ombra di un Charles Bukowski moderno, ma anche la visionaria passione di Jim Morrison e la speranza e disillusione di Emily Dickinson. Soprattutto però, c’è la sensibilità di un animo estremamente umano e la sincerità nel raccontare pulsioni e sentimenti quotidiani, di una persona normale, che per fortuna (o sfortuna) vive spesso un mondo parallelo a quello reale, guardando dall’esterno ma senza presunzione e sicuramente senza nessuna invidia, tutto quello che ruota intorno a se, non sentendosene parte e nello stesso tempo rendendosi conto che in fondo molti sentimenti sono comuni a tanti, e magari vissuti in maniera diversa e senza spesso rendersene conto, sono pur sempre universali.
Il libro d’esordio di Francesco Montalto “Stabili Equilibri Precari” è da qualche giorno online. E’ un libro di poesie, che racchiude, come lui stesso dice, i tre ultimi anni della propria vita e le sensazioni che questi hanno portato dietro. Si respira un’atmosfera cupa, di perenne instabilità, inquietudine e turbamento, tra i versi di Stabili Equilibri Precari, ma anche di estrema consapevolezza. Versi che lasciano trasparire tutto l’ignoto che le varie esperienze di vita portano con se. C’è l’ombra di un Charles Bukowski moderno, ma anche la visionaria passione di Jim Morrison e la speranza e disillusione di Emily Dickinson. Soprattutto però, c’è la sensibilità di un animo estremamente umano e la sincerità nel raccontare pulsioni e sentimenti quotidiani, di una persona normale, che per fortuna (o sfortuna) vive spesso un mondo parallelo a quello reale, guardando dall’esterno ma senza presunzione e sicuramente senza nessuna invidia, tutto quello che ruota intorno a se, non sentendosene parte e nello stesso tempo rendendosi conto che in fondo molti sentimenti sono comuni a tanti, e magari vissuti in maniera diversa e senza spesso rendersene conto, sono pur sempre universali.
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=779352#.T_Aiqfgt-Oc.facebook
“Vedere” di Mattia Zadra
Vedere di Mattia Zadra
Cicorivolta Edizioni, 2010, pp. 163
ISBN: 9788895106984
Recensione di Lorenzo Spurio
 Il romanzo d’esordio di Mattia Zadra, Vedere, è un misto di comportamenti anomali, incongruenze ed espressione di una realtà periferica e degradata. Il titolo richiama direttamente uno dei cinque sensi, quello della vista, ma nel corso della narrazione l’autore più volte sottolinea che “guardare” e “vedere”, che potrebbero essere considerati come semplici sinonimi, in fondo non sono la stessa cosa. Kyle (forse inspirato da uno dei personaggi di South Park?), infatti, più volte “guarda” ma raramente riesce a “vedere”, quasi che l’atto visivo non sia semplicemente qualcosa di meccanico ma che, in qualche modo, venga vagliato dalla sfera emotiva.
Il romanzo d’esordio di Mattia Zadra, Vedere, è un misto di comportamenti anomali, incongruenze ed espressione di una realtà periferica e degradata. Il titolo richiama direttamente uno dei cinque sensi, quello della vista, ma nel corso della narrazione l’autore più volte sottolinea che “guardare” e “vedere”, che potrebbero essere considerati come semplici sinonimi, in fondo non sono la stessa cosa. Kyle (forse inspirato da uno dei personaggi di South Park?), infatti, più volte “guarda” ma raramente riesce a “vedere”, quasi che l’atto visivo non sia semplicemente qualcosa di meccanico ma che, in qualche modo, venga vagliato dalla sfera emotiva.
Interessante l’elaborazione del plot che Zadra prevede per il suo romanzo, che si gioca su di diversi piani temporali; c’è un prima e un dopo, un passato e un presente, che però non sono distanziati e che l’autore, con una tecnica quasi cinematografica, amalgama ad intervalli. Sebbene il passato non sia altro che l’origine o la causa del nostro presente, in questa narrazione non sembra essere così. Il personaggio, Kyle, è un uomo che vive da solo, sempre inquieto e che, pur avendo diversi amici, è maledettamente solo. La sua ragazza, con la quale aveva preso un appartamento in cui andar a vivere, è ferma da un anno sul letto di un ospedale in stato vegetativo. Lui continua a visitarla tutti i giorni, portandole una rosa. Fin qui niente di strano, potrebbe sembrare una drammatica storia stile Almodovar ma poi Kyle si attornia dei suoi vecchi amici, ubriaconi, violenti, truffatori e si rende lui stesso protagonista di una serie di atteggiamenti perseguibili penalmente come quando l’amico, animato da un grande odio di classe (da cui traspare, forse, l’idee rivoluzionarie e oltranziste dello stesso Zadra) lo coinvolge, sotto stato di ebbrezza, a spaccare auto che secondo lui sono dei “figli di papà”. Le sue giornate si susseguono sempre uguali, tra il lavoro, la visita in ospedale e l’incontro al mercoledì con l’amico Mark e, paradossalmente, l’unica cosa più importante per il protagonista è quella di dar da mangiare al gatto. Impossibile non respirare degli echi bukowskiani nella scrittura, soprattutto nei confronti dell’alcool e del mondo lavorativo all’interno del quale Kyle è sempre insoddisfatto, riluttante e fuggitivo e a Chuck Palahniuk, riconosciuto dallo stesso autore come “maestro”. Singolarmente, però, anche la religione fa capolino dal romanzo quando Kyle, inconsapevolmente, decide di prender parte al funerale di un uomo che non conosce scoprendosi addirittura addolorato per quella morte. E’ un semplice modo di Zadra per dirci che gli errori possono essere espiati con semplicità appellandoci alla religione? Non lo sappiamo.
Proseguendo nella lettura, nel lettore si fa sempre più viva la convinzione che l’autore cerchi di depistarlo, raccontando cose che in realtà non sono successe e che, invece, rappresentano solo delle visioni, dei sogni, dei fantasmi di Kyle come le voci che sente nella stanza d’ospedale dove si trova l’amata benché la stanza sia completamente vuota («Penso alle voci. Penso al perché io le senta, ma non riesco a darmi una risposta», pag. 71) o il palazzo di fronte casa sua demolito o forse collassato su se stesso senza che nessuno si dia da fare per salvare le persone rimaste intrappolate. Zadra crea, così, attorno al personaggio un’atmosfera sospesa, surreale, sonnambula che non riusciamo a comprendere del tutto, sottolineando anche la fallibilità della sfera sensoriale dell’uomo. Tuttavia, il riferimento al “sentire le voci”, alle allucinazioni auditive, che potrebbe essere perfetto per una trama gotica o comunque a un thriller psicologico (vedi film come The Others o Haunting-Presenze), sembra qui non essere troppo adatto per esser sostenuto dalla trama anche se, ci consente di inserire il personaggio all’interno di una possibile psicologia disturbata, uno stato di depressione bipolare.
Il linguaggio utilizzato è semplice e facilmente accessibile a tutti, non manca di utilizzare parole colorite ed espressioni giovanili molto comuni; la narrazione procede per sbalzi temporali ma questo non crea difficoltà a seguire e ci consente invece di dare uno sguardo complessivo alla vita di Kyle. Il personaggio è molto ben strutturato ma anche molto sfaccettato: da una parte è l’uomo sensibile, romantico, poetico e innamorato della sua donna, dall’altro è l’amico del disgraziato (e quindi disgraziato lui stesso), il beone, il teppista, l’eterno insoddisfatto. E’ curioso come Zadra riesca a coniugare con meticolosità queste due sfaccettature del suo carattere forse facendo proprio riferimento ai due piani temporali usati. Il passato visto come momento felice, spensierato, bello, da innamorato e il presente vissuto in maniera sregolata, viziata, degradata forse proprio perché il passato gli ha tolto la cosa più bella della sua vita, la sua donna.
E quelle crepe che Kyle vede prima nella stanza d’ufficio, poi in chiesa, in ospedale e nei vari palazzi del suo quartiere sono forse il segno più concreto dell’incrinarsi della sua interiorità mentale a causa di un trauma doloroso e del suo stato di depressione. Forse. Al lettore il compito di sviscerarlo.
a cura di LORENZO SPURIO
E’ SEVERAMENTE VIETATA LA RIPRODUZIONE DI STRALCI O DELL’INTERA RECENSIONE SENZA IL PERMESSO DA PARTE DELL’AUTORE.
Chinaski il nazista
Charles Bukowski con le sue storie di vita sregolata e maledetta ci ha abituato ad atteggiamenti licenziosi o sessualmente deviati, degrado, emarginazione, isolamento, alcolismo e comportamenti maniacali. Il suo principale beniamino, Henry Chinaski, è spesso ritratto mentre si sta ubriacando con della birra scadente o con degli scoli di whisky di bottiglie che sono disseminate in casa sua o mentre fa sesso con le sue donne descrivendoci la componente più animalesca e tralasciando quella passionale. In ogni caso, in ciascuna storia si sottolinea il temperamento qualunquista del personaggio, il suo menefreghismo verso gli altri e il suo comportamento sfrontato e irriverente nei confronti degli altri. E di se stesso.
La critica si spacca sostanzialmente in due circa l’analisi di Chinaski e del suo creatore, tra coloro che lo bollano come ossessionato al sesso, manesco, insofferente agli obblighi lavorativi, immagine di una vita degradata e allucinata e che lo pongono in una condizione di reietto e coloro che invece ne analizzano il personaggio più a fondo, sviscerandolo dalla sua etichetta di barbone manesco e sottolineandone le carenze, la complessa strutturazione del personaggio e l’origine delle condizioni d’indigenza. A Chinaski sono state date le più varie caratterizzazioni (tutte abbastanza negative). E’ stato detto che è un maniaco, un barbone, un mitomane, un reietto, un sex-addicted, un emarginato, una sorta di diavolo, un criminale, un violento, un alcolizzato, un maschilista, un animale e tanto altro. Alcuni hanno aggiunto che è un nazista.
Va sottolineato il fatto che né Chinaski né Bukowski hanno mai espresso pubblicamente, al contrario di molti altri autori, una chiara posizione politica. Chinaski si scaglia sia contro gli hippy ultrasinistroidi che contro i borghesi, sia contro i suoi capi di lavoro che contro persone che conducono esistenze economicamente disagiate. Non critica particolari strati della società ma critica la società nel suo complesso. Non esprime un’idea politica né evoca un modello di stato che secondo lui potrebbe essere migliore rispetto ad un altro. Alcuni hanno visto nel temperamento violento, maschilista e insensato di Chinaski alcuni elementi comuni al comportamento dei fedeli del nazismo. Va ricordato che Bukowski nacque in Germania, paese che lasciò nei primi anni della sua infanzia per stabilirsi a Los Angeles. Nel romanzo autobiografico Ham on Rye (1982) Chinaski ripercorre i momenti cruciali della sua infanzia: il difficile rapporto con i genitori, l’isolamento nel contesto periferico, l’emarginazione a scuola e l’amicizia con pochi ragazzi tra cui Crapa Pelata, la scoperta del corpo e l’interessamento all’universo femminile. Traccia in un certo senso la biografia stessa di Bukowski ed è una narrazione atipica all’interno della sua produzione perché, contrariamente al suo stile, mancano le scopate e le alcolizzate tanto frequenti nelle altre opere. Il capitolo cinquantadue del romanzo appena citato ci parla di Chinaski e del nazismo. Può pertanto essere considerato un primo punto di contatto tra i due universi. In questo capitolo si dice che la guerra in Europa era favorevole a Hitler e che alla scuola gli insegnanti erano tutti nemici alla Germania e sinistroidi. Chinaski non è nazista, considera il nazismo come un’eventuale possibilità di scelta non per motivazioni politiche ma per motivazioni tutte personali:
«Forse, con Hitler al governo, mi sarebbe toccata un po’ di fica ogni tanto, e magari qualcosa di più del dollaro alla settimana che mi passavano i miei genitori. Non avevo niente da perdere. E poi, essendo nato in Germania, non me la sentivo di tradire il mio paese d’origine, e non mi andava di vedere l’intera nazione tedesca, l’intero popolo tedesco, demonizzati e dipinti nelle tinte più fosche» *.
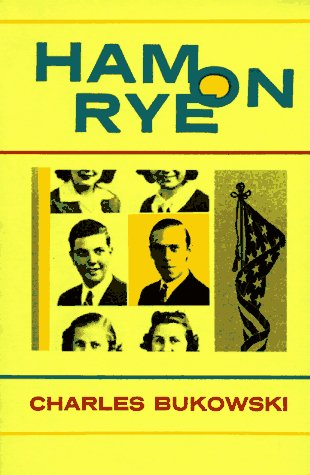 Se decidiamo di definire Chinaski nazista dobbiamo anche dire che non è nazista politicamente parlando ma per motivazioni astruse: per la sua comune origine tedesca e per il fatto che immaginando di poter essere devoto al Fuhrer potrebbe ottenerne dei vantaggi: soldi e fica. Il suo essere nazista è motivato dal suo desiderio di sentire e mostrarsi diverso dagli altri (gli insegnanti sinistroidi), è semplicemente un modo per differenziarsi da persone che non ama. («Per pura alienazione, e naturale spirito di contraddizione, mi trovai schierato contro il loro punto di vista» ).
Se decidiamo di definire Chinaski nazista dobbiamo anche dire che non è nazista politicamente parlando ma per motivazioni astruse: per la sua comune origine tedesca e per il fatto che immaginando di poter essere devoto al Fuhrer potrebbe ottenerne dei vantaggi: soldi e fica. Il suo essere nazista è motivato dal suo desiderio di sentire e mostrarsi diverso dagli altri (gli insegnanti sinistroidi), è semplicemente un modo per differenziarsi da persone che non ama. («Per pura alienazione, e naturale spirito di contraddizione, mi trovai schierato contro il loro punto di vista» ).
E nello stesso capitolo rende ancora più chiaro che in realtà non ha niente di nazista:
«Evitavo accuratamente ogni riferimento diretto a negri ed ebrei, che, poveretti, non mi avevano mai dato rogne. Tutte le rogne che avevo avuto me le avevano date i bianchi ariani. Quindi, non ero nazista per carattere o per scelta; erano gli insegnanti, ad appiccicarmi addosso quell’etichetta, con il loro atteggiamento conformista, le loro idee conformiste e i loro pregiudizi antitedeschi» .
C’è da concludere che se possiamo definire Chinaski un nazista, non è un nazista con mitra in pugno o pronto ad urlare o a deportare gente in campi di concentramento. E’ un nazista strano, che cerca di difendere la sua ideologia in maniera strumentale e per nulla politica.
Lo studioso Raffaele Gramegna** in un testo ha evidenziato il fatto che il racconto Svastika incluso nella raccolta Tales of Ordinary Madness (1983), nella sua versione italiana Storie di ordinaria follia non è stato incluso nella raccolta. Ha tentato di analizzarne il motivo contattando direttamente le case editrici italiane che avevano stampato l’opera nella versione tradotta e tutte hanno risposto tergiversando ed eludendo la domanda del critico. L’interpretazione più ovvia è quella di considerare il fatto che un titolo così scomodo e un racconto nel quale si parlasse di Hitler collegandolo alla politica americana non poteva essere stampato e divulgato. La mancanza del racconto nella raccolta è dunque non il segno di una svista grossolana ma quello dell’imposizione di una censura. Raffaele Gramegna dopo un’interessante introduzione al racconto in questione ha riportato il racconto nella sua lingua originale e poi tradotto da lui in italiano.
Si tratta di un racconto profondamente diverso dallo stile tipicamente buwoskiano: manca un’ambientazione periferica degradata, mancano riferimenti al bere e alla voglia di ubriacarsi, mancano le tanto amate corse dei cavalli e addirittura il sesso. Se a vari lettori amanti dell’autore venisse proposto di leggere questo racconto senza rivelare chi l’ha scritto probabilmente nessuno indovinerebbe che si tratta proprio di Bukowski.
Il racconto è breve, diretto e incisivo e utilizza ampiamente il discorso diretto. Il personaggio principale non è Chinaski ma in questo caso il protagonista è il presidente degli Stati Uniti che all’apertura del racconto viene sequestrato da agenti della polizia. Viene condotto in un appartamento dove si trova dinanzi il Fuhrer sebbene sia molto invecchiato. Per mezzo di due medici chirurghi tedeschi, il presidente viene sottoposto a una operazione di scomposizione e congiunzione di parti di corpi diversi che ci fa pensare a Frankenstein. E’ un operazione senza dolore, che non lascia cicatrici e che consente il cambio di personalità tra il presidente americano e il Fuhrer.
Il racconto andrebbe analizzato più approfonditamente a più livelli. Sembra stupido a questo punto considerare come la censura abbia potuto tagliare un racconto di Bukowski per la presenza di elementi fastidiosi (la svastica del titolo, la presenza del Fuhrer) quando nella contemporaneità abbondano testi che utilizzano la storia o particolari momenti di essa in chiave revisionista o negazionista. Bukowski è uno scrittore e le storie che racconta sono frutto del suo ingegno.
E’ sempre difficile affibbiare a una persona una determinata ideologia politica, un pensiero sulla società basandosi sui suoi atteggiamenti e le sue parole che possono rivelarsi in questo contesto anche contrastanti. La questione si fa ulteriormente più difficile nel caso di Bukowski che è sempre stato lontano dai temi politici e un acre criticatore di ogni ambito e rango del sistema sociale.
Il suo anticonformismo, il suo temperamento che lo porta continuamente a rompere schemi e commettere crimini e reati, la sua sfrontatezza nei confronti della vita, il suo marcato individualismo non ci consentono di individuare nella sua persona un’ideologia reazionaria né tantomeno nazista come è stato a volte sostenuto dalla critica. La sua critica contro tutto e tutti, compreso se stesso, potrebbe paradossalmente avvicinarlo ad un’ideologia confusa come quella anarchica. Si tratta ovviamente di interpretazioni vaghe e paradossali che sottolineano ancora una volta quanto la sua persona e quella di Chinaski siano variegate e complesse e prive di una chiara dimensione politica.
* Le citazioni sono tratte da Charles Bukowski, Panino al prosciutto, Milano, Tea, 2010, pp. 272-273.
** Charles Bukowski, Svastica (a cura di Raffaello Gramegna), Viterbo, Millelire Stampa Alternativa, 1994. Questo testo può essere letto on-line o scaricato collegandosi al sito: http://www.stampalternativa.it/liberacultura/books/buk.pdf
25-03-2011
LORENZO SPURIO