Nota introduttiva
Il 22 agosto, ad Assisi, la Sala della Conciliazione del Palazzo dei Priori ha ospitato la presentazione di Il canto vuole essere luce, volume miscellaneo curato da Lorenzo Spurio e dedicato a Federico Garcia Lorca (Bertoni editore, 2021). Coordinato dallo stesso Spurio, il quale ha tenuto una breve conferenza sul soggiorno del poeta a New York, l’incontro è stato introdotto dal saluto dell’editore Jean Luc Bertoni, accompagnato dalla chitarra del M° Massimo Agostinelli su partiture lorchiane, arricchito dal reading di Annalena Cimino, infine corredato dagli interventi critici di Lucia Bonanni e della sottoscritta. La mia relazione, trascritta qui di seguito, è stata dedicata a un aspetto particolare della poetica dell’autore andaluso. (ci.ba.)

Da sinistra: Lorenzo Spurio, Cinzia Baldazzi e Claudio Camerini
Anche nel campo della critica vige la consuetudine di lasciare nel lavoro compiuto un’impronta veritiera dei dati sensibili o razionali coltivati sulle tracce autobiografiche del critico stesso, o di quanto sia accaduto o sperimentato dalle persone incontrate.
Perciò questi brevi appunti su Lorca prendono avvìo con il pensiero rivolto al lontano 1967, quando, appena dodicenne, nel secondo anno delle medie inferiori, la professoressa di lettere Anna Maria Perrone Pecchia scoprì per noi l’incanto e la magia dei versi del poeta con il celebre esordio di Los alamos de plata:
I gattici d’argento si piegano sull’acqua:
tutto essi sanno, giammai parleranno.
Il giglio della fonte non urla la sua tristezza.
Tutto è più degno che l’umanità!
All’epoca, il lettore italiano disponeva di poche versioni dal castigliano: a parte qualche tentativo sporadico prima della guerra, si dovrà aspettare il ’52 per le traduzioni del teatro a cura di Vittorio Bodini. Poi, a metà degli anni ’70, a breve distanza, ecco il volume di Carlo Bo con le poesie e quello di Claudio Rendina con gli inediti.
La mia insegnante traduceva in proprio: “los alamos”, ovvero i “pioppi”, diventavano i “gattici”, e il “nunca” venne reso con “giammai”. Più tardi ho creduto di aver compreso la ragione dell’uso di tale termine lessicale, segno denotativo del pioppo bianco, i cui fiori alle estremità dei rami hanno riflessi argentei. Nella raccolta Myricae, pubblicata agli inizi del Novecento, Giovanni Pascoli apre così un famoso componimento:
E vi rivedo, o gattici d’argento,
brulli in questa giornata sementina.
Ho voluto rendere omaggio alla mia insegnante, con la quale sono tuttora in contatto. A lei, all’epoca giovanissima, debbo la prima conoscenza del poeta spagnolo in un periodo della scuola italiana in cui, per le caratteristiche personali e politiche del “personaggio” Lorca, difficilmente se ne parlava ad alunni di dodici anni. Sempre con lei leggemmo alcuni brani della morte di Ignacio.
Perché condivido l’episodio? Poiché la natura antropomorfa risulta centrale nella poësis di Lorca. Gli alberi potrebbero parlare, ma non lo fanno, quasi fossero anziani saggi persuasi di quanto sia inutile comunicare realtà tanto essenziali da non implicare una banalizzazione comunicativa. Da parte sua il giglio – simbolo della forza dell’innocenza – sceglie di tacere, di non violare l’universo urlando ansia, paura, dolore.
Ecco, io credo che l’ars poetica del grande andaluso si possa interpretare, comprendere anche senza aver prima amato e conosciuto la poesia in generale. Però non si può fare a meno di prediligere, di conoscere l’onnipresente Natura, la Φύσις dei nostri fratelli greci: i versi non trasmetterebbero forza, struggimento, impeto, se non presupponessimo un legame saldo e inscindibile dell’autore con il mondo inteso come ordine strutturale, finalistico delle cose.
La Natura sovrana, sia pure sofferente, occupa il terreno utopico preminente del repertorio di Lorca: qui entrano, a pieno diritto, le figure maggiori della produzione teatrale, le protagoniste e i protagonisti di Yerma, La casa di Bernarda Alba, Nozze di sangue.
Il teatro di Lorca è un’immensa area di significati dominata dalla Natura Madre, dal corso degli eventi, dove si celebra – e qui utilizziamo le parole di Lorenzo Spurio – «la frustrazione, la solitudine, l’onore e il sentimento tragico della vita». Lo studioso canadese Northrop Frye scriveva: «Noi pensiamo alla natura come qualcosa di femminile e, in effetti, essa lo è. La natura, in termini più semplici, è Madre Natura».
Un nuovo salto nel passato. Nel 1982, nel pieno dell’attività di cronista teatrale su un quotidiano romano, seguivo soprattutto gli artisti impegnati nell’avanguardia e nell’area sperimentale. Ogni tanto, però, ero incaricata di recensire i teatri stabili. Al Quirino ebbi la fortuna, nonché l’onore, di assistere alla messa in scena de La casa di Bernarda Alba con la grandissima Lilla Brignone, diretta da Giancarlo Sepe.
Quella sera, dinanzi alla tragedia delle donne vestite di nero, riuscìi a capire come a Lorca io fossi legata dal complesso totale dell’amore. Ma non quello vicino allo stupore di un sogno a occhi aperti. L’arte lorchiana mi rendeva felice, consentendo di intervenire nell’angoscia tipica di solitudini, nel tormento di passioni disgregate, tradite, ripudiate.
Era nata così, nell’indole di ragazza, la figura di un “poeta come eroe”, paladino di itinerari di lotta nemica acerrima del male, non in chiave astratta, generica, cioè impersonale: piuttosto, coglievo affascinata l’esito di una personalità pragmatica, fattuale, convincente. García Lorca si rivolge sempre agli interlocutori credendo in tutti noi, uomini, donne, bambini, giovani, anziani, nella scelta di accompagnarli con commovente riserbo e non “trascinarli” in una cerchia intimissima di reazione alle vicende dell’esistenza.
Se molti di noi, dunque, accusano un’umiliante sensazione di impotenza nell’operare su questa terra, altrettanti reputano la ποίησις un’occasione di intervento di ripiego, da gestirsi poiché è l’unica disponibile: essa, del resto si rivelò terribilmente impotente a salvare il poeta dalla morte.
Eppure, ascoltate Yerma, nella tragedia omonima, ammonire il marito Juan:
No, non venirmi a ripetere ciò che dice la gente. Io vedo con i miei occhi che non può essere… Tanto cade la pioggia sulle pietre che le fa ammorbidire e vi fa nascere la ruchetta, che la gente dice che non serve a niente. “La ruchetta non serve a niente”, ma intanto io la vedo agitare nell’aria i suoi fiori gialli.
Nell’immaginario di Federico, la ruchetta costituisce una metafora della poesia: non serve a niente, predilige le circostanze difficili, le idee più improbabili, però rimane lì ad agitare nell’aria i suoi versi.

Yerma coincide con l’esempio di testo teatrale lorchiano da me preferito. Ricordate? Lei non riesce a concepire, il marito Juan, da parte sua, non vuole avere figli.
Il dramma ha origine nel vigoroso ambito interiore di un autore omosessuale, dunque lontano dal poter vivere uno stato di gestazione e filiazione naturale del microcosmo della sfera paterna: ebbene, pur non condividendone l’esperienza reale, Federico riesce a colmare le pagine con l’altissimo appello alla ποιητική τέχνη del fenomeno opposto: la sterilità. Il poeta di Fuente Vaqueros personifica con il suo contrario una fecondità partecipata in un delicato spazio da “spettatore”: coinvolto, addolorato nell’animo, non avendo però mai potuto abbracciare un bambino concepito come sangue del suo sangue.
Sono sempre stata accompagnata da un interrogativo: quale tecnica semantica, quale ispirazione artistica può essere all’altezza di rendere uno scrittore capace di incarnare eventi sconosciuti al suo divenire quotidiano? Come può Lorca parlare così crudamente, con precisione, dell’essere padre, dell’essere madre?
La domanda diventa però un’altra. Perché mai i poeti dovrebbero mentire? Cioè affermare di percepire ciò che non sentono, di amare contesti a loro indifferenti?
Mentre a dodici anni leggevo Lorca, più o meno a quell’età, insieme all’amica Dina Tron, scoprivo i primi dischi di Bob Dylan distribuiti in Italia. Da allora, Dylan non l’ho abbandonato e, modestamente, nel tempo sono divenuta una dylanologa doc. Ora, Dylan – soprattutto da giovane – ha scritto e interpretato numerose canzoni tristi, lamentose, di amori impossibili, di solitudini, di vite sprecate. Nel passato ho tentato di identificare l’aura che gli permetteva di rappresentare così efficacemente le vette dello sconforto e gli abissi del dolore, avendo lui condotto, invece – e per sua fortuna – una vita di tutt’altro genere.
È questo lo scatto semantico-semiotico tipico delle menti eccelse: Lorca, come Dylan, è riuscito a superare, nell’utopica concretezza, il valore del messaggio rispetto al manifestarsi nel reale, perché lo ha avvertito reale, anzi realissimo, nonostante non rispondesse alla legge ferrea, quotidiana, della verosimiglianza.
Così, per il poeta andaluso, la donna appare figura dalla struttura sociale-ideologica composita e variegata, coincidente con un modello di rivolta a soprusi, male, bassi impeti malvagi, ipocrisia, limitatezza nella ragione, tendenze immorali.
Ho iniziato con un breve accenno all’elemento dell’acqua su cui si piegano i gattici dello splendido componimento. Allo stesso modo vorrei concluderlo.
Il mio viaggio lorchiano, l’ho accennato, ha preso il via, da giovanissima, nella sfera volitiva di un Io Conscio sollecitato dalla tensione alla maternità: nell’adolescenza, l’Inconscio registra in atto una sorta di preparazione ad essa, con ansie, desideri, timore di esserne o meno all’altezza, chissà, non volerla affatto.
In una scena di Yerma, la protagonista chiede a una vecchia come si possa combattere la sterilità. L’anziana contadina risponde:
Io? Io non so niente!
Io mi son messa a pancia all’aria e ho cominciato a cantare.
I figli arrivano come l’acqua.
A scuola, in classe, leggemmo uno stralcio del Pianto per Ignacio Sánchez Mejías, in particolare le righe conclusive del Corpo presente:
Non voglio che gli copran la faccia con fazzoletti
perché s’abitui alla morte che porta.
Va’, Ignacio. Non sentire il caldo bramito.
Dormi, vola, riposa. Muore anche il mare!
Due immagini che non dimenticherò mai: l’acqua trasporta i figli, il mare smette di esistere.
Da ragazza ingenua, non sapevo spiegare come mai, di fronte all’illimitato dolore di Federico per la fine dell’amato amico Ignacio, ne sortisse, affascinante e impagabile, l’input di connetterlo a concreti, coinvolgenti flash di maternità realizzata e non: dall’immagine funerea delle “madri terribili” associate allo scontro con il toro, alla figura pallida e lunare della bimba dolente, al bambino che porta il lenzuolo bianco, fino ai versi finali allusivi della improbabile nuova nascita di un uomo come Ignacio.
Adesso, invece, lo comprendo, con l’aiuto dell’anziana amica di Yerma: per esprimere l’immensità della sofferenza provata per la scomparsa dell’innamorato, il poeta ha giudicato fosse indispensabile avvicinarlo alla visceralità, al quid esclusivo del liquido primordiale, del vincolo, del contatto definitivo mamma-figlio, vissuto in absentia, misurandone la mancanza.
Il nostro poeta non accetta di vedere il torero senza vita, addirittura non vuole gli coprano il volto con delle bende perché si abitui al buio assoluto. Infatti, è come se Ignacio volasse oltre la prevaricazione della τύχη, della cattiva sorte, mentre l’autore auspica, anzi stabilisce, che muoia, all’istante, persino il mare. A noi madri, se perdessimo un figlio, la croce, lo sgomento apparirebbero tanto smisurati da essere in grado di stravolgere non la morte – sarebbe poco – ma il θάνατος e insieme il principio medesimo di esistere-sopravvivere nell’elemento simbolico delle distese d’acqua fluviali, oceaniche, la cui presenza rigeneratrice si annullerebbe.
Magari è accaduto a ognuno di voi di conoscere persone colpite da enormi tragedie: può succedere diventino meno sensibili alle pene, ai lutti altrui, poiché inconsciamente, avendo subito il male estremo, per loro è comprensibile che esso abbia annientato ovunque ogni bene. Dunque, anche per gli altri.
Ma, in conclusione, cosa dire? Lontana da noi l’idea di smentire, ma anche solo di correggere, il pensiero di Federico. Nonostante tutto, speriamo che i fiumi continuino a scorrere impetuosi, in eterno si susseguano le onde di mari e oceani, per poter continuare a vivere e a leggerlo.
Cinzia Baldazzi
Roma, 22 agosto 2021
Il presente testo viene pubblicato su questo sito dietro autorizzazione espressa da parte dell’Autrice la quale nulla avrà a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro. La riproduzione del presente testo, in forma di stralci o integrale e su qualsiasi supporto, non è consentita senza l’autorizzazione dell’autrice.

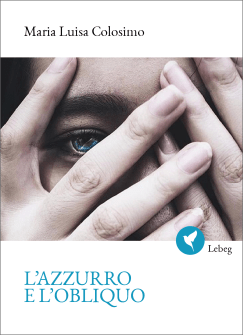 Titolo di per sé ambiguo e che apre alle possibilità, a una fertile evocazione, questo dell’opera poetica di Maria Luisa Colosimo, L’azzurro e l’obliquo (Lebeg, Roma, 2017). Il volume, che si apre con una perspicace ed esaustiva nota critica firmata da Giovanni Perrino, si mostra formato da due comparti in sé ben definiti: un poemetto iniziale che copre svariate pagine, una sorta di dialogo con sé stessa, e poi una serie di liriche dalla fattura per lo più affine, numerate in senso progressivo da numeri romani, delle quali si apprezza, invece, la brevità dei contenuti espressi.
Titolo di per sé ambiguo e che apre alle possibilità, a una fertile evocazione, questo dell’opera poetica di Maria Luisa Colosimo, L’azzurro e l’obliquo (Lebeg, Roma, 2017). Il volume, che si apre con una perspicace ed esaustiva nota critica firmata da Giovanni Perrino, si mostra formato da due comparti in sé ben definiti: un poemetto iniziale che copre svariate pagine, una sorta di dialogo con sé stessa, e poi una serie di liriche dalla fattura per lo più affine, numerate in senso progressivo da numeri romani, delle quali si apprezza, invece, la brevità dei contenuti espressi. In questa silloge Katia Debora Melis sembra aver approfondito, e di molto, le tematiche che nel corso del tempo ha trattato nelle sue varie sillogi precedenti tanto da giungere a una poetica in cui l’evoluzione matura di scelte linguistiche, sistemi poetico-architettonici e resa di immagini con relative suggestioni conoscono una espressività più diretta che nel lettore produce soprattutto in relazione a certe liriche un’empatia della quale egli stesso può rimanere felicemente impressionato.
In questa silloge Katia Debora Melis sembra aver approfondito, e di molto, le tematiche che nel corso del tempo ha trattato nelle sue varie sillogi precedenti tanto da giungere a una poetica in cui l’evoluzione matura di scelte linguistiche, sistemi poetico-architettonici e resa di immagini con relative suggestioni conoscono una espressività più diretta che nel lettore produce soprattutto in relazione a certe liriche un’empatia della quale egli stesso può rimanere felicemente impressionato.
