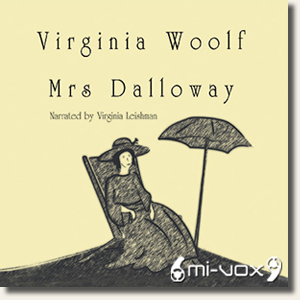Recensione di Lorenzo Spurio
Vorrei
giungere in vista di Itaca,
sentire la tua mano sulla guancia,
come rugiada nel cuore d’una rosa (97).
Di recente pubblicazione è la nuova raccolta di poesie di Stefania Pellegrini, autrice nata in terra d’Irlanda e da tanti anni residente nei pressi di Aosta. Non si tratta della sua opera prima e numerosi suoi testi sono già apparsi in rete, soprattutto sul suo sito personale «Parole Nomadi», su varie uscite della rivista di poesia e critica letteraria «Euterpe», nonché su antologie di premi letterari.
Il nuovo volume, edito per i tipi di CTL di Livorno, porta il titolo di Itaca nel cuore e già da questa definizione che richiama il mito classico – e con esso il mistero del viaggio – compendiamo che il percorso che la Nostra ci propone d’intraprendere immergendoci nelle sue liriche ha qualcosa d’analogo a un itinerario odeporico vale a dire di quella letteratura di viaggio che non è semplice cronaca di trasbordi e viaggi fisici quanto – ben più spesso e in forme ancor più profonde – di carattere esistenziale e interiore.

La Pellegrini ha deciso di suddividere il copioso materiale poetico che qui trova posto in varie sotto-sezioni che, in realtà, appaiono più come delle vere e proprie micro-sillogi che possono essere concepite, lette e dunque fruite nella loro singolarità: sono autosufficienti ai contenuti e complete e non necessariamente debbano trovare riflesso e collegamento con le altre sezioni. Ed è la stessa Autrice a chiarire nella nota introduttiva del volume quella che è stata la sua intenzione alla base di questa necessaria e ben condotta cernita di titoli e relativa catalogazione in sottogruppi. C’è una prima sezione che porta il titolo “La forma dei giorni”, enunciato nel quale non facciamo difficoltà a percepire l’intenzione della Nostra di volersi riferire a quegli aspetti della vita odierna, agli ambiti colloquiali e transeunti dell’uomo contemporaneo, in balia tra pensieri e ossessioni, a volte ostaggio di incomprensioni, altre pervaso da moniti di fuga e sempre – comunque – fortemente attraccato alla vita concreta nella quale la Nostra ritrova il senso delle cose in circostanze di meditazione, pausa, riflessione, ricerca di sé e attribuzione di significati all’essenziale che ci contraddistingue.
A rivelare questo (possibile) atteggiamento sono i titoli stessi delle poesie che si trovano contemplate in questa prima parte: “Sono così oggi”, “Cambiare prospettiva”, “Mia solitudine”. Sono, in effetti, testi particolarmente intimi in cui l’interiorità della Nostra viene offerta al lettore non tanto perché ne faccia testamento proprio quanto perché, senza difficoltà né superfetazioni, può ritrovarcisi egli o ella stessa. Pensieri, dubbi, divagazioni, riflessioni e rievocazioni, ma anche memorie, ricordi che riaffiorano, promesse, visioni incantate o comunque piacevoli (non sempre in linea con l’animo dell’io lirico) fanno da sfondo a questi componimenti. Penso anche a testi quali “E nasce il giorno” e “Il mare”.
D’altro canto non possono – né devono – passare inosservati gli scambi lirici nei quali la Nostra tematizza la vita nella forma del percorso, tramite l’allegoria del viaggio, metafora nota del cammino dell’uomo, viandante in terre che non conosce, scopre, caratterizzato da continue dislocazioni per ragioni dettate da aspetti pratici della vita. Si pensi ai componimenti “La locomotiva”, “Andata-ritorno” ma anche “In quell’andare” e “Il viaggio” dove questo si fa particolarmente palese.
Noto è il mito di Ulisse che ritorna ad Itaca dopo numerose peripezie di varia natura di cui Omero dà di conto in una delle epiche più studiate e affascinanti dell’intera letteratura mondiale. Eppure al suo ritorno Ulisse non viene riconosciuto da chi l’ha visto nascere e crescere (con eccezione della nutrice Euriclea oltre che del cane Argo s’intende), dal suo popolo e questo elemento – che vedrà la sua agnizione nel momento che il personaggio considera valevole di far cadere il mondo di impostura e tradimento che per i tanti anni di sua assenza si è creato – ha dato spazio alle considerazioni critiche e alle interpretazioni più varie, a partire dalle più banali per affrontare circostanze situazionali e logiche in effetti che non hanno nulla di inferiore a un chiaro esperimento sociologico. Credo che il non riconoscimento di Ulisse al suo approdare su Itaca non derivi dal semplice fatto che lui è di molto cambiato, invecchiato, barba incolta e travisato da mendicante, e dunque restituisce un’immagine assai differente da quella che tutti hanno di lui, ma attiene anche all’impossibilità di saper cogliere l’essenziale, l’incapacità di scorgere l’autentico, la miopia e la faciloneria che portano l’uomo in senso generale ad essere connaturatamente più propenso al giudizio (e al pregiudizio) che al ragionamento e al collegamento meditato. È pur vero che Ulisse è diverso, ma non solo fisicamente, dunque nel mero aspetto, è un uomo formato, completamente maturo, temprato dalle fatalità della vita, le cui vicissitudini lo hanno ispessito e reso saldo in una maniera da averne fatto un uomo essenzialmente diverso da com’era. Eppure si mantiene in lui la compassione e l’amore che nella scena con la ritrovata Penelope – l’unica sofferente della sua assenza – risalgono in superficie. Ecco, la poesia della Pellegrini ha qualcosa di analogo a questo comportamento ambiguo di Ulisse: al di là del fascino arcaico verso il mare visto sia come ecosistema puro ma anche come elemento di attraversamento verso spazi diversi e lontani dai propri, nelle poesie della Nostra sembra di percepire, pur diluiti in contesti emozionali introiettati ed esperiti come propri, i motivi del viaggio e dell’evasione, dell’allontanamento e della crescita interiore e morale, dell’asperità della vita, della condizione di esule, ma anche del ritorno, del recupero di quel che si credeva perso e di cui, non senza difficoltà (proprio come la memoria dei nostri cari ormai sottratti al tempo), possiamo riappropriarci.

La seconda sezione del volume, dal titolo “Oltre le pagine sporche”, con un sottotitolo inciso che recita “Incontri”, ha a che vedere con la dimensione spiccatamente civile della Nostra, di cui sulle pagine della rivista «Euterpe» si è già avuta, più volte, dimostrazione. La Pellegrini abbraccia l’arma della poesia per parlare di drammi, situazioni di difficoltà, condizioni di vita marginali e di sopraffazioni, contesti di violenza, infanzia negata, situazioni d’indecorosa indifferenza e di crudeltà umana. Sono testi mossi – in taluni casi – da episodi concreti, partoriti da una cronaca efferata e iterata, così dolorosamente colpevole di riempire l’informazione che ci giunge da angoli reconditi del mondo. Ma, altrettanto spesso, anche da situazioni e contesti della nostra Provincia, che accadono poco distanti da noi, nell’indifferenza e nell’incomprensione dei più, mix deleterio che impoverisce il senso di concordia umana che andrebbe rinsaldato e protetto. Doverosamente preponderante appare il tema del fenomeno migratorio: “Fiore del deserto / vertigine bronzea di vellutata pelle, / occhi grandi incrostati di sale / colmi di mistero, e di passione, / dalla furia del mare sgranati di terrore” (53) si legge nella poesia “Amàli” che apre questa sezione del volume. Il tema ritorna in “Alya, Alya” che ci narra di un altro naufragio divenuto eccidio: “Brucia le labbra l’acqua salata, / ostile, ansiosa di tenermi con sé. // […] // L’acqua sale, le labbra, gli occhi bruciano” (58-59).
Tra le altre rievocazioni di sciagure umane che la Pellegrini richiama quali motivi trainanti di un duro affondo di sgomento e denuncia vi è la shoah con un ricordo relativo a undici giovani fucilati a Nus, in provincia di Aosta e dove l’Autrice risiede, nel luglio del 1944. “Non piangere madre, / un tempo c’è stato, e non è stato vano” (55) recita l’explicit, in un singulto di dolore che non svanisce con gli ultimi versi della lirica e che, invece, pare raggrumarsi come uno spiacevole nodo alla gola. C’è una grande partecipazione dell’io lirico in questi testi, lo si nota dal grande garbo verso una materia spesso abusata e maltrattata – anche in poesia – fatta oggetto di facili utilizzi, quando non addirittura di indecorose strumentalizzazioni. Nelle poesie della Nostra si riscontra un pathos la cui intensità risulta difficilmente configurabile a parole. Alto è il senso di pietas della Pellegrini, di quell’ascolto gratuito e doveroso verso l’altro che, anche nella circostanza di episodi ormai lontani e consegnati alla Storia, non dovrebbe venir meno. C’è il senso dell’umanità, trafitta dalle sofferenze, ma anche il monito a non dimenticare per non cadere in baratri analoghi. Se la Storia è testimonianza di vita, diviene doveroso e imprescindibile per l’uomo d’oggi farsi testimone per le nuove generazioni.
Sguardo attento anche verso l’esodo del popolo curdo sottoposto al continuo esilio da una terra che lo rende “appeso al filo della speranza” mentre vive disperato, sospeso, tra “un lembo di terra nomade” e “un recinto di filo spinato” (61), all’infanzia negata dei bambini siriani con “i sogni impigliati sul filo spinato” (63), finanche a un meno noto genocidio degli indiani Sioux noto come il “massacro di Chivington” che vide come scenario il Colorado nel 1864: “Agnelli al suolo sacrificati, / sciabole sguainate, corpi come grano / mietuto sui campi” (66). La Nostra dedica un componimento anche per coloro che, avendo commesso reati, si trovano “relitti ai margini del vuoto, / chius[i] nel grigiore delle ristrette mura” (67), quelle degli istituti penitenziari. Storie di profughi, di immigrati che muoiono nel loro tragitto che dovrebbe condurli in un pase dove cercano pace e futuro, spose bambine, violenze assolute, bambini soldato (“Perdona mamma muoio, / preme un’ombra nera / sulla coscienza”, 75), infanti martoriati nel corpo e assopiti nell’anima, esuli in cerca di uno spazio che possa accoglierli, deportati nei lager, donne stolkerate e abusate (“la voce melliflua che ti adula / con parole spacciate per amore / […] / ti viola insistente”, 78), manovalanza straniera soggiogata e vilipesa da avidi caporali, sono i nuovi martiri contemporanei.
Si riscontrano anche invocazioni e tentativi di dialogo con la luna: “Parlaci / delle nostre imperfezioni” (11), promesse (non facili) fatte a sé stessi, dettate da un’altalenante convinzione dell’esistenza di motivi di forza atti a imprimere un segno di cambiamento o a fortificare meccanismi di resilienza: “Vincerò le stupide paure / […] / Per affrontare / le rotte del mare sconosciuto // […] // e troverò il coraggio / per superare gli ostacoli” (15), convincimenti entusiastici dinanzi a un’avvincente scoperta: “Ma oltre / lo sguardo mira, / verso quel mare che tutte le contiene. / Ancora salperò!” (19), finanche il riconoscimento di una vulnerabilità data dalla carenza di presenze amorose e rassicuranti: “Posa la polvere e lame di luce / l’odore dei ricordi, / aleggia tra le finestre e il comò, / con il passo silente della sera, / e il marchio doloroso delle assenze” (24) mente l’insicurezza diffusa della condizione instabile e logorante del dubbio crea ansia: “Cresce – prolifica / in cerca d’attenzione / come gramigna nell’orto, / e insinua / granelli d’incertezza, / un tarlo nella mente / che rode fin dentro il cuore” (28).
Con l’ultima sezione del volume, “L’impronta del tempo”, è come se si completasse quel percorso circolare che la Nostra ha intrapreso e concesso a noi lettori di intraprendere con lei. Ritornano, infatti, ma in maniera ben più sentita e in forma quasi opprimente, i temi dell’infanzia (“Mi guardo, mi riguardo / cercando la ragazza nella foto / […] / Scopro a illudermi, / a abortire il ricordo”, 88), dei ricordi (“sola mi rifugio / tra le pieghe del ricordo / […] / mentre andavo incontro all’anse / del grande mare, / incurante dei venti contrari”, 98), dell’inesorabilità del tempo che porta la Pellegrini a ragionare su questioni supreme, d’impossibile decodifica per l’uomo, eppure temi impellenti, ricorrenti, a tratti dolorosi, necessari, che svelano un’accentuata dote intellettiva e cogitante: “E mi chiedo perché, / nell’essere non è il rimanere” (89) scrive nell’affascinante testo che porta il titolo “Sfoglia il tempo la mia vita”. Grumi di nostalgia in quel “suono dei tuoi passi andati” (100) si assommano a un senso di vera angoscia dettato dal sentimento dell’assenza (“Ti cerco – non ti trovo, / […] // Queste ore a contare / il tuo ritorno”, 101) e trovano compimento, nell’adesione alla prepotenza della realtà, che smentisce veli e smantella illusioni: “Cede la foglia il suo stare, / da un fiato di vento si lascia rapire. // […] // Vedi? / Niente resta lo stesso” (105).
L’acqua, lo scivolare, lo scorrere, il fluire, divengono in questa sezione del volume tutte sfaccettature di quell’andamento sorgivo e impetuoso improntato al divenire e, in quanto tale, irrefrenabile: immagini e riflessioni di un tempo che cambia perché progressivamente s’allontana da quel passato che ha impresso le nostre esistenze. Tale percorso – come già accennato – non sempre si mostra di facile accettazione per l’uomo perché, adombrato da meccanismi inconoscibili e restio a conformarsi alle sue precipue volontà, produce sperdimento e incomprensione: “non trovo risposte / ai miei richiami” (91), scrive l’Autrice.
LORENZO SPURIO
Jesi, 07/05/2021
Note: La riproduzione del presente testo, sia in formato integrale che di stralci e su qualsiasi tipo di supporto, non è consentito se non ha ottenuto l’autorizzazione da parte dell’autore. E’ possibile, invece, citare dall’articolo con l’apposizione, in nota, del relativo riferimento di pubblicazione in forma chiara e integrale.