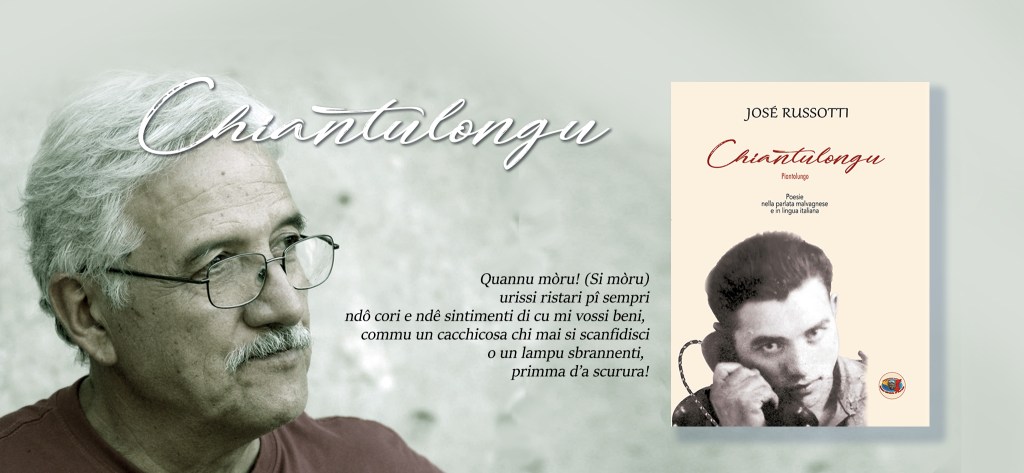Nella civiltà umanistico-rinascimentale iniziò un processo di emancipazione femminile in virtù del quale molte donne furono istruite al livello degli uomini. Alcune riuscirono ad acquisire una profonda cultura unita alla volontà di ribellarsi ai pregiudizi misogini che le avevano relegate in una posizione subalterna. L’educazione impartita alle donne era tradizionalmente basata su attività considerate utili da svolgersi nell’obbedienza, nell’abnegazione e nel silenzio. Nonostante questi presupposti poco edificanti, alcune donne provenienti dall’aristocrazia e alla nobiltà minore integrata nelle corti, si riscattarono e divennero poetesse stimate e apprezzate come Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, Veronica Gambara e molte altre.
Com’era prevedibile, la congerie maschile continuò a nutrire ostilità nei confronti di quelle donne che, tramite la scrittura, vagheggiavano di mostrare la loro anima e il loro mondo interiore abbandonando “l’ago e il fuso” strumenti fin dal medioevo simboli per eccellenza delle occupazioni femminili. Altre non ebbero la possibilità di farsi conoscere o furono giudicate devianti. Chi era disposto ad accettarne l’istruzione o la produzione letteraria nutriva il pregiudizio che si trattasse di creature fuori dal loro ruolo naturale che, nell’immaginario collettivo, era solo quello di vergine o moglie e madre, non certo di scrittrice o intellettuale. Anche la diffusione, soprattutto nelle corti, del petrarchismo e dei cosiddetti “petrarchini”[1], assunsero un ruolo importante, poiché fissarono l’uso di un codice espressivo proprio della convenzione amorosa tipico però di un mondo maschile.
Non tutte le poetesse furono mere imitatrici di Petrarca e si servirono della poesia solo come pratica sociale legata all’ambiente cortigiano, ma seppero rivisitare autonomamente stilemi e codici linguistici preesistenti con la loro spiritualità alimentata dalla cultura e da sentimenti autentici. Un luminoso esempio ci viene offerto da Vittoria Colonna, donna di alto lignaggio, dalla vita morigerata, ricca e fruttuosa, amata dai contemporanei sebbene le sue liriche fossero conosciute solo da un ristretto numero di amici.
Nata nel 1490 da nobili genitori di prestigiose casate, Fabrizio Colonna e Agnese di Montefeltro, ricevette fin dall’infanzia una raffinata educazione che la fece diventare una delle donne più apprezzate del suo secolo. Il suo fu un matrimonio combinato, a sette anni fu infatti promessa ad un coetaneo, Ferdinando D’Avalos, marchese di Pescara, come suggello di un’alleanza tra due potenti famiglie, ma nonostante i presupposti, il matrimonio si sarebbe rivelato felice. Grazie al mecenatismo dei marchesi, il castello di Ischia, loro residenza e sede di un prestigioso cenacolo letterario aperto alla discussione sui problemi della fede, fu un punto di riferimento importante per i più importanti letterati e poeti del periodo, come Jacopo Sannazaro, Cariteo, Galeazzo di Tarsia, Bernardo Tasso.
L’amato marito si allontanò da Ischia nel 1511 per combattere nella lega antifrancese promossa dal papa guerriero Giulio II e cadde prigioniero nel 1512. In quest’occasione Vittoria compose per lui un’epistola in terzine, per esprimere la sua afflizione, che testimonia la sua vocazione letteraria ed è l’unico che abbia scritto prima della morte del marito. Negli anni successivi conobbe altri famosi intellettuali tra i quali Baldassarre Castiglione e Pietro Bembo, ma la sua fama di nobildonna di specchiata virtù, vasta cultura e grande talento ebbe vasta risonanza ovunque.
A Pavia, nel 1525, in uno scontro con l’esercito francese, il marito morì, Vittoria cadde in uno stato di prostrazione. Iniziò a comporre sonetti dedicati a lui caratterizzati dalla cifra del ricordo, in cui lo descrive come un eroe, l’unico “lume”, il suo “sole” e verso di lui incanala tutta la sua sofferenza che diventa uno strumento di elevazione spirituale.
Nel 1525 Ariosto le dedicò un sonetto[2] per consolarla e allo stesso tempo esortarla a temperare il suo dolore con la sua virtù capace di innalzarla fino al cielo insieme con la gloria dello sposo. Anche Baldassarre Castiglione nel 1928 scrisse lusinghiere parole per lei nell’introduzione del Cortegiano.[3] Parimenti la sua fama di poetessa si diffuse rapidamente: nel 1532 Ariosto ne cantò le lodi nell’ultima edizione del Furioso citandola nel canto XXXVII in cui, dopo aver accennato a vari scrittori che encomiarono le donne, coglie l’occasione per tessere elogi per lei e per le rime gentili dedicate alla memoria dell’amato[4]. Vittoria riversò il suo dolore in liriche intrise di sofferenza in cui si avverte il desiderio di morire e di ricongiungersi presto al marito. Un esempio è offerto dal sonetto LXXXII di chiara ascendenza petrarchesca in cui la poetessa esprime il suo dolore al sorgere del mattino che non rappresenta un momento di gioia bensì di tristezza perché le richiama alla mente la sua condizione di solitudine. La sua sorte triste la induce dunque a cercare le tenebre che si identificano con la morte e la conducono al suo “sole”.
Quando ‘l gran lume appar nell’oriente,
Che ‘l negro manto della notte sgombra,
E dalla terra il gelo o la fredd’ombra
Dissolve e scaccia col suo raggio ardente:
De’ primi affanni, ch’avea dolcemente
Il sonno mitigati, allor m’ingombra:
Ond’ogni mio piacer dispiega in ombra,
Quando da ciascun lato ha l’altre spente.
Così mi sforza la nimica sorte
Le tenebre cercar, fuggir la luce,
Odiar la vita e desiar la morte.
Quel che gli altri occhi appanna a’ miei riluce,
Perchè chiudendo lor, s’apron le porte
Alla cagion ch’al mio sol mi conduce,
Il sonetto XXII si può considerare significativo nel passaggio dall’amore terreno a quello spirituale, Vittoria è da tempo rassegnata al fatto che la morte abbia rotto i vincoli materiali che la legavano all’amato, però se i corpi sono ormai sterili, le anime diventano ancora più feconde e più che mai sono avvinte in un connubio molto più produttivo grazie a cui ella diviene madre metaforica di una prole immortale fatta di spirito. La sua poesia che nasceva dal pianto ora si innalza al cielo.
Quando Morte fra noi disciolse il nodo
che primo avinse il Ciel, Natura e Amore,
tolse agli occhi l’obietto e ’1 cibo al core;
l’alme ristrinse in più congiunto modo.
Quest’è ’l legame bel ch’io prezzo e lodo,
dal qual sol nasce eterna gloria e onore;
non può il frutto marcir, né langue il fiore
del bel giardino ov’io piangendo godo.
Sterili i corpi fur, l’alme feconde;
il suo valor qui col mio nome unito
mi fan pur madre di sua chiara prole,
la qual vive immortal, ed io ne l’onde
del pianto son, perch’ei nel Ciel salito,
vinse il duol la vittoria ed egli il sole.
Benché la donna, dopo il 1525, avesse trascorso un lungo periodo di volontaria reclusione nel castello di Ischia e avesse desiderato anche di chiudersi in un monastero, nel 1530 il letterato Paolo Giovio[5], da sempre vicino alla marchesa a cui era legato da un intenso amore spirituale, tentò di riportarla sulla scena letteraria. Fu proprio lui il tramite con Pietro Bembo, che nel 1535 incluse un suo sonetto nella seconda edizione delle Rime e gliene dedicò un altro[6].

Iniziò un sodalizio poetico rafforzato da un intenso scambio epistolare. Nonostante la vita ritirata e il dolore, riuscì a conoscere molti intellettuali dell’epoca, ma non solo, si avvicinò infatti a religiosi come Juan de Valdés[7], il frate Bernardino Ochino[8], più volte ascoltato a Roma, a Napoli, poi a Ferrara, infine al cardinale Reginald Pole[9]. Iniziò per Vittoria una mutatio animi grazie ad un percorso religioso e alla conoscenza dei personaggi sopraccitati, esponenti del cosiddetto movimento degli “Spirituali” che avevano come principi cardine l’evangelismo e la rigenerazione interiore, temi a cui la marchesa si avvicinò con interesse. Il suo itinerario spirituale la unì anche al più grande artista dell’epoca, Michelangelo[10], che le dedicò un madrigale nel quale paragonava l’azione della scultura che libera la figura dalla materia all’influenza su di lui dell’amica: la donna riesce a introdursi nell’anima pura e fragile “che pur trema” del poeta nascosta dalla “dura scorza” della carne[11]. Le rivolse anche altre rime[12] in cui dice, per esaltare le doti della donna, che in lei sente parlare un uomo, salvo poi correggersi affermando che attraverso la sua bocca sente parlare un dio. L’artista comprese che sarebbe stato completamente soggiogato dal sentimento ma in realtà fu un amore totalmente incorporeo e mistico associato ad un altro elemento in comune con lei, ovvero l’adesione alla corrente degli “spirituali” e ai loro principi.
In virtù della mutatio animi, i componimenti della poetessa denominati Rime spirituali costituiscono uno spartiacque con gli altri, (come nel Canzoniere di Petrarca le rime in vita e in morte di Laura), ed esprimono l’esigenza della solitudine, di un ripiegamento in se stessa e di una profonda introspezione, ma soprattutto di un colloquio diretto con Dio, di un insopprimibile anelito ascetico frutto di una fede pura e sincera.

Dalla lettura dei sonetti si palesa il travaglio interiore, la ricerca inesausta della consolazione della fede, il superamento e la sublimazione delle passioni terrene che gradualmente vengono soppiantate dall’immersione totale nel divino. Tutto ciò non avviene senza contrasti, il suo è comunque un dissidio interiore come emerge chiaramente dal sonetto CXLIV in cui si rileva un atteggiamento di pentimento e vergogna (che sicuramente la accosta a Petrarca), ma anche la sofferenza e la tensione emotiva della donna che palesa la profondità della sua fede e si congiunge con tutta se stessa alla croce di Cristo trovando in lui l’amore prezioso capace di mutare ansia e timore in speranza e giubilo.
Quand’io riguardo il mio sì grave errore,
Confusa al Padre Eterno il volto indegno
Non ergo allor, ma a te, che sovra il legno
Per noi moristi, volgo il fedel core.
Scudo delle tue piaghe e del tuo amore
Mi fo contra l’antico e novo sdegno,
Tu sei mio vero prezïoso pegno,
Che volgi in speme e gioia, ansia e timore.
Per noi su l’ore estreme umil pregasti,
Dicendo: Io voglio, o Padre, unito in cielo
Chi crede in me, sì ch’or l’alma non teme.
Crede ella e scorge, tua mercè, quel zelo
Del quale ardesti sì, che consumasti
Te stesso in croce e le mie colpe insieme.
In un altro sonetto la poetessa immagina di elevarsi oltre le proprie facoltà sensibili per permettere all’anima di avvicinarsi a Dio, il “vero Sole”. In questo viaggio mistico, simile al trasumanar dantesco, impara l’ineffabile, lontano da tutte le cose terrene e può profondarsi nello splendore di Dio che conosce tutti i suoi dolori. Ė evidente anche la variazione del linguaggio utilizzato: agli echi petrarcheschi e danteschi si unisce, come del resto in tutte le rime spirituali, quello biblico.
Sovra del mio mortal, leggera e sola,
aprendo intorno l’aere spesso e nero,
con l’ali del desio l’alma a quel vero
Sol, che più l’arde ognor, sovente vola,
e là su ne la sua divina scola
impara cose ond’io non temo o spero
che ‘l mondo toglia o doni, e lo stral fero
di morte sprezzo, e ciò che ‘l tempo invola,
chè ‘n me dal chiaro largo e vivo fonte
ov’ei si sazia tal dolcezza stilla
che ‘l mel m’è poi via più ch’assenzio amaro,
e le mie pene a lui noiose e conte
acqueta alor che con un lampo chiaro
di pietade e d’amor tutto sfavilla.
Nonostante la rettitudine morale, la fede sincera e la ricerca continua di religiosità pura, intima e lontana dalla corruzione, Vittoria attirò a sé l’attenzione dell’Inquisizione romana che per anni cercò di raccogliere prove indagando sui suoi rapporti con i valdesi e con Pole. Fortunatamente, nonostante i sospetti e il fatto che il suo nome spesso ricorresse nelle carte dei processi, non venne pubblicamente accusata, in virtù delle amicizie influenti di cui godeva la sua famiglia, non ultima quella del pontefice Paolo III. Cosa più rilevante, che esula da ogni intervento esterno e che la salvò da ogni accusa di eresia, fu la sua reputazione di donna virtuosa, colta e dall’integrità morale ineccepibile. A maggior ragione stupisce che una poetessa di un tale spessore morale, culturale e religioso, a prescindere dal rango di appartenenza, potesse essere infamata dal fanatismo religioso che non aveva nessun diritto di sindacare sulla sua autentica e sofferta fede di cui i sonetti offrono un’eccelsa testimonianza. Una tale ingiustizia si può spiegare soltanto alla luce di atavici preconcetti su donne brillanti capaci di compiere scelte coraggiose e libere.
Bibliografia
Cosentino Paola, Poetesse del Cinquecento, in Il contributo italiano alla storia del pensiero. Letteratura, direzione scientifica di G. Ferroni. Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 2018, pp. 187-192.
Per le biografie: Enciclopedia Treccani online.
Plastina Sandra, “Vittoria Colonna”, in Galleria dell’Accademia Cosentina, Roma Iliesi CNR 2016
Prandi Stefano, “La vita immaginata” vol. 1B, Mondadori, Milano 2019
Rime di tre gentildonne del secolo XVI, Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, Veronica Gambara. Prefazione di Olindo Guerrini, Milano, Edoardo Sonzogno, 1882. Edizione elettronica del 29 aprile 2009.
Salinari Carlo; Ricci Carlo, Storia della letteratura italiana vol.2, Bari, Laterza, 1995
[1] Edizioni in miniatura del Canzoniere di Petrarca e piccoli glossari dei termini più usati dal poeta.
[2] Illustrissima donna, di valore
ferma colonna, se ’l volubil cielo,
come vedete, or ne dá caldo or gielo,
or vita or morte, or gioia ed or dolore;
s’egli ha furato ’l vostro primo amore,
ch’è anche l’estremo ed il fral suo velo
sciolt’ha dal spirto anzi il cangiar del pelo,
dando a voi noia, ed a sé eterno onore;[….]
[3] “L’ingegno e la prudentia di quella Signora, la virtù della quale io sempre ho tenuto in venerazione come cosa divina”., Cortegiano.
[4] XVIII Vittoria è ’l nome; e ben conviensi a nata
fra le vittorie, et a chi, o vada o stanzi,
di trofei sempre e di trionfi ornata,
la vittoria abbia seco, o dietro o inanzi.
Questa è un’altra Artemisia, che lodata
fu di pietá verso il suo Mausolo; anzi
tanto maggior, quanto è piú assai bell’opra,
che por sotterra un uom, trarlo di sopra.
[5] Paolo Giovio, storico (1483-1552), fu ospite della poetessa Vittoria Colonna e di Costanza d’Avalos. Rimase affascinato dalla donna «a cui fu legato da un amore celeste, santo e platonicissimo, armonia delle cose più belle», scrive in una lettera nel 1530 al cardinal Bembo.
[6] CXXVI.Alta Colonna e ferma a le tempeste
del ciel turbato, a cui chiaro onor fanno
leggiadre membra, avolte in nero panno,
e pensier santi e ragionar celeste,
e rime sì soavi e sì conteste,[…].
[7] Juan Valdés (1500-1542), letterato e teologo spagnolo, esercitò un fascino grandissimo nell’alta società napoletana, nella quale diffuse il suo pensiero di una fede ricondotta alla purezza evangelica Della sua lezione si nutrì Vittoria Colonna e, tramite lei, Michelangelo.
[8] Ochino Bernardino (1487-1564) entrò nell’Ordine dei francescani. Cominciò a tessere una fitta rete di rapporti con il circolo di ‘spirituali’ riunitosi intorno all’esule iberico Juan Valdés.
[9] Reginald Pole (1500-1558), cardinale e arcivescovo cattolico inglese, tra i maggiori protagonisti dell’età della Controriforma. A Viterbo raccolse attorno a sé gli Spirituali reduci del circolo napoletano di cui facevano parte, tra gli altri, Vittoria Colonna, il grande artista Michelangelo, il mistico spagnolo Juan de Valdés.
[10] Michelangelo frequentò Vittoria dal 1538 fino alla morte (1547): con lei scambiava rime, vivendo intensamente la propria esperienza dell’amore platonico. La Colonna lo convinse ad aderire alla dottrina di Valdés. Per lei l’Artista realizzò alla fine del ‘500 diverse opere di cui rimangono i disegni preparatori tra i quali la Pietà per Vittoria Colonna e la Crocifissione.
[11] Sì come per levar, donna, si pone
in pietra alpestra e dura
una viva figura,
che là più cresce u’ più la pietra scema;
tal alcun’opre buone,
per l’alma che pur trema,
cela il superchio della propria carne
co’ l’inculta sua cruda e dura scorza [….]
(Michelangelo, Rime, n. 152)
[12] Un uomo in una donna, anzi uno dio
per la sua bocca parla,
ond’io per ascoltarla
son fatto tal, che ma’ più sarò mio[..]
(Michelangelo, Rime n.235)
Questo testo viene pubblicato nella sezione “Rivista Nuova Euterpe” del sito “Blog Letteratura e Cultura” perché selezionato dalla Redazione della Rivista “Nuova Euterpe”, n°02/2024. L’autrice ha autorizzato alla pubblicazione senza nulla avere a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro.