Recensione di Marco Camerini
A Gina Berriault (1926-1999) è, in qualche modo, toccata la sorte dell’umbratile J. Johnson (ci occupammo del suo unico libro Ora che è novembre, Bompiani 2017) piuttosto che quella del Nobel A. Munro, anch’essa straordinaria autrice di short stories, e questo nonostante gli apprezzamenti sinceri di alcuni fra i più autorevoli scrittori della sua generazione opportunamente riportati in quarta di copertina.

All’editore Mattioli 1885 si deve la prima traduzione italiana dei suoi racconti, storie uniche per drammatica intensità d’ispirazione, capacità narrativa di costruire trame inquiete ed inquietanti su particolari solo apparentemente secondari, nitida eleganza formale: doveroso il tributo ad una scrittrice misconosciuta anche in America. I modelli vengono persino citati nel corso della raccolta (Gogol’ e Cechov più che Carver o Dubus, magari la Woolf, certo l’Achmatova, Whitman, Pound per la cifra poetica della sua prosa) e i piaceri sono quelli che la Vita ha rubato ad un’anonima folla di personaggi i quali solo raramente hanno saputo/voluto fare altrettanto con le opportunità di un destino assai poco generoso: la speranza in un futuro migliore (accade alla problematica Delia “dalla faccia piatta e minacciosa” e alla sorella Fleur, “riccioli color rame e aria da agnello sacrificale” de I piaceri rubati che, incapaci di “dimostrare quanto fossero preziose”, colmano un’esistenza frustrante con la reciproca e alla fine solidale confessione dei propri rimpianti),[2] il sogno della colta, fascinosa Claudia di incontrare Camus per le vie di Parigi e qualcuno “capace di spezzare le catene dei suoi sensi di colpa” (Morte di un uomo minore), le aspettative di successo del rancoroso Berger, solo “suonatore e non artista”, lui che “viveva la musica come un concentrato di tutti i desideri e le cose belle provate” (Notti nei giardini di Spagna).
Ancora ad essere sottratti senza scampo sono il recupero di un rapporto genitoriale difficile, mai rimosso né rinnegato (“colpa dello sguardo” quella di Arty che assiste, Spettatore inerte e passivo, al crollo di un padre tardivamente incontrato fra i pazienti di un ospedale psichiatrico e solo di un male inesorabile se Eli, con il suo gogoliano Cappotto “nero, poderoso e impenetrabile” non riesce a confessare al suo che dovrà sopravvivergli),[3] l’opportunità – per il cattivo/folle/solo razionale? Bambino di pietra Arnold (“Perché sei rimasto a raccogliere piselli per un’ora dopo che tuo fratello era morto?”) o la Bimba sublime Ruth, concupita dall’amante di sua madre – di vivere un’adolescenza serena, il senso ultimo della propria identità (Chi può dirmi chi sono? con la figura del bibliotecario Perera che rinvia al Tabucchi di Tutti i nomi prima che a Dickens o Dostoevskij…e non fosse per una “i”?!).

Infine l’amore, il furto che scuote maggiormente e non si vorrebbe mai subire: non solo quello senile ed impossibile che nasce dalL’infinito potere delle aspettative di un anziano verso una giovane cui non serve il Kierkegaard de La pienezza del cuore per “alzare gli occhi e guardarsi intorno”, o di una donna che, per l’egoistico piacere di essere ancora desiderata (“terribile non vivere più nemmeno nei ricordi”) costringe gli altri a farlo anche se hanno 16 anni, ma l’Amore in sé, come empatico incontro di anime. Ne traccia un desolato referto la taciturna, sensibile, coscienziosa sessantatreenne de Il diario di K.W. kafkianamente ridotta alle sue sole iniziali, a parlare con un Dio che non risponde (“mi rispondo da sola e faccio tutto il lavoro al posto Suo”), a vergognarsi delle “piccole transazioni” esistenziali e sperimentare la forza rigenerante della pittura ma non quella della passione…tanto affine, in questo, alla dublinese Maria di Cenere. Accumunano le vicende di ognuno il rimpianto struggente di un passato (forse) felice, il costante senso di smarrimento e perdita, la lucida percezione del fallimento che generano rassegnazione più che rabbia, paralisi più che vitale, necessaria speranza, ripiegamento cinico ed esacerbato, mai solidale apertura alle ragioni dell’altro: amico, consorte, amante, genitore o figlio che sia.
Labili ma tenaci segnali di riscatto sembrano giungere dalla terapeutica pratica dell’esercizio artistico: non a caso due racconti vedono protagonisti degli scrittori – seppure in crisi – e la musica, in tutte le sue declinazioni, è una sorta di preziosa costante del libro. Così a Lang gli Scherzi dell’immaginazione consentono di sconfiggere “l’indifferenza per il miracolo della vita” – vera linfa dell’ispirazione creativa (e confessione di poetica) – Kligspringer ritrova la propria dimensione di affabulatore alla Ricerca di Kruper, fantomatico, salingeriano Kurtz della narrativa e nel citato Piaceri rubati – ci limitiamo a questo riferimento – compare una bellissima definizione del jazz (oltre che…del pianoforte): “La melodia che esplode senza un vero inizio e non torna indietro per ricominciare, suonata da persone che pareva sapessero avrebbero ricevuto ciò che volevano e molto di più dalla vita” (p. 48).
L’apparente minimalismo tematico (sarebbe piaciuto a Flannery O’Connor) si traduce in uno stile mai semplicemente referenziale nella sua asciutta essenzialità (prevalgono l’indiretto – a volte libero – del personaggio o il punto di vista onnisciente del narratore sui dialoghi) con frequenti squarci lirici e splendidi finali “aperti” che raramente concludono l’esile intreccio, suggerendo intriganti perplessità/interrogativi nel lettore, sempre emotivamente coinvolto da una lettura appassionante. Gina Berriault va (ri)scoperta ed amata.
MARCO CAMERINI
[2] Rimanda ad Espiazione di McEwan il rapporto di conflittualità/complicità fra le due ragazze.
[3] Questi ultimi due racconti ci sono parsi assoluti capolavori, fra i migliori della letteratura americana del secondo ‘900…ma eravamo sul punto di eliminare l’aggettivo.
L’autore del presente testo acconsente alla pubblicazione su questo spazio senza nulla pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro. E’ severamente vietato copiare e diffondere il presente testo in formato integrale o parziale senza il permesso da parte del legittimo autore. Il curatore del blog è sollevato da qualsiasi pretesa o problematica possa nascere a seguito di riproduzioni e diffusioni non autorizzate, ricadendo sull’autore dello stesso ciascun tipo di responsabilità.

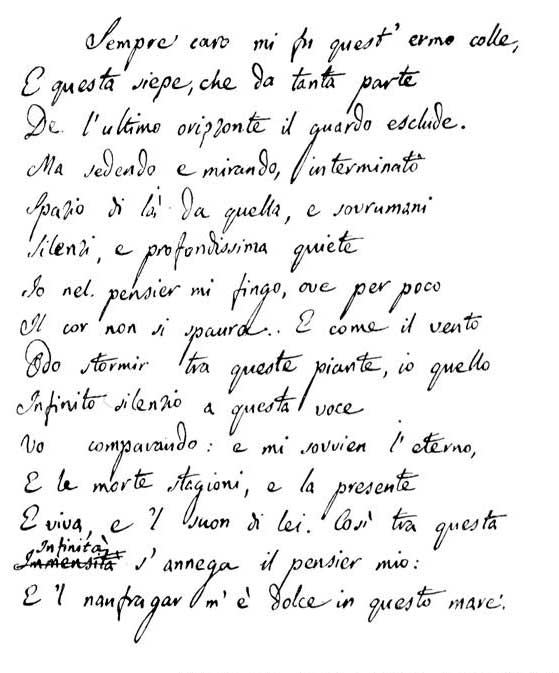
 Perché l’ultimo romanzo di A. Yehoshua Il tunnel (Einaudi, 2018), fra i suoi meno “politici”, è anche un romanzo “dei” e “sui” nomi: quelli angosciosamente dimenticati, quelli emblematici dei personaggi – Hanadi fiore viola/spada, Shibolet spiga/vortice, il fiabesco Aladin, Assael “fatto da Dio” e Zvi…cervo – soprattutto quello che tutti tentano di sostituire eufemisticamente con i più rassicuranti “disorientamento”, “smarrimento”, “stato confusionale”: demenza senile progressiva. Non mancano, certo, i temi cari allo scrittore: il tunnel – che, come forma di terapia contro la degenerazione neuronale, l’ex-ingegnere esperto in svincoli e cavalcavia spinto dalla moglie progetterà, aiutando il figlio di un vecchio collega – lo proietta nel vivo dei complessi, delicati rapporti israelo-palestinesi, a contatto con la realtà di onlus non sempre ineccepibili che fanno curare i secondi negli ospedali dei primi, mentre Israele, scossa dalla corruzione dei suoi vertici, sempre meno esporta nei paesi in via di sviluppo tecnologia civile e competenze in campo agricolo, idrico, logistico (come nei lontani anni ’60) e sempre più sofisticata tecnologia militare, con buona pace dei Nabatei “adoratori del sole” e degli arabi di Palestina…”ebrei che hanno dimenticato di esserlo” secondo Ben Gurion, più volte (e non a caso) citato insieme al Presidente israeliano che del protagonista ha il cognome, Ben Zvi.
Perché l’ultimo romanzo di A. Yehoshua Il tunnel (Einaudi, 2018), fra i suoi meno “politici”, è anche un romanzo “dei” e “sui” nomi: quelli angosciosamente dimenticati, quelli emblematici dei personaggi – Hanadi fiore viola/spada, Shibolet spiga/vortice, il fiabesco Aladin, Assael “fatto da Dio” e Zvi…cervo – soprattutto quello che tutti tentano di sostituire eufemisticamente con i più rassicuranti “disorientamento”, “smarrimento”, “stato confusionale”: demenza senile progressiva. Non mancano, certo, i temi cari allo scrittore: il tunnel – che, come forma di terapia contro la degenerazione neuronale, l’ex-ingegnere esperto in svincoli e cavalcavia spinto dalla moglie progetterà, aiutando il figlio di un vecchio collega – lo proietta nel vivo dei complessi, delicati rapporti israelo-palestinesi, a contatto con la realtà di onlus non sempre ineccepibili che fanno curare i secondi negli ospedali dei primi, mentre Israele, scossa dalla corruzione dei suoi vertici, sempre meno esporta nei paesi in via di sviluppo tecnologia civile e competenze in campo agricolo, idrico, logistico (come nei lontani anni ’60) e sempre più sofisticata tecnologia militare, con buona pace dei Nabatei “adoratori del sole” e degli arabi di Palestina…”ebrei che hanno dimenticato di esserlo” secondo Ben Gurion, più volte (e non a caso) citato insieme al Presidente israeliano che del protagonista ha il cognome, Ben Zvi. 
 Di Tomás Nevison (padre inglese, madre spagnola), occhi inquieti ed inquietanti, ironico, brillante, impenetrabile, fascinoso come (a scelta) un pilota anni ‘40/un musicista/un attore alla G. Philipe, miracolosamente versato nelle lingue e destinato a sicuro successo in (a scelta) finanza, diplomazia, politica, carriera universitaria si innamora al liceo, con la cieca, primitiva cocciutaggine di una passione “elementare e arbitraria, estetizzante e presuntuosa”, Berta Isla, protagonista dell’ultimo, omonimo romanzo di Javier Marías (Einaudi, 2018).
Di Tomás Nevison (padre inglese, madre spagnola), occhi inquieti ed inquietanti, ironico, brillante, impenetrabile, fascinoso come (a scelta) un pilota anni ‘40/un musicista/un attore alla G. Philipe, miracolosamente versato nelle lingue e destinato a sicuro successo in (a scelta) finanza, diplomazia, politica, carriera universitaria si innamora al liceo, con la cieca, primitiva cocciutaggine di una passione “elementare e arbitraria, estetizzante e presuntuosa”, Berta Isla, protagonista dell’ultimo, omonimo romanzo di Javier Marías (Einaudi, 2018). 
 Nel deserto rovinoso di un presente segnato da solitudine, incomprensioni, sconfitte, fra gli spettri opprimenti di una vecchiaia mai ammessa né accettata, naufragi matrimoniali drammaticamente (o penosamente) negati, rimpianti e rinunce, ciniche rivalse e frustranti derive economiche, alienati e lancinanti smarrimenti, è certamente il “tema ossessivo dell’inadeguatezza”
Nel deserto rovinoso di un presente segnato da solitudine, incomprensioni, sconfitte, fra gli spettri opprimenti di una vecchiaia mai ammessa né accettata, naufragi matrimoniali drammaticamente (o penosamente) negati, rimpianti e rinunce, ciniche rivalse e frustranti derive economiche, alienati e lancinanti smarrimenti, è certamente il “tema ossessivo dell’inadeguatezza”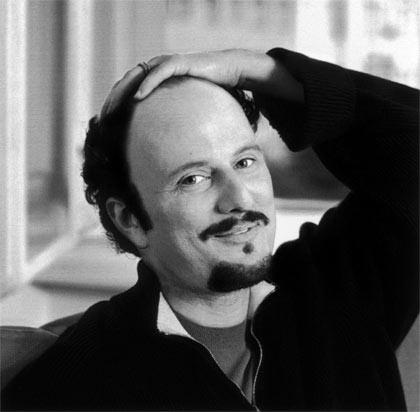
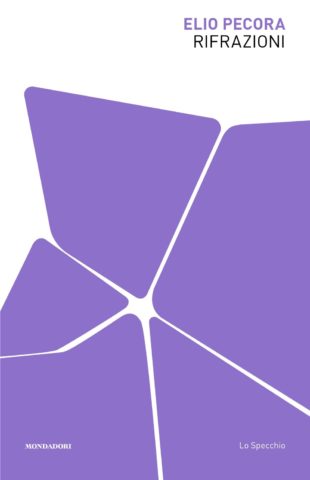 Alla dimensione di una contemporaneità che opprime ed assedia l’io lirico (mai l’autore ne rinnega la voce), funestata da ruberie e delitti, eccidi ed eccessi, guerre che servono a scherani del raggiro seduti a legiferare sulle immondizie
Alla dimensione di una contemporaneità che opprime ed assedia l’io lirico (mai l’autore ne rinnega la voce), funestata da ruberie e delitti, eccidi ed eccessi, guerre che servono a scherani del raggiro seduti a legiferare sulle immondizie