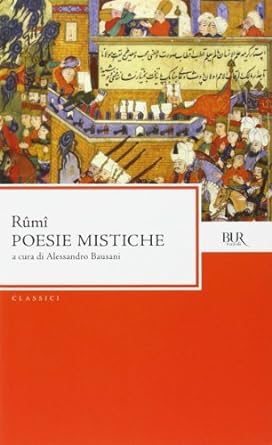La vita è il tempo che passa tra la nascita e la morte, è un passa-tempo nella semplice accezione denotativa, la più novile (niente di dispersivo, di negativo) e che ognuno imposta come meglio crede, senza dettami di specie, purché non offenda l’altrui fede.
La vita, in ottemperanza all’obbligo naturale inderogabile, avviato dal big ben iniziale, è un passa-tempo che impone il movimento, causa generata e generante da mantenere e reiterare.
La vita è azione, ma anche la poesia è azione, dunque vivere vuol dire poetare, esplicitare nel mondo una creazione sempre unica e irripetibile in ogni sua sfaccettatura, nei più svariati ambiti.
La vita/poesia e la poesia/vita si equivalgono. In un mix mutante di vasi comunicanti a volte castranti che mi piace chiamare POEVITÀSIA, dove la poesia, sulle ali della libertà seppur condizionata, è madre di tutte le arti, e ingloba la vita normale (che definisco COATTA) relegata alle comuni mansioni per garantire l’esistenza materiale, secondo il sistema economico-sociale-politico dato, e mai soddisfacente per la maggioranza (anche quando viene spacciato per tale col ricorso all’abusata e vuota parola di “democrazia” “una tecnica del potere, una tra le altre, niente di qualificante).
La Democrazia, nonostante l’emancipazione delle donne che, si sperava, lo scongiurasse, è rimasta un luogo di ipocrisia e menzogna.
POEVITÀSIA si conclude con la morte, suo completamento che apre a un nuovo ciclo infinito. Un eterno ritorno. Prima si barcamena tra un momento ludens e un momento moriens, gioca ogni sorta di giochi d’amore di successo di vizio e di virtù e TUTTO proprio per ammansire la morte. La fase successiva alla vita.
E se fosse il contrario? Se fosse la morte la vera protagonista, la dia ex machina di ogni esistenza? Veniamo dalla morte e ad essa ritorniamo. La vita è forse il sogno della morte che continua, che si perpetua nel movimento per sfuggire alla sua eternità con la nostra precarietà. Siamo fiori caduchi del male è vero. Siamo fiori della morte, la sua fervida immaginazione. La sua poesia. Consolatoria. Ma caduca. Non si può esaurire in nessuna interpretazione (e lo sapeva già Platone) perché rimanda all’agire, all’azione, a tutte le azioni in cui si produce l’umafemìno. E sono infinite.

La poesia coincide così con la vita in tutta la sua molteplicità e la vita è un gioco, in cui si impara imitando e dove non si scinde mai la realtà dall’immaginario. L’imitazione non è semplice riproduzione della realtà sulla base di una qualche tecnica facilmente assimilabile, ma è porsi in ascolto delle cose, percepire ciò che si nasconde al loro interno, coglierne il ritmo, il ritmo delle cose, afferrarlo e abbandonarvisi in un fare, in un poiéin sempre nuovo e diverso, come nuovo e diverso è ogni soggetto che si cimenta nell’operazione.
Nel mondo del gioco realtà e irrealtà trapassano di continuo una nell’altra sono inseparabili e indivisibili. E non si possono cogliere che in un unico movimento, quello dato nel LINGUAGGIO e dal LINGUAGGIO – più generalmente, nei segni e dai segni. Tant’è che è necessario che prima ci sia il gioco perché esista la realtà, e non viceversa. Giocando col linguaggio si costruisce la realtà. Così che il gioco da eraclitea metafora cosmica, diventa simbolo del mondo. E «la lingua non solo manifesta ma anche condiziona il nostro modo di pensare: incorpora una visione del mondo e ce la impone». Quell’ attuale è maschia da sempre.
Il gioco è ricreazione della creazione, e il suo annullamento, per una ripresa continua.
Affidata al linguaggio che non va ingessato in una lingua morta e che dà oggi MORTE, ma va tenuto in un frullatore rigenerante che veda finalmente la partecipazione della donna, con la speranza che faccia man bassa della lingua che i maschi le hanno cucito addosso, e possa rinnovarne la vitalità. Orientarla al bene, alla giustizia, che latitano da tempo immemore.
POEVITÀSIA è fare agire attuare porgere attenzione alla realtà più profonda per testimoniarla, condividerla, contribuire per quanto possibile a comporre il puzzle di senso che a tutti sfugge.
È l’illusione che se tutti potessimo impegnarci a trovare la nostra piccola verità personale forse chissà finalmente ci si potrebbe avvicinare alla verità generale universale.
Ecco perché concordo con chi dice che la poesia è il gioco più serio che ci sia.
La poesia andrebbe affrontata con questo spirito di massima serietà, e da tutte e tutti. DICO Tutte e tutti.
Ecco il punctum dolens. Inaccettabile da chi fa della poesia solo uno status simbol di posizionamento sociale o di supposta superiorità morale, e di magnanima sensibilità. Da chi crede nell’ispirazione divina, dai cultori della poesia bella, orfica, infiocchettata, baciata, portatrice di successo, pratica di vanità.
A tutte e tutti dunque, secondo lo stile che meglio gli aggrada e li inquadra, la dignità iniziale di poete e poeti. Senza graduatoria alcuna, perché ciò che preme non è arrivare ai primi posti in classifica o scorrazzare ovunque nei festival, in vuoti protagonismi, ma condividere un progetto di impegno solidale nella catastrofe attuale. Anzi più che andare verso l’altro bisognerebbe assumere l’altro in sé, capire finalmente che ognuno è centro dell’universo. Anche se non necessaria, la testimonianza di sé scritta sarebbe auspicabile per compilare quel libro unico che in un puzzle universale potrebbe aprire qualche spiraglio sul mistero dell’esistenza. Scongiurare intanto di farne SQUALLIDA sopravvivenza.
Tutti siamo poete e poeti, perché tutte e tutti agiamo nel gioco della vita e tutte e tutti abbiamo diritto di cercarci e raccontarci seppure non eccezionali (senza essere Ulisse, Enea, Orlando, Dante…). Dovremmo scavare in noi per recuperare l’orma della nostra esistenza.
Poesia è la vita di ogni donnuomo che, come l’arte, esiste a prescindere che piaccia o meno agli altri. A prescindere che riesca a gettare ponti, che, essendo di parole, durerebbero come neve al sole. La poesia di ognuno esiste come le stelle nel cielo che non chiedono di certo la nostra approvazione per esserci. È la vita di ognuno la più bella poesia.
Questo testo viene pubblicato nella sezione “Rivista Nuova Euterpe” del sito “Blog Letteratura e Cultura” perché selezionato dalla Redazione della Rivista “Nuova Euterpe”, n°02/2024. L’autrice ha autorizzato alla pubblicazione senza nulla avere a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro.