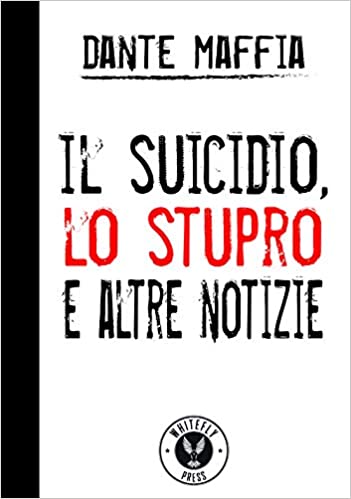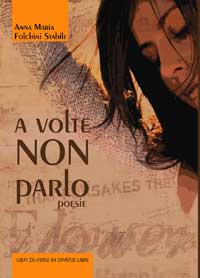Basta guardarla nelle rare fotografie che la ritraggono, per capire chi fosse Christine Lavant, la grande poetessa austriaca, nata nel 1915, originaria di un paesino della valle della Lavant, in Carinzia, nome che adotterà come suo pseudonimo, perché in realtà lei si chiamava Christine Thonhauser. Nona figlia di un povero minatore, bambina gracile, affetta da scrofola e problemi agli occhi, oltre che da regolari polmoniti che la prostrarono impedendole una vita regolare, frequentò comunque la scuola elementare, ma la sua fu un’esistenza segnata dalla povertà e dalla malattia. Crebbe in un ambiente rigido e cattolico col quale non riuscì mai a identificarsi. Anche se le sue poesie e opere in prosa sono caratterizzate da un linguaggio moderno e fortemente simbolico, il patrimonio culturale é quello cristiano, orientato verso una religiosità naturale contraddistinta dal desiderio di sicurezza e di riconoscimento.
Questi giorni non diventeranno vita.
Forse già nel ventre di mia madre il mio destino
s’è coraggiosamente separato da me
e se n’è andato – audace come io non sono mai stata –
sulla stella abbandonata da Dio
ed è rimasto là, s’è messo a dormire
e forse sogna ciò che mi deve accadere
con le tempie luccicanti.
Maliziosa mi lascio portare dal vento
vicino al focolare della realtà
mi lascio abbrustolire, mi lascio sbucciare
e da coloro che sono amaramente delusi
mi lascio risputare nel fuoco
o nell’acqua salata.
Là spesso rifletto e mi chiedo, se Dio sappia di me
se ci siano spiriti custodi anche per quelli come me
e se il sacro nucleo dell’anima
ce l’abbiano davvero solo i sani
che rompono le noci con i denti
e prendono il destino degli altri per il loro.
Nel fuoco e nell’acqua nessuno è lucido –
Perdonatemi Dio Padre, Figlio e Spirito Santo!
Voi siete una trinità e io sono così sola
e nessuno lassù risveglia il mio destino.

Thomas Bernhard, suo conterraneo, la porterà alla luce, e curerà personalmente un volumetto di sue poesie, 81 in tutto, scegliendole dalle sue quattro principali raccolte. Le consegnerà al suo editore nel 1987 avendo individuato in questa donna apparentemente fragile, un’interessantissima voce, isolata soltanto geograficamente entro i confini angusti di un’Austria nazionalsocialista, che lui stesso avversava. Nonostante il suo humus valligiano, la Lavant, sin dal suo primo volontario ricovero nel manicomio di Klagenfurt, dimostrò interessi culturali notevoli e una passione per Rilke, il poeta che ispirerà quasi tutta la sua opera. Bernhard, contrariamente all’immagine consolidata, la sottrae all’idea che fosse un Ligabue della poesia, esaltandone l’intelligente e raffinata espressività poetica, anche perché, nel tempo, la poetessa aveva intessuto una rete notevole di relazioni e contatti con i massimi esponenti dell’avanguardia viennese.
La sua poesia coniuga l’attaccamento alla terra, la tradizione, i riti liturgici, il folklore, a una sete inestinguibile di infinito. La sua è un’invocazione a un Dio sordo e cieco, verso cui inveisce con rabbia, nel dolore inascoltato che l’attanaglia. Rivendica con orgoglio il diritto a esistere come creatura di Dio, dimenticata e abbandonata a se stessa.
Dice Bernhard, nella prefazione al libro da lui curato: “Questo libro documenta la cronologia della vita di Christine Lavant che fino alla morte non ha trovato né pace né tranquillità e che nella sua esistenza si è flagellata attraverso la sua persona ed è stata distrutta e tradita dalla propria fede cristiano-cattolica; si tratta della testimonianza elementare di un essere umano strapazzato da tutti gli spiriti celesti, un essere umano, che altro non è se non grande letteratura, meno conosciuta nel mondo di quanto meriterebbe. La scelta qui proposta segue solo il mio intento e quello di nessun altro”.
Dimentica il tuo ciarpame, Creatore!
O sarai creatore
di ciò che è cadavere e lo rimane
e si unisce alla terra
ben più volentieri che al cielo.
Vai, continua ad ammantare i gigli
corrompi pure i passeri con il miele vergine –
io vivo di ruggine e muffa.
Tu dici che questo non mi sazia
e blateri della città di Dio
che molti conquistano con il digiuno.
Non io! Mi piace vivere nell’argilla
per diventare pietra e tuttavia
mai esserti di peso.
Le sue insicurezze risiedono nella sua fragilità fisica e psichica. Sin da piccola dovette rimanere a casa occupandosi di lavori domestici e cucito, cosa che lei fece con scrupolo anche per riuscire a mantenersi. Non disdegnava la lettura e la scrittura tanto che si rivolse a un editore di Graz per pubblicare il suo primo romanzo, che distrusse dopo che fu definitivamente respinto nel 1932, questo a testimoniare una personalità immatura, ma già provata dalle delusioni della vita. Nel 1935 si ricoverò spontaneamente al manicomio di Klagenfurt dal quale uscì dopo qualche tempo. Morti i genitori, si trovò in condizioni economiche disastrose sostenuta solo dal suo lavoro di cucito e dal supporto finanziario dei fratelli. Decise allora di sposare il pittore Josef Habernig, molto più vecchio di lei.
Le poesie della Lavant sono state definite preghiere blasfeme non solo perché si rivolge in modo irriverente a Dio ma soprattutto perché lo sfida. Emerge la sua natura semplice, franca, simile alla terra natia, dove nulla è concesso con generosità ma è la risultante di un lavoro duro e faticoso. La scrittura diventa elemento salvifico e testimonianza di vita subita, non agìta. Anche Ingeborg Bachman appartiene a quella terra ma da quella terra se n’è andata per trovare ispirazione e pace altrove. La malinconia che permea l’opera di entrambe si spande per quelle vallate dove il silenzio è rotto soltanto dal rimbombo dell’eco.
La Lavant sentiva ardere dentro di sé il fuoco dell’arte ma dovette soffocarlo perché la sua realtà oggettiva non le permetteva di realizzarlo e nessuno intorno lei, a partire dai medici dell’Ospedale psichiatrico in cui era stata ricoverata, erano riusciti a capire il suo desiderio di poetare, stroncando ogni sua velleità poetica, come denuncia nei suoi “Appunti da un manicomio”.
Sono nel reparto “Due”. E’ il reparto del’’osservazione per “i meno gravi” in cui di regola si arriva solo dopo essere passati dal”Tre”. Io non sono passata dal “Tre” e per questa ragione quasi tutti me ne vogliono. Ieri ho sentito dire dalla Regina a Renate: “Quella ci è piombata addosso con gli occhiali e la roba per scrivere. Che se la porti il diavolo! Che cosa è venuta a fare da noi? Probabilmente a spiarci, cosa altro sennò?!”… Renate si è limitata a risponderle: “Ah, eccola che riattacca con queste storie”. Ma poi a sera è venuta dirmi che aveva di nuovo bisogno dei suoi fermacapelli e che doveva riprenderseli. Peccato, non per i fermacapelli, ma per Renate perché credevo che avremmo potuto stringere una qualche amicizia. Fin dal primo giorno ho provato simpatia per lei, per questi suoi occhi muti e malinconici e per quel sorriso evanescente e dimesso che certo mette un po’ di tristezza, ma che non fa paura come la risata delle altre. Dall’altra parte ci si abitua incredibilmente presto ai visi e a discorsi più strani…]
Morte diffamata, per me sei così bella!Già di mattino ti penso come la mia capanna,dove la sera mi trasferirò,e penso che sopra la capanna brillerà una stella.Nemmeno del trasloco ho paura!Certo, prima bisognerà bruciare molto,prima di tutto il corpo con tutte le sue bramee dell’anima ciò che qui si è accumulatoin fatto di coraggio e di allegria.Solo il mio amore, morte, lo porterò con me!Per lui, se davvero sei il mio rifugio,dovrai preparare l’angolo migliore della mia capanna,e se possibile mettici anche una finestra,perché la stella, la buona stella di cui parlo,la possa colmare di tutta la consolazione,che qui non gli ho mai potuto dare.
Le sue invocazioni a Dio ricordano quelle di Rilke, il poeta che la Lavant sentì più di tutti. Lei grida a Dio la sua impotenza, con veemenza e spirito combattivo ben sapendo che il suo urlo disperato è un atto di rassegnazione.
Voglio condividere il pane con i pazzi,ogni giorno un pezzo di questo grande orrore,anche la campana nel cuore,là, dove il colombo fa il nidoe trova un minuscolo asilonella selva sulle acque.A lungo ho vissuto come pietrasul fondo delle cose.Ma ho sentito la campanaSussurrare il tuo segretonei pesci volanti.Imparerò a volare e a nuotaree lascerò tutto ciò che è pietra sotto la pietralascerò la malinconia coricata nella madreperla,ma solleverò in alto la rabbia e la miseria.Le mie ali sono più antiche della tua pazienza,le mie ali sono volate oltre il coraggio,che s’era fatto carico dell’errare.Voglio condividere il pane con i pazzilà, nella spaventosa selva del colombodove la capanna divide in tre parti il grande terroretrasformandolo nel suono tripartito del tuo nome.
***
Ti ho tuffato nella mia rabbia!
Ora sei d’acciaio sopra la terra
e sotto, mansuete, avanzano le tue radici
tra pietre scricchiolanti.
Non portarmi il grano! Non ti ho reso acciaio
per saziarmi o addormentarmi
a me spetta la metà di quella mela
che matura tra i rami dell’albero del serpente.
Spada o giglio – tu li sei entrambi a metà!
Voglio scagliare in alto la tua affilatezza
ed essere dolce sorella della terra
e indurre in tentazione Dio come lui ha fatto con me.
Ti ha tuffato tre volte nel mio cuore
e ti ha ordinato di rinunciare a lui
ma io ti ho immerso nell’acciaio della rabbia;
ora porta a suo figlio la mia metà della mela!
***
Mentre io, turbata, scrivo,
nel disco della luna piena brilla
la parola che osservo
da quando la colomba mi ha deriso
perché dallo specchio dell’acqua
senza nome, senza sigillo,
entravo nell’arido.
Non fosse cresciuta
la semina dell’osservazione
dovrei uccidere luna e colomba
che sempre m’ingannano
e fanno il nido sul mio albero del sonno
che per questo rinsecchisce.
Spesso una parola s’imprime a fuoco
da sé nella sua corteccia,
e allora mando quel cieco
messaggio, che inutilmente si rigira
aggredendo il tuo sonno
mentre nel disco della luna
è in salvo la risposta.
Christine Lavant morì a Wolfsberg nel 1973, all’età di 57 anni. Non lo sapeva allora che la sua voce sarebbe diventata alta e sarebbe uscita da quei confini che lei aveva sempre considerato un limite alla sua brama di libertà.
(Le poesie scelte appartengono al volumetto Christine Lavant, Poesie, scelte da Thomas Bernhard, nella traduzione di Anna Ruchat. Effigie Edizioni).
Questo testo viene pubblicato nella sezione “Rivista Nuova Euterpe” del sito “Blog Letteratura e Cultura” perché selezionato dalla Redazione della Rivista “Nuova Euterpe”, n°02/2024. L’autrice ha autorizzato alla pubblicazione senza nulla avere a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro.