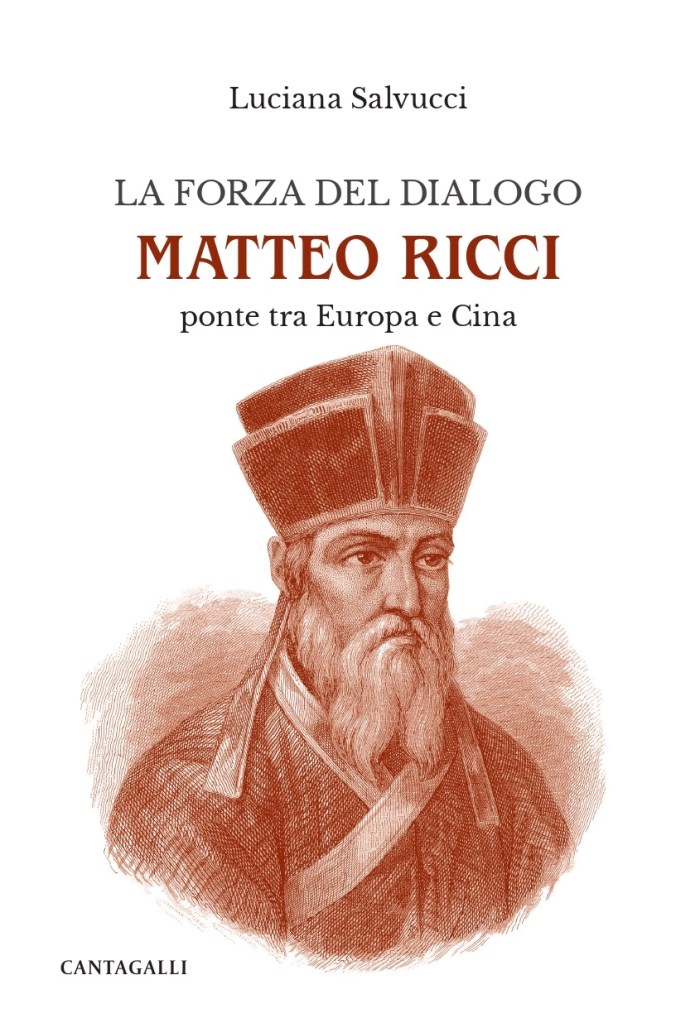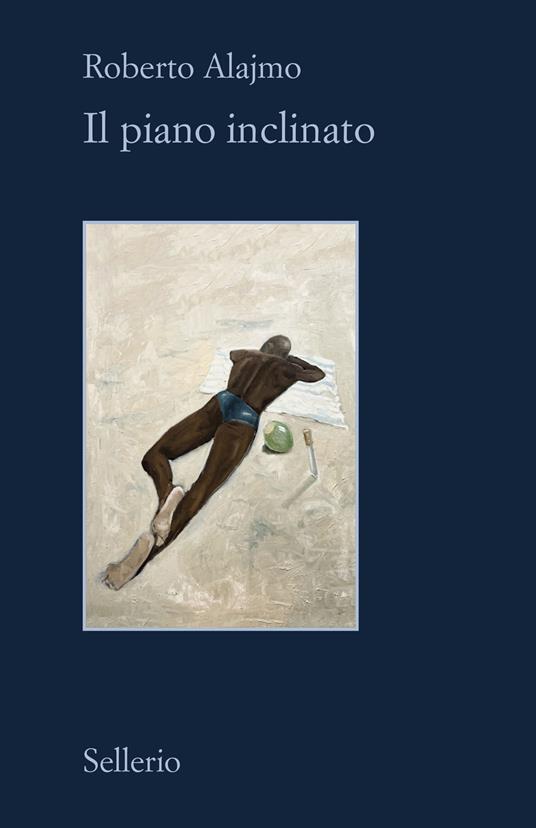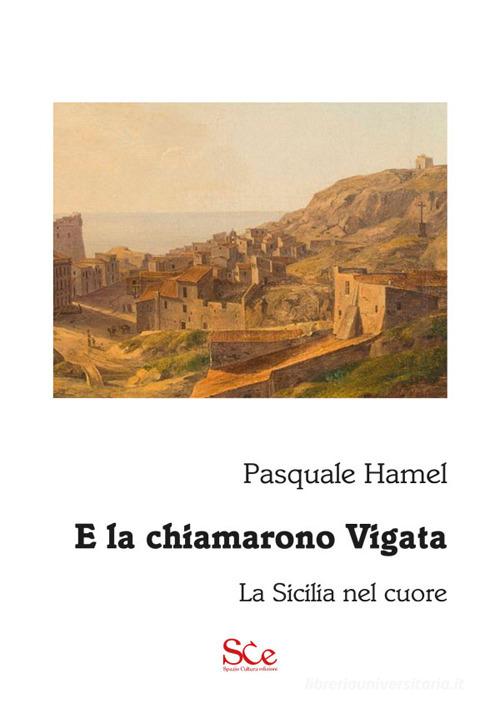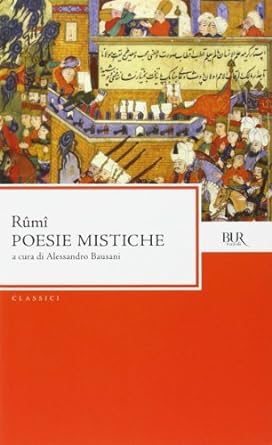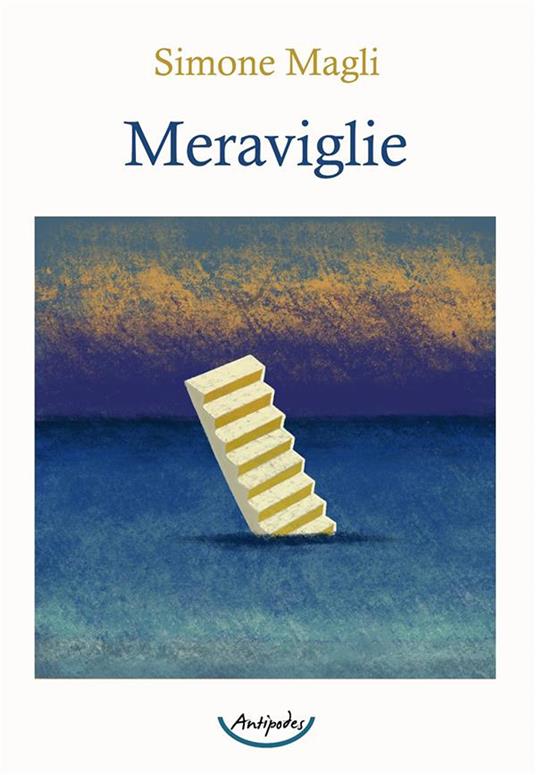Undici anni fa usciva un libro di poco più di novanta pagine: Fuori non è così di Miriam D’Ambrosio, pubblicato per la Collana Centocinquanta della Barbera Editore. Un breve viaggio in ventiquattro piccole tappe, intrise di sogni, passioni e paure, all’interno di quel “recinto magico” nel quale può trasformarsi una qualsiasi classe delle nostre scuole, laddove presenza, entusiasmo e motivazione di docenti e studenti riescono a convergere in quella sorta di “non luogo” privilegiato che è, a dire il vero, la conoscenza della vita stessa. Oggi, dal seme di quel delizioso fiore, è nata una nuova pubblicazione di quegli splendidi frammenti di anime, grazie all’editore Florindo Rubbettino, con l’aggiunta di nuovi capitoli che vanno ad impreziosire, senza scalfirne l’intensità, il racconto di quella quotidiana esperienza didattica.
Come ebbi già modo di scrivere, si tratta di un racconto leggero e sottile, che trasuda atmosfere familiari a tutti coloro che hanno varcato la soglia di una qualsiasi delle nostre classi e che le hanno vissute “dall’interno”, raccogliendo ogni istante come se si trattasse sempre del più prezioso. Una sorta di “collezionismo”, nel quale si fanno strada vitalissimi personaggi reali, deboli e coraggiosi al tempo stesso, che racconta un mondo, troppo spesso dimenticato e messo in secondo piano, che nutre e aiuta a crescere un numero inquantificabile di persone, al di qua e al di là dalla famigerata “cattedra”.
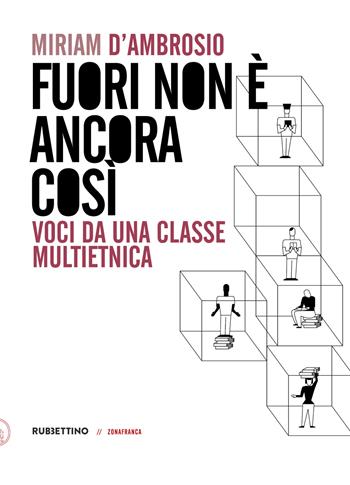
Il lavoro dell’autrice si rivela una preziosa rassegna di piccoli eroi del quotidiano, chiamati a galleggiare sulla precarietà del presente e a ritagliarsi, mai senza sforzo, il proprio posto nella vita; a questi piccoli eroi la “prof” (come si definisce, quasi a sottolineare un ruolo mai come adesso così sottoposto a continui tagli, imposizioni e ritagli) suggerisce letture e personaggi, danzando tra un romanzo ed un testo teatrale, proponendo assaggi mirati di vite appese ad un filo, dove il lieto fine (per quanto pesantemente auspicato) non è affatto scontato.
Un vero viaggio nella dimensione umana, che riesce a ripercorrere indelebili tappe della letteratura, con il coinvolgimento e la discrezione dei suoi grandi momenti, con la passione riservata al mistero quasi sacro della “prima volta”: l’amicizia raccontata attraversando le pagine di Pasolini e di Uhlman; il difficile rapporto con il padre, evocato ed affrontato sulle suggestioni di poeti come Leopardi, Saba o Sbarbaro; e ancora lezioni d’amore, con l’impronta pesante di Giulietta e Romeo o di Paolo e Francesca, dove si attraversa la tragedia, sballottati verso il dubbio e la passione irrefrenabile, feriti dal tradimento del fratello Gianciotto; la convivenza impossibile con la tremenda gelosia di Otello; l’immancabile e troppo spesso da noi trascuratissimo tema del “doppio”, dove si fatica a riconoscere dentro di sé un Mister Hyde da tenere a bada o un Minotauro da affrontare.
Un libro che nasce dall’amore e dall’equilibrismo quotidiano di una Professoressa (la maiuscola è d’obbligo) che ha scelto di non cedere all’immobilismo, continuando a leggere, vivere, rileggere e sognare, ma soprattutto che punta a condividere tutto questo con le persone, adulte e meno adulte, che le si affidano. Perché “Raccontare la bellezza dell’essere umano non è solo una scelta, è necessità. Lo stupore deve accompagnarci, è una specie di guida che non dà mai niente di scontato”. È la chiave di lettura più preziosa da condividere con i ragazzi.
E questi ragazzi vengono da Ghana, Costa d’Avorio, Senegal, Marocco, Egitto, Algeria, India, Pakistan, Filippine, Ecuador, Albania, Romania, Italia. Strabordanti di sogni e paure, sono qui in un istituto professionale, soprattutto per imparare un mestiere, ma ecco che le ore di Italiano si trasformano in un indelebile momento di condivisione. Miriam D’Ambrosio, nonostante il prevalente quasi costante grigiore della Val Padana, apre finestre davanti a loro, spalancandole sui colori del mondo, senza obbligare nessuno ad uscire, ma insegnandogli a nutrirsi di sguardi, riflessioni e racconti.
Seguirli in queste pagine e in questi oltre undici anni è toccare con mano la vita che scorre, avvertirne il cuore pulsante, osservarne i volti sempre nuovi che scrivono, pensano e parlano di Dorian Gray, seguono l’Innominato nella sua tormentata notte, giudicano i migranti di Sciascia, incontrano Pin nel suo rifugio, un sentiero dei nidi di ragno dove stare al riparo dalla realtà, tra le lucciole che rendono sopportabile il buio.
DAVIDE TOFFOLI
L’autore ha autorizzato alla pubblicazione su questo spazio senza nulla avere a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro. La riproduzione del presente testo, in qualsiasi tipo di formato, sia parziale che integrale, non è consentita senza l’autorizzazione dell’autore. La citazione, con opportuno riferimento al titolo completo, nome del blog, data di caricamento e link è consentita.