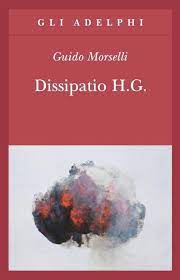Il 1° di marzo del 1922 nacque ad Alba (Cuneo) Beppe Fenoglio, il quale, nella seconda metà degli anni ’30, frequentò il locale ginnasio-liceo classico[1], dove, tra gli altri insegnanti, si trovò particolarmente a suo agio con la docente di inglese Maria Lucia Marchiaro. Delle lezioni di letteratura inglese durante gli anni ginnasiali egli ricavò non solo modelli linguistici, ma anche morali, così come possiamo ricavare dalle sue stesse opere, in cui uno dei riferimenti a lui più congeniali è la storia inglese del secolo XVII, rinvenibile in filigrana sia nella scelta del soprannome partigiano di Milton, che egli scelse per il protagonista di vari suoi racconti, sia nella figura emblematica di un round-head[2], cioè un soldato dell’esercito repubblicano di Oliver Cromwell, cui egli si paragona spesso[3].
Dal punto di vista linguistico, invece, l’eredità più evidente lasciatagli dallo studio dell’inglese è – come si sa – la presenza, massiccia ed invasiva talora fino al parossismo, di termini inglesi intercalati, con estrema nonchalance dovuta alla padronanza assoluta dello strumento linguistico, nel tessuto lessicale italiano del testo del romanzo Il partigiano Johnny[4], in cui la presenza di una sorta appunto di “sostrato” inglese ha fatto sì che l’attenzione sulla lingua dell’autore si concentrasse sui rapporti italiano-inglese, tralasciando (almeno in parte) il rapporto tra quella che doveva essere la lingua materna fenogliana, cioè il piemontese (sia la koinè che nella sua variante langarola)[5], e quella imparata sui banchi di scuola, cioè l’italiano.
La lettura dei testi fenogliani[6] ci presenta infatti una presenza continuativa di piemontesismi, sia (soprattutto) lessicali sia sintattici e fonetici, oltre ad un discreto numero di forme idiomatiche, presenti in maggior misura nelle parti dialogate, ma tuttavia non del tutto assenti anche in quelle narrative o descrittive. Certamente troviamo una maggior quantità di voci piemontesizzanti in testi ambientati nell’alta Langa e narrati in prima persona e/o con molte parti dialogate, come La malora[7], mentre più rare tali voci sono in testi o ambientati ad Alba (o con protagonisti comunque cittadini) oppure – dal punto di vista narratologico – che prevedano un narratore esterno.
1. Fonetica
Un solo esempio, nella Malora, di fenomeno fonetico piemontese: bei stupidi (406), adattamento del piemontese bej stùpid[8].
2. Lessico
Si collocano in questa categoria sia a) prestiti o calchi di parole piemontesi, solamente traslitterati in italiano, sia b) termini che, pur esistenti anche in italiano, sono tuttavia da Fenoglio usati in un’accezione peculiare del piemontese, differente rispetto al loro uso in lingua.
a)
bricco (brich): collina, altura, anche in senso metaforico “gran quantità” (cfr. it. “montagna di…”), un bricco di cose (397); cabalizzare (gabolisé): ipotizzare, indovinare (393); cadreghino (cadreghin, diminutivo di cadrega, “seggiola”): seggiolina (410); cascinai (cassiné): proprietario o conduttore di cascina (419); censa (censa): privativa di tabacchi (372); chiabotto (ciabòt): casetta rustica (407); corba (còrba/gòrba): cestino (381); diffizioso (difissios): diffidente, difficile da accontentare (398); disgenato (dësgenà): non imbarazzato (400) e, al contrario, genato (genà: imbarazzato; 412) e genava (dal verbo gené; 419); droganti (drogant): imbroglioni (392); frusto (frust): consumato (410) e sono frustato (sono consumato, dal verbo frusté; 425); lingeria (lingerìa): biancheria (423); macello gentile (masel gentil): macelleria, specificamente di vitelli (372); paglione (pajon): pagliericcio (379); partitante (partitant): compagno di gioco, di partita (405); paste dolci (paste dosse): pasticcini (405); pelandracce (plandrasse): sfaticate (usato come peggiorativo di plandra, pelandrona) stroppo di pelandracce (374); penduto (pendù): appeso (420); piumarli (piumé): spennarli, usato in senso metaforico (392); porrata (porà): termine di cui l’autore stesso dà nel testo la spiegazione[9] (434); rubarizio (robarissi): furto (409); sbardati (sbardà/sbardlà): dispersi (421); schiavenze (s-ciavensa): cura di un podere d’altri (431); schivare/schiviare (schivié, ed anche nella forma riflessiva schiviesse): mettere da parte, farsi da parte (riflessivo) schivarmeli (“mettermeli da parte”; 371) schivai un po’ di soldi (“misi da parte”; 429) oppure ancora “evitare, tenere lontano” se potevo schivarlo lo schivavo (419); sfisonomiata (nell’espressione “la voce… sfisonomiata”; [dë]sfusumià): alterata (425) ed allo stesso modo lo sfisonomiava (“gli storceva i lineamenti”, dal verbo dësfusumié; 405); smangiate (smangé): corrose, sfilacciate (410); stanchità (stanchità/strachità): stanchezza (408); si stortagnavano (stortagnesse): si contorcevano (408); stracco (strach): stanco (374); stroppo (strop): gregge, mandria (e per traslato: gruppo) stroppo di pelandracce (374); svegliarino (dësvijarin): sveglia (410); sversa (nell’espressione “anima sversa”; svers): sconvolta (399); tiretto (tirèt): cassetto (423); travata (travà): trave centrale (378).
b)
abbrancata (brancà): attaccata (401); andare (nel nesso “far andare”; fé andé): lavorare la terra far andare la terra (398); arrangiare (nell’espressione: “t’arrangia lo stomaco”; rangé): sistemare, mettere a posto (401); arrembarsi (arambesse): avvicinarsi ci si arrembarono (396); ascoltare (scoté): ubbidire (392); avanzare (vansé): evitare o risparmiare avanzare lo zolfino (373); battere (nell’espressione “battere i mercati”; bate ij mërcà): vendere al mercato (372 e 376); i bracci (ij brass): le braccia (375); budelle (buele): budella (380); buon’ora (bonora): presto (383); cimentarsi (cimentesse): stuzzicarsi, darsi fastidio si cimentavano (396); comandare (comandé): ordinare (usato in genere all’osteria) comandai una bottiglia (436); comprare (caté [na masnà]): partorire (423); contentare (contenté): accontentare mi contenta (377); cuciniera (cusinera): cuoca (389); fardello (fardel): corredo da sposa (387); figlio (specialmente nella formula “un bravo figlio”; fieul/brav fieul): ragazzo[10] (400), oltre che anche “figlio”; forgiare (forgé), usato come intransitivo: essere fatto in certo modo, pensarla in un certo modo ero forgiato (383); garretti (nell’espressione: “giù fino ai garretti”; garèt): talloni (395); gesto (gest): azione, fatto (specialmente in senso negativo) che gesto (395); giornata (giornà): misura terriera piemontese, equivalente a 3.810 m2 (379); giuntare (gionteje): rimetterci ci avrei giuntato (402); governare, solo nell’espressione “governare le bestie” (goerné le bes-ce): accudire alle vacche (430); incamminare (ancaminé), usato in forma transitiva: cominciare incamminargli il discorso (402); incontrare, usato in forma intransitiva assoluta (ancontré): avere fortuna non incontriamo (418); mancare (manché): (eufemistico) morire era mancato (371); mischiare (mës-cé): nell’espressione “mischiare un mazzo di carte” lo mischiava (404); naturale (natural): carattere (388); onta (onta): vergogna non ti piglia l’onta? (381) si lasciò prender dall’onta (432) e così l’aggettivo ontosa: vergognosa (405); originale (original): strambo (417); particolare (particolar): piccolo proprietario agricolo (387); partita (partìa [’d gent]): gran quantità, numero; nell’espressione “una partita di…” una partita di gente (404); pastura: il pascolare in pastura (374); perdonare (përdoné): condonare, lasciar perdere stasera ci perdonate il lume (405); pertugio (përtus): buco (386); pilone (pilon): edicola votiva campestre (407 e 428); ramazzare (ramassé): letteralmente scopare, ma usato col valore traslato di raccogliere, prendere tutto, far piazza pulita ramazzava la posta (404); riva: costa, fianco (di una collina) la riva da legna (373); rocca (ròch/ròca): masso, macigno (401); scorciare (scursé): accorciare scorciato i capelli (377); scuro (scur): sera (nella locuzione a scur: a sera) a scuro (372); servente (serventa): serva, domestica (383); servire (serve/servì): essere servitore (in campagna) avevano già servito (377); slargare (slarghé/slarghesse): spargere si slarga la voce (410); soffrire, transitivo e in espressioni in genere negative (sufrì/seufre): sopportare non poteva soffrirlo (419); solette (nell’espressione “far solette”; fé solëtte): fare la calza (426); spesso, come sostantivo: l’insieme ammassato di qualcosa lo spesso delle case (382); spogliare, nell’espressione “spogliare la meliga” ([dë]speujé): sfogliare il granoturco (dëspeujé la melia; 419); studiare (studié): pensare attentamente, riflettere o cercare una soluzione lasciami studiare (399); svariare, usato come intransitivo pronominale (svariesse): divertirsi (412); taglie (taje): tasse pagare le taglie (373 e 378); tempesta (tampesta): grandine (378); tirare, nell’espressione “mi sentivo tirato verso”; essere attratto (406); tossico (tòssich/tòssi): veleno (380); uomini (òm/òmini): mariti (389); inoltre l’espressione buonuomo per “sempliciotto, ingenuo, poco furbo” (407); vegliare (vijé): nel senso specifico di “si faceva la vijà (veglia) nella stalla” (398); verga (vërga): fede nuziale (387).
In particolare notiamo l’uso dei pronomi, quello delle reggenze verbali, ed alcune costruzioni sintatticamente diverse da quelle italiane, alcune delle quali – invero – potrebbero anche essere registrate nell’elenco, successivo, delle forme idiomatiche.
da me solo: da me (372; da mi sol); non me ne sarebbe fatto niente: importato (380; a sarìa famne gnente); mentre che ero: mentre ero (382; mentre ch’i j’era); tanta di quella gente: così tanta gente (383; tanta ’d cola gent); della meglio: della migliore (387; dla mej); niente del tutto: assolutamente niente (390; nen d’autut); con tutto che: per quanto, benché (394; contut che); con più niente da dire: senza nulla più da dire (398; con pì nen da dì); né di sì né di no: né sì né no (400; che ’d si e che ’d nò); guardava di storto: guardava storto (400; dë stòrt); da raro: raramente, di rado (402; da ràir); dirmelo amico: considerarlo amico (404; dimlo amis); lungo questa settimana: durante (405; arlongh costa sman-a); discorrergli insieme: parlargli (407; ciaciareje ’nsema); ce n’è almeno mezzi più indietro di me: c’è almeno la metà meno bravi di me (412; a-i n’j’é almanch mesi); per nostro conto: per conto nostro (416; për nòst cont); né più né meno che te: di te (417); aveva solo fatto che prendere: non aveva fatto altro che… (419; a l’avìa mach fàit che); non si sentiva più che chiamare: si sentiva solamente chiamare (420; as sentìa mach pì ciamé); esserci al caso: essere nel caso in cui (420; esse al cas); fin passato: fin oltre (420; fin-a passà); il più su che arrivai: il punto più alto a cui… (421; ël pì sù ch’i son rivaje); a mio povero figlio: usato senza l’articolo determinativo (438; a me pòvr fieul).
Forme idiomatiche ovvero modi di dire tipici del parlato quotidiano
sia scesa alla mira di: sia arrivata al punto di (372) e siamo a una buona mira: siamo ad un buon punto (379); in mira ai figli: di fronte ai (380) e alla mira degli altri, all’altezza degli altri (383); si viene a una mira che: si arriva ad un punto che (409)[11]; col cuore in bocca: col cuore in gola (373); Braida: uso del cognome, da parte della moglie, per indicare il proprio marito (374 e 423: Rabino); con del buon tempo: tempo da perdere (374; ëd bontemp); tirò un numero: andare di leva (374; tiré ’l nùmer); in paga: in contraccambio, in ringraziamento (375 e 421; an paga); il mazzo ce l’aveva sempre lui: era sempre al centro dell’attenzione, teneva sempre banco (375; avèj ël mass an man); uno scudo: moneta da 5 lire (375); le dava dei nomi: la insultava (376, dé dij nòm/nomass) e mi caricavi di nomi: di improperi (423); alla larga nel bosco: libero (377), mi diede la larga: mi lasciò libero (384) e diede la larga: liberò (420; dé la larga); bestemmiare un’esagerazione: moltissimo (381); sotto il grano e sotto l’uve: al tempo del raccolto del… (381); c’è posto che: può darsi che (381); alzargli gli occhi in faccia: guardarlo in faccia, negli occhi, sfidarlo (384); o assassino: disgraziato, usato come insulto (384, ah sassin!); per quattr’ore: per le quattro (384; quatr ore); allungato le gambe sotto una tavola: mettersi a pranzo, in genere nelle feste (387; slonghé le gambe sota la tàula); cos’aveva visto: cosa le era capitato (390; cò a l’avìa vist); ci faceva basta: ci bastava (392; a fà basta); gli aveva dato sul cuore: danneggiato il cuore (394; dé an sël cheur); il tempo s’era girato: era cambiato (396; ël temp a l’era virasse); dare i due botti: suonare le due (398; dé ij doi bòt); le case in faccia: di fronte (398); le disse tutto attaccato: tutto di seguito (399; tut tacà); parlato del vento e della pioggia: del più e del meno (400; dël vent e dla pieuva); m’aveva attaccato una festa: aveva parlato male di me (404; taché na festa); non c’è nessun confronto: non c’è paragone (405; pa gnun confront); della mia leva: mio coscritto, coetaneo (406); assaggiarlo bagnato nell’olio: averci a che fare sempre (407; tastelo bagna ’nt l’euli); con la pancia lunga: dover attendere quando si ha fame (411; avèj la pansa longa); di sua scienza: di testa sua, con la sua esperienza (414; ëd soa siensa); toccarlo nei soldi: toccare negli affari o costringere a pagare o ancora chiedere un prestito (415; tochelo ant ij sòld); allegro: modo di salutare (415; alégher!); una faccia mezzo e mezzo: così così (417; mes e mes); madame di cascine: signore cascine (418); avevano più caro: preferivano (419; avèj pì car) e ho più caro (427); venivo su a once (probabilmente altra grafia per a onge, cioè “a unghie”): a piedi (421); passata sul raspo: alla meno peggio, alla lontana (426; calco per passà sla rapa); che metà bastavano: che erano fin troppe (427; la metà a vansava); non era fuori del caso: non era impossibile, strano (428; pa fòra dël cas); mi tiravano le satire: mi prendevano in giro (434; am tiravo ’d sàtire).
[1] Intitolato al generale e uomo politico Giuseppe Govone (1825-1872).
[2] Letteralmente “testa rotonda”: così erano popolarmente chiamati i soldati di Cromwell in quanto, in opposizione alla monarchia ed alla nobiltà, non portavano la parrucca.
[3] Sappiamo che Fenoglio tradusse alcune parti, per proprio interesse, della biografia di Cromwell dall’edizione inglese di Charles Firth (1857-1936), edita nel 1900. Inoltre, acutamente Davide Lajolo intitolò proprio Un guerriero di Cromwell sulle colline delle Langhe la sua biografia dello scrittore albese, che avrebbe certo voluto essere «un soldato di Cromwell con la Bibbia nello zaino e il fucile a tracolla», come ci rivela il suo amico e maestro Pietro Chiodi, suo professore di filosofia al liceo.
[4] La presenza di termini inglesi inseriti nel fluire della narrazione aveva fatto ipotizzare ad alcuni critici che tale romanzo, nella sua interezza o almeno in molte sue parti, fosse stato concepito direttamente in inglese, e poi tradotto in italiano, lasciando tuttavia alcuni relitti inglesi al suo interno. Tale ipotesi è stata poi confermata da un frammento, edito col titolo di Ur-Partigiano Johnny, di alcuni capitoli del romanzo scritti direttamente in inglese.
[5] Le vicende storiche e socio-linguistiche del Piemonte hanno fatto sì che nella regione, oltre alle varie forme dialettali locali (nel caso di Fenoglio il langarolo), si costituisse una koinè sovraregionale, in pratica coincidente pressoché del tutto col torinese. Tale koinè era, almeno fino a circa 70/80 anni orsono, compresa (e spesso anche usata) anche da coloro che normalmente usavano nel loro parlare quotidiano la loro forma dialettale locale. Questo doveva essere il caso di Fenoglio, così come di quasi tutti gli abitanti borghesi delle principali città e cittadine (come Alba) del Piemonte.
[6] L’opera omnia di Fenoglio è stata edita in Opere (ed. critica diretta da M. Corti); Torino (Einaudi) 1978. Vol. Primo (Tomo i): Ur-Partigiano Johnny [Ur] (a cura di J. Meddemmen); (Tomo ii): Il partigiano Johnny [PJ] (a cura di M. A. Grignani); (Tomo iii): Primavera di bellezza [PB]; Frammenti di romanzo [FrR]; Una questione privata [QP] (a cura di M. A. Grignani); Vol. Secondo: Racconti della guerra civile [RGC i-vii]; La paga del sabato [PS]; I ventitré giorni della città di Alba [VGA i-xii]; La malora [M]; Un giorno di fuoco [GF i-xii] (a cura di P. Tomasoni); Vol. Terzo: Racconti sparsi editi e inediti [RS]; [Quaderno Bonalumi; QB]; [Diario; D]; Testi teatrali [T]; Progetto di sceneggiatura cinematografica [Sc]; Favole [F] (a cura di P. Tomasoni); Epigrammi [Ep] (a cura di C. M. Sanfilippo). Le citazioni in questo nostro lavoro sono fatte seguendo tale edizione.
[7] Proprio per tale motivo ci siamo limitati, per ora ed in questa sede, ad affrontare, segnalando sempre la pagina secondo l’edizione einaudiana di riferimento, il testo della Malora, quale opera più fortemente “piemontesizzante”, rimandando ad altro momento l’analisi di altri testi narrativi fenogliani. Sulla lingua di questo breve romanzo si veda anche B. Villata, La langue de la malora, in “L’Arvista dl’Academia” vii (Luglio-Settembre 1997), pp. 29-46.
[8] Anche nelle altre opere i casi sono rarissimi. Segnaliamo solamente, a mo’ d’esempio, dei zolfini (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], pag. 13): non esistendo in piemontese il suono della z italiana, esso viene sostituito da quello della s sonora.
[9] «che è una traccia di porri e meliga che si semina verso la porta di chi è stato lasciato da una donna nel giorno che lei si sposa con un altro». Il dizionario di G. F. Gribaudo (Dissionari piemontèis; Torino 19963) alla voce porà recita “minestra di porri”, mentre alla voce povrà (facendola derivare però da póver, “polvere”) ci dice “striscia di crusca che si spingeva fin sulla porta di chi era stato rifiutato in matrimonio”.
[10] Lo stesso per il femminile fija: “ragazza” oltre che “figlia”.
[11] Tutte queste forme originano dal valore del termine mira: “punto, altezza, riferimento, segno” (cfr. Gribaudo, cit., s. v.).
*
Questo testo viene pubblicato su questo dominio (www.blogletteratura.com) all’interno della sezione dedicata relativa alla rivista “Nuova Euterpe” a seguito della selezione della Redazione, con l’autorizzazione dell’Autore/Autrice, proprietario/a e senza nulla avere a pretendere da quest’ultimo/a all’atto della pubblicazione né in futuro. E’ vietato riprodurre il presente testo in formato integrale o di stralci su qualsiasi tipo di supporto senza l’autorizzazione da parte dell’Autore. La citazione è consentita e, quale riferimento bibliografico, oltre a riportare nome e cognome dell’Autore/Autrice, titolo integrale del brano, si dovrà far seguire il riferimento «Nuova Euterpe» n°01/2023, unitamente al link dove l’opera si trova.