La vasta produzione poetica – in dialetto messinese (di Malvagna) e in lingua italiana – di Josè Russotti (31 marzo 1952 – Ramos Mejìa – Argentina) appare fortemente omogenea sul piano tematico ma assai diversificata sul piano stilistico-linguistico (per peculiarità che sono tutte da verificare) e come attraversata da una perenne, progressiva ricerca espressiva: opera, senza meno, in fieri di un poeta che mira sagacemente alla conquista dello stile.
Il poeta di Malvagna esordisce nell’arengo poetico con una vibrante, commossa raccolta di poesie dialettali (con traduzione italiana a piè di pagina), Fogghi mavvagnoti,[1] che dell’«opera prima» possiede tutti crismi (sviste e refusi compresi). Vi si percepisce, immediatamente, l’amore viscerale di Russotti per il paese della sua infanzia – vero e proprio leitmotiv – tuttavia frustrato dalla delusione per quella che pare un’irreversibile sparizione: «Urìa stari ‘ssittatu subbra un furrizzu ‘i ferra / a menzu â campagna ciuruta di Pìttiri. / […] Ma non c’è vessu e modu di nuddha manera / ‘i truvari u sint’ri chi carusu avìa scapicciatu» (Urìa stari);[2] e ancora: «Lucia di centu dottrini, / non vidi chi stu paìsi pinìa / e mòri senza na raggiuni?» (Donna Lucia Pantano).[3]È forte, invero, il disappunto dell’io poetante per l’attuale vita-non vita del paese «china di lazzi e ruppa» e il suo desiderio inappagato di «nnèsciri ô chianu» (Mi veni iàddita).[4] Trapela anche nettamente, nella raccolta, la sensibilità sociale di Russotti per le sofferenze degli ultimi (Canzuni pi un drogatu, Turi Cacotta, L’emigranti), accentuata dal suo tormento di figlio desolato dopo la morte del padre (U scontru) e della madre (E jò chi n’ha vistu mòriri mai a nuddu, 7 febbraio ’99). Trascorre peraltro nei testi, per brevi cenni, tra immagini di crudo realismo, qualche lieve meditazione sui grandi temi del bene e del male, del tempo irrevocabile, della vita che fugge, della morte che incombe (Parori, Ora mi veni, Don Micu Scrofani, Acqua chi scenni e s’incanara, Comu attenti suddati). E ritorna sovente, per concreti, espliciti riferimenti, l’attaccamento carnale, sensuale del poeta all’amore (U nsonnu, Chi nostri cori, A surgiva, Quanti uòti, Niàutri dui).
Sul piano linguistico-stilistico, Fogghi mavvagnoti è, però, a tutti gli effetti, un’opera radicalmente intessuta di termini, locuzioni, stilemi popolari rimemorati agevolmente dal poeta di Malvagna e trasposti felicemente sulla pagina con i loro forti accenti realistici, senza particolari mediazioni autoriali che non siano quelle relative all’armonia, al ritmo, alla testura dei versi, che paiono, invero, «senza tempo tinti». Talché, parafrasando un titolo di Marcuse, questa prima raccolta di Russotti, parrebbe «a una dimensione»: quella realistico-referenziale della poesia dialettale tout court. Si rilegga, a conferma, la prima strofa di Spondi dill’Alcantara: «Uci di fìmmini si lèunu / ndê spondi dill’Alcantara. / Uci di matri patuti / che càntunu chini di prèjiu / vannu dritti e vagghiaddi / chî so’ cufini subbra a testa»,[5] dove la precisione dei dettagli non differisce punto da quella che si può ritrovare in un saggio di antropologia culturale o, meglio, nel quadro di un pittore realista, come Courbet.
La raccolta di poesie in lingua italiana, Spine di Euphorbia, pubblicata, quindici anni dopo[6], contiene liriche che si muovono nello stesso ambito tematico-contenutistico della precedente, ma appare del tutto nuova sotto il profilo stilistico. C’è, invero, un salto tra Fogghi mavvagnoti e Spine d’Euphorbia che non si spiega solo col cambiamento del codice linguistico (dal dialetto mavvagnotu alla lingua italiana) e con il lungo intervallo tra l’una e l’altra, ma presuppone una radicale svolta, se non una rivoluzione effettiva, nella maniera d’intendere e praticare la poesia, da parte di Josè Russotti, che sembra ora privilegiare la dimensione metaforico-simbolica dei testi, probabilmente mutuata dalla lettura dei poeti maggiori del Novecento (García Lorca in primis, già ricordato dallo stesso Russotti nella prima raccolta, i maudits francesi nonché gli italiani ermetici e post ermetici, conosciuti in occasioni non programmate),[7] ma fatta propria dal poeta nei modi entusiastici del neofita che idoleggia il tesoro di cui è venuto in possesso, cavandone impensate potenzialità espressive. Vale la pena di rileggere la prima lirica della raccolta, Madre sola, dove il flusso continuo di metafore, similitudini e simboli, senza annullare la realtà e conservando un altissimo grado di leggibilità, concorre a un canto-pianto che riesce a sfiorare le vette del sublime: «Madre di nulla vestita! // Vestita del tuo dolore che è pianto / del tuo lamento che è canto / Madre senza neppure aspettare / e quasi alla fine dei miei passi / ti riscopro brace per l’inverno inoltrato […] All’ombra dei tuoi capelli argentati / diventavo quieto come un agnello / e ambivo le carezze della notte […] Madre di nulla vestita. Madre da sempre sola / adesso ti rincorro nei rimpianti della sera».[8]
Non mancano, invero, nella raccolta, casi di iperfigurativismo (da neofita), in cui le metafore si susseguono di verso in verso, senza riuscire a essere illuminanti: «Dentro un fuoco di lava / appaio sconfitto e detestabile/ e tale perduro // Gli occhi in lutto / bagnano l’ossario aperto / di filo spinato // Si taglia a fette / questa piaga immensa / dentro un sogno di latta / che non trova nei ricordi / un qualsivoglia riscontro // I morti / giacciono in me» (I morti giacciono in me).[9] Ma bisogna riconoscere che il poeta, in Spine di Euphorbia, riesce, perlopiù, a combinare in un’armonica cifra stilistica, il piano realistico (degli affetti familiari, della vocazione sociale, dell’amore-disamore per il paese di origine), e il piano simbolico-metaforico della poesia novecentesca, conseguendo altissimi livelli poetici. Basti ricordare A Very, All’alba di un giorno qualsiasi, A-sintonie instabili, Con l’attesa ferma nel cuore, Disomogenie malvagnesi, Graffio l’angolo di vetro, I negri invisibili, L’ultimo passo (a Sebastiano, mio padre), Mai t’amai così teneramente, Noi chiedevamo solo amore, Non piangere per me Malvagna, Se vuoi infrangere, Sul filo amaro della vita, Vegeto in una crepa di luna, Vòlto a scavare. La scoperta della dimensione metaforica della poesia produce peraltro un altro notevole scatto, rispetto alle raccolte precedenti, in Spine d’Euphorbia, dove l’amore della donna amata, si traduce in immagini della natura circostante che, a loro volta, prefigurano modi pensosi, drammatici dell’Essere all’insegna della precarietà, della provvisorietà, se non della insignificanza del mondo. (Avvinto, Ci sorridemmo, Del tuo tenue sapido effluvio, Eri qui, Nudo amore, Spine d’Euphorbia, Steli di Tamaro fra le dita, Ti lascio una crepa di vita). In questo ambito si coglie, peraltro, qualche timido riflesso del cristianesimo sofferto di Russotti (Sotto il sole d’agosto).
La rivoluzione stilistica evidenziatasi in Spine d’Euphorbia si riflette nelle liriche in dialetto della raccolta Arrèri ô scuru, pubblicata due anni dopo, presso Controluna (Roma 2019).[10] Vi si ritrova, profondamente ramificata, la forte, abituale materia sentimentale (l’amore della madre – Matri sura -, del padre – Unn’eri, E campu ‘i tia -, della moglie – Ciatu c’appoj diventa aria e si sciàmina, U to’ ciàuru di sempri, della figlia – Figghia chi resti ntô cori pi sempri), insieme con la vocazione etico – sociale (Di russu virgogna ora è u ma’ duluri, ‘Nfin’a quannu, Nino Bongiovanni, u putaturi, Ntâ sta terra di Sicilia) e con un’accentuata tensione introspettiva (Si tesci di dumanni a tira, Intra un vacanti ‘i nenti) dell’io poetante. Ma – quel che più conta -pullulano sulla pagina le figure retoriche (similitudini, metafore, simboli) tipiche della poesia in lingua del Novecento, già ampiamente sperimentate in Spine d’Euphorbia, qui utilizzate, però, con maggiore discernimento, senza alcuna perdita di senso. Si rilegga la prima poesia (che dà il nome alla raccolta), Arrèri ô scuru, dove, in pochi versi, mirabilmente fioriscono luminose metafore, atte a rendere nuovo il motivo eterno dell’amore: «[…] Ma ‘a notti è fatta suru di sirènzi, / unni mi peddu e mi cunfunnu / sutta na cutra di ‘nganni e llammìchi. / Femma u passu e vèstiti d’amuri, / picchì si’ timpesta subbra i puntara, / simenza d’addauru ‘i chiantari».[11] La documentazione di tale miracolo di armonia espressiva, per via di limpide metafore, potrebbe essere, invero, sterminata: ricorderemo, per sommi capi, «A puisia è simenza chi scava ntâ terra, / ràrica chi nun canusci cunfini», in A pusìa è …;[12] «Urìssi pi sempri a to’ bucca di meri», in Ciatu c’appoj diventa …;[13] «Si non si’ ccà a mmenzu a nuiàtri / a cantari a to’ gioia e a to’ alligria» in E campu ‘i tia;[14] «I campani sònunu a luttu subbra / i cappotti ‘ncurvati d’u friddu», in Figghia chi resti ntô cori …;[15] «Mu sentu d’incoddu / u to’ ciauru di fimmina e matri», in U to’ ciauru di sempri;[16] «Matri di nenti vistuta, / vistuta d’u to’ duluri chi è chiantu», in Matri sura;[17] «Ntâ sta terra di Sicilia / […] lorda / di mafia e bucchi ‘ntuppati», in Ntà sta terra di Sicilia, p. 78; «sutta a ràrica d’u rimpiantu» («sotto la radice del pianto») in Ntô mari lavu tutti i ma’ peni.[18] Su questa via, vòlta a una sempre maggiore limpidezza espressiva, procede invero, come vedremo, il poeta di Malvagna nelle raccolte successive, in cui si va perfezionando la sua travagliata conquista dello stile.
Il processo avviato nelle poesie dialettali di Arrèri ô scuru s’intensifica nelle liriche della seconda raccolta poetica in lingua, Brezza ai margini[19], di Josè Russotti, il quale continua a privilegiare la curvatura metaforica, novecentesca dei testi, ma mira, nel contempo, con maggiore convincimento, alla comunicazione, alla leggibilità, alla poesia «corale», per dirla con Quasimodo.
Le prime cinque liriche della prima delle due sezioni di cui l’opera si compone, Amare è vita, sono stabilmente imperniate sulle volizioni, i pensieri, le angosce di un io poetante tuttavia speranzoso, che avverte nel «silenzio dell’erba» il grido di dolore di chi nei «vicoli stretti del […] presente» non trova più «la porta di casa»,[20] o soffre per «il vuoto degli assenti»,[21] o rievoca, nella «bolgia infinita della sera», le «intrepide illusioni mancate»,[22] o si conforta sapendo che, «come per incanto / sorgerà il sole del mattino»,[23] o cerca un conforto frugando «nei vicoli / carichi di remoti silenzi».[24] Seguono tre liriche (VI, VII, VIII) imperniate sulla tecnica allocutiva dell’io/tu, che costituiscono autentiche invocazioni d’amore alla moglie: accolga lei, «nelle pieghe del suo dolore»,[25] le lacrime del suo uomo; la sua mano non si stanchi di dare al poeta «un senso di raro sollievo» (degno di attenzione l’intenso distico: «Me lo sento addosso / il tuo odore di femmina e madre»,[26] versione italiana del verso sopra citato di Arrèriô scuru); se l’amore dovesse affievolirsi («Se dovessi frugare nel vano / del tuo ventre acceso»), lei sicuramente saprà «aprirgli il cuore».[27] La tensione erotico-espressionistica si prolunga nella lirica successiva, in cui il poeta si prefigura che «Brandelli di lusinghe» e «bocche sconosciute e intrepide /accenderanno il suo cuore / nella bolgia della sera».[28] La decima lirica della raccolta è una dolorosa, ma stilisticamente compiuta, rievocazione della madre morta: il poeta cerca in casa ma «non trova più niente di lei»; il suo cuore «cade a pezzi», ma egli aggiunge «una goccia all’origano nel vaso di suo madre» (il verso è davvero sublime) sperando che ritorni.[29]
La seconda sezione, Angoli bui nel silenzio, della raccolta si apre con una lirica, la XI, in cui l’io poetante canta mestamente la morte del padre scomparso quando egli era in tenera età: «L’assenza / è un suono molteplice di arpe sulla riva / […]».[30] Al padre è anche ispirata la lirica XVII che forma con la XI un singolare dittico filiale. Il dodicesimo componimento è quello più gonfio di crudo, corposo realismo, prossimo – parrebbe – ai moduli espressionistici della poesia di Cattafi: «la grandine sui tetti», il «sangue dalla croce», la «fame che divora le budella», il «gesto inconsulto / di chi disperde il seme», il «vento tra la gramigna», «lo sputo sui vetri», il «vino rosso […] nello stipo»:[31] brandelli, invero, di una vita vissuta tra stenti, lontano dagli agi, e tradotti in una tormentata musicalità. Segue quella che si definirebbe «una trilogia della gente»: tre ampie liriche «corali», in cui il poeta, messo da parte il suo io dolente e risentito, guarda attorno a sé, divenendo quasimodianamente partecipe del dolore degli emarginati che sono vessati dagli uomini e dalla sorte: gli emigranti, extracomunitari, in ispecie, vittime della brutalità della storia e i morti di Covid. In essi il poeta emigrante si identifica, a tal punto che, nella prima strofa, della XIII poesia, presta loro la sua voce e diventa di fatto uno di loro: «Ci ha lasciato la madre che ci nutrì / col latte del seno e sedano crudo» (un distico sublime, invero).[32] Nella lirica successiva, la «gente» (forse, i parenti dei morti per Covid) «piange e stringe le ossa / dentro un fazzoletto intriso di memoria»,[33] e nella quindicesima il poeta «corale» registra accorato il «greve allinearsi delle bare».[34] Della stessa temperie stilistica sono i componimenti XX e XXI, in cui lo stesso acceso espressionismo presiede alla visione dei corpi dei migranti che «emergono e poi affondano […], / gonfi di sterile salgemma»;[35] mentre «le barche approdano vuote»: il poeta porge «alla faccia stupita degli stolti / un piatto ben condito di sapienza».[36] Nella lirica XVI, domina, tra illusioni e delusioni dell’io poetante, «la noia di certe giornate disadorne», mentre lo sguardo cade «sulla lumiera di carni putrefatte e scheletro» (di cattafiana memoria).[37] Seguono tre liriche (XVII-XIX) in cui ritorna la voce disillusa del poeta, che rifiuta ogni ipotesi consolatoria dell’aldilà («la morte è solo un gelido varco interiore / nella vanità dissoluta del transito finale»)[38] e ridimensiona il ricordo, più o meno affettuoso, che di lui avranno i compaesani, agognando semmai l’infinità che solo l’arte può dare («vivere ancora e poi ancora / e ancora, nel fertile cuore / dei fragili»),[39] e guardando in faccia la morte «che scivola sul destino delle cose».[40] La paura del disamore o meglio della fine dell’amore ritorna nella mesta lirica XXIII, che sembra costituire il pendant pessimistico («un ristagno di silenzi / innanzi alla fisica estraneità di mia moglie»)[41] del trittico alla moglie (della prima parte). Vi si collegano, per l’intonazione elegiaca, i due ultimi componimenti soffusi dalla malinconia del tramonto: «ogni gemito diviene / un tormento di rondini in pena».[42]
L’autore di Brezza ai margini è, in effetti, un poeta che patisce (o ha patito) sulla sua pelle il dolore, la sofferenza, l’ingiustizia del mondo, approdando a una visione amara (ma non sconfitta), leopardiana se vogliamo, della vita e dell’arte: un uomo dimidiato, ad ogni modo, come un poeta medioevale, tra il sogno o il rimpianto del paradiso e l’amara certezza dell’inferno.
Nello stesso anno, qualche mese prima – precisamente nel gennaio del 2022 –, Josè Russotti dà alle stampeuna sorprendente raccolta di trentanove liriche in dialetto malvagnese,[43] con traduzione a fronte in italiano, distribuite in sette sezioni: I) Pî mapatri; II) A Mariacatina, ma’ matri; III) A mia moglie; IV) A Elyza, mia figlia; V) Nei giorni chiusi; VI) A Malvagna, il paese della memoria ritrovata; VII) Sulla vita e sulla morte. Quanto dire che Chiantulongu racchiude, come le altre raccolte e forse più compiutamente – alla stregua di un organico canzoniere d’antan – la vita e la storia personale dell’autore, talché, a lettura ultimata, sapremmo tutto di lui anche se non lo conoscessimo affatto: il legame fortissimo con la sua famiglia di umili origini (padre, madre, moglie, figlia); l’amore per Malvagna, il paese nativo (da cui il Russotti padre, indomito contadino in cerca di lavoro e di fortuna era emigrato per trasferirsi in Argentina, insieme con la moglie, e a cui, come tanti, era ritornato nel 1959, con moglie e figli); la sensibilità sociale, esplicita nella quinta sezione, Nei giorni chiusi, dedicata ai tragici effetti del Covid 19; il suo profondo, insanabile dissidio esistenziale, nella sezione finale Sulla vita e sulla morte. Ma quel che più colpisce è non solo il perfetto recupero, che vi si registra, di termini e locuzioni dialettali forti, efficaci, del tutto inedite (epperò pregne di un ancestrale nitore primigenio), ma anche l’attitudine del poeta a coniugare, sullo stesso asse linguistico, i colori antichi della poesia dialettale e le più ardite forme della poesia contemporanea, senza sbilanciamenti di sorta verso nessuno dei due poli espressivi. Donde, in altri termini, la coesistenza (come in Arrèri ô scuru, ma con maggiore pregnanza), in uno stesso componimento, del registro realistico, tipico della poesia popolare, col registro meditativo, introspettivo, allusivo, tipico della poesia novecentesca. Si veda come nella lirica finale (Davanzi a sti petri) della sezione dedicata all’indimenticabile padre (morto giovanissimo, dopo il ritorno in Sicilia), alla sequenza dialettale «mutu, restu ora, / davanzi ô to’ ricoddu / ‘ngudduriatu e suru» («silente, rimango adesso, / dinanzi al tuo ricordo / avvolto e solo») segua, senza soluzione di continuità, un verso allusivo di chiara matrice ermetica: «ndâ frèvi d’u sirènziu» (nella febbre del silenzio).[44] Allo stesso modo, nella lirica finale (Cu ddu sapuri di …) della sessione dedicata alla madre, morta dopo lunga e penosa malattia, sono perfettamente associate locuzioni contadinesche («ô brisciri d’u matinu») e forme di levatura novecentesca: «E di ora â fini / nniàvi u to’ coppi / ndô ballàriari mutu / d’u tempu!» («E da ora alla fine / annegavi il tuo corpo / nella muta sospensione / del tempo!»).[45] Ma le citazioni di questo che pare essere lo stemma esemplare della poesia di Josè Russotti sono numerosissime, nella raccolta. Ci si limita a evidenziarne qualche altra particolarmente pregnante.
Nella sezione dedicata alla cara moglie, la lirica Dumannu a tia dipinge la moglie con un dittico «muta ti nni stai ‘i canzàta / intra un faddari chinu ‘i pinzèri» («muta te ne stai in disparte / dentro un grembiule colmo di pensieri»),[46] dove il primo verso («muta ti nn stai ‘i canzàta») è desunto tale quale, dalla parlata locale mentre il secondo («intra un faddari chinu ‘i pinzèri») è immagine di raffinata caratura stilistica. Eppure, l’accostamento non stride affatto. Allo stesso modo, in Rìnnina d’amuri, la dolce figlia Elyza, prematuramente scomparsa, giunge «lorda ‘i brizzi» («sporca di sorrisi») – il di specificativo dopo l’aggettivo è usuale nelle poesie degli Ermetici –, ma la similitudine del verso successivo («commu na rìnnina ô giuccu» – «come una rondine al nido») è normale nel linguaggio popolare.[47] La stessa armonica associazione di stilemi popolari e figure retoriche ultramoderne si coglie agevolmente nelle liriche della sesta sessione, dedicata a Malvagna, dove l’amore del paese natio fa tutt’uno col dolore per «la sua sventura» di «paese che muore»: «Chiossai d’u ‘nvernu iratu / disìu a nivi janca di latti, / quannu u cantu d’i cicari fa a junnata. / Nivi fina di farina cinnuta / a cummigghiari i tènniri chiantimmi. / Mentri, / tutt’attornu ô paisi / matura u tempu, / avanza a motti» («Più dell’inverno gelato / bramo la neve bianca di latte, / quando il canto delle cicale fa la giornata. / Neve fina di farina setacciata / a coprire i teneri boccioli. / Mentre, / tutt’attorno al paese, / matura il tempo, / avanza la morte»).[48] Ugualmente intessuti di forme lessicali tratte dall’immaginario popolare di Malvagna e di stilemi postermetici sono i componimenti dell’ultima sezione, in cui si squaderna l’amara condizione esistenziale del poeta che cerca e non trova un senso della vita: «Non viddu nudda differenza / tra chiddu chi fu aieri / e chiddu chi sarà dumani: / suru a motti mmisca e sracancia i catti / subbra a tuàgghia d’a vita» («Non vedo nessuna differenza / tra quel che accadde ieri / e quel che accadrà domani: / solo la morte sconvolge e muta le carte / sulla tovaglia della vita».[49] Unico conforto la poesia, che va custodita come un tesoro: «Si campa d’amuri e di nenti, / di llammìchi e sustintamenti / ma non livàtivi a puisia d’u cori!» («Si vive d’amore e di nulla, / di stenti e sostentamenti / ma non toglietevi la poesia dal cuore!»).[50]

Il bifrontismo tematico e stilistico (tra la dimensione lirica, introspettiva, memoriale e la vocazione sociale), in composizioni magistralmente metaforiche ma viepiù schiarite in direzione della leggibilità assoluta, appare, con nuovi intendimenti, nella terza raccolta poetica in lingua di Josè Russotti,[51] che chiude, all’insegna del sublime, il portentoso biennio 2022-2023.
Delle quattro sezioni di cui il libro si compone, la prima (Pieghe all’ombra della sera) è imperniata sull’io dolente e tuttavia indomito del poeta, consapevole del sua solitudine e del suo disagio esistenziale in un mondo incapace di amare e di capire: «Ramingo e solitario nell’anima, orfano di padre e di madre assente, / stretto nell’angolo buio, spegnevo le mie paure / cantando tristi canzone d’amore / […] Un batuffolo indifeso / attorno al lordume dei grandi, / teso a implorare carezze / che nessuno mai seppe donare»;[52] «Con le mani impazienti / sul pomo della notte, / erro per l’infinito / come un bimbo col suo veliero : / cosmonauta vagabondo / nelle costellazioni dell’Io / per scoprire ciò che la vita / non ti permette di scoprire »;[53] «Smarrito nelle pieghe della vita, / vivo la duplice angoscia / sui ponti di rive opposte»;[54] «Io amo il mio vitigno e i figli d’allevare, / il vino nel bicchiere e il grano da mietere. / […] lontanissimo / dalla vanità dei colti / come un rozzo guascone, / prenoto ancora un posto / per nuovi sogni / da raccontare».[55] Donde, l’avvertenza dei limiti personali («Sono / figlio della Poesia e mi nutro di parole, / vivo nella lusinga dei miei errori / e solo nei versi la mia morte desiste dal morire»;[56] «Parea una piccola screziatura / nei riflessi dell’alba policroma, / […] Parea la fine del suo tenero silenzio / […] È la mia fragile ombra, / che mi segue ancora […]»,[57] [il corsivo è mio]), ma anche l’orgoglio dei valori coltivati: «In un urlo feroce di bandonéon argentino / cantai al cielo / lo sdegno per le futili apparenze / e il falso moralismo, / fino a far tremare i polsi / degli astanti».[58] Anche se lo sdegno per la malevolenza dei potenti sconfina talora negli eccessi della paranoia: «Li avevo tutti addosso / l’aculeo piantato sulla lingua, / la stizza del prete dietro la schiena, / gli occhi degli altri fissi su di me»;[59] «Non mi turba il vostro stupore / né l’infamia delle parole».[60] Quanto dire che, in Ponti di rive opposte, Russotti fa un passo avanti: non indulge all’elegia del paradiso perduto dell’infanzia, come in Brezza ai margini, ma oppone più decisamente la sua alterità di «rozzo guascone» alla cultura dominante. E, su questa stessa lunghezza d’onda, la polemica esplicita contro critici e poeti mediocri ma acclamati dai più: «[…] mi ritrovai fra le mani / esempi di poesia macellata / da finti poeti, svigoriti di parole / e vuoti endecasillabi rimati»;[61] «Ma se la vivida poetica degli avi non traspare / nei monitor accesi della sera / l’indicibile oltraggio cova / nella stupidità degli accoliti. / Nei predicatori del nulla / e nella fragorosa autocelebrazione / di chi non conosce la decenza. / Non è il male che insinua le menti /ma l’estremo dilagare dell’insanabile / mediocrità».[62] Dove sono esplicite le isotopie disforiche di «finti poeti», «vuoti endecasillabi», «stupidità degli accoliti» ecc., sull’asse semico della «mediocrità» come vero «male». Né manca, in questa prima sezione, del libro la testimonianza della religiosità (quasi francescana) del poeta, tuttavia immune da ogni forma di clericalismo: «ho imparato a domare l’orgoglio / e ho camminato al fianco degli scartati»;[63] «Ogni Pasqua che arriva non lenisce il mio dolore / è solo un giorno come tanti: / il rito della resurrezione è una parte / che non mi si addice».[64]
Anche da questa sintetica documentazione, si possono cogliere alcuni aspetti precipui dello stile poetico di Josè Russotti, il quale a) predilige un lessico chiaro fino ai limiti dell’oltranza («lordume dei grandi», «futili apparenze», «il falso moralismo», «poesia macellata», «predicatori del nulla», «l’insanabile / mediocrità»), b) adotta talora un’inedita, raffinata associazione di nome e aggettivo («alba policroma», «tenero silenzio», «fragile ombra»[65] e costrutti metaforici («sul pomo della notte»,[66] «provo a scavare con le unghie strappate / tracce del mio passato»;[67] «Lo strazio / è sale che sa di abitudini»[68]) nonché similitudini («danzano i pensieri / come l’erba fra i sassi»),[69] e immagini («Io amo il mio vitigno e i figli d’allevare, / il vino nel bicchiere e il grano da mietere»)[70] molto personali, desunti chiaramente dalla cultura contadina e magistralmente innestati in contesti verbali e stilistici di diversa caratura.
La seconda sezione del libro, Naufragio, contiene poesie intessute intorno all’amore coniugale, non privo di forti accensioni erotiche, corporali. Si alternano, difatti, liriche tenerissime che cantano – o recuperano dai flussi della memoria – momenti di assoluta tenerezza («[…] la tua mano sul viso / mi dà un senso / di raro sollievo»),[71] a cui non difetta mai, però, l’inevitabile legame carnale del vero amore: «Nell’approssimarsi incerto del mattino, / quel poco o molto che rimane / del tuo splendido sorriso / ha il verso di certe nenie infantili. E […] riparto / per nuove galassie inesplorate / annegandomi, da ora alla fine, nell’insenatura del tuo / florido petto».[72] Il poeta esprime, invero, sentimenti antichi, universali, forse imperituri, con un linguaggio forte, inusuale, pregno di fremente, non dissimulata carica erotica: «Linfa e sudore coprono / la tua pelle di sposa fedele, /mentre l’intrepida mano / affonda nella verticale ambìta / della tua calda ferita. Le dita la sfiorano appena / per non fermare / l’estasi sublime / del ritrovato desiderio».[73] Non casualmente, le isotopie erotiche – «sudore», «pelle», «intrepida mano», «calda ferita», «estasi», «desiderio» – convivono armonicamente, nei contesti citati, con quelle della castità coniugale: «raro sollievo», «splendido sorriso», «sposa fedele». E vale, a stento, la pena di sottolineare come tali isotopie siano, di norma, antitetiche, in gran parte della cultura e della poesia moderna, dove permane la scissione antica, forse di origine cattolica (più che cristiana), della donna nelle due ipostasi di angelo (madre, moglie, sorella) e demonio (amante, prostituta). Certo, poetesse come Alda Merini, Patrizia Valduga e la messinese Iolanda Insana hanno ampiamente ricomposto, nelle loro opere, quella orrenda scissione, consegnando al lettore un’immagine unitaria della donna, ricca di luci e ombre, di carnalità e di spiritualità (come in tutti gli esseri viventi). E tuttavia la poesia di Russotti assume, anche in questo ambito, un rilievo non marginale.
La terza sezione, Il Lavacro, ritesse, con accenti di assoluta purezza espressiva, l’amore del poeta per la madre scomparsa: «Solo nell’approssimarsi dei giorni / quel poco o molto / che mi è rimasto di te e di me, oh madre mia, / assumerà il verso / di certe nenie infantili»;[74] «La rivedo ancora, in un sogno di sempre, / quando prima della scuola / mi sistemava i bordi del bavero bianco».[75] Se non manca, invero, in alcuni componimenti di questa e nelle altre sezioni, così come nella precedente silloge, qualche oscurità superflua (di matrice ermetica), bisogna riconoscere che sfiora i vertici del sublime la suddetta lirica III di p. 77, in cui è ridotto al minimo l’armamentario poetico e il dettato, pur conservando il ritmo inconfondibile della poesia, si accosta molto alla prosa: «Le braccia incrociate sul petto / davano il senso compiuto dell’atto finale: / crudele da vedere. Duro da scordare. / Eppure, alla fine, a guardarla sul volto / pare che ci sorridesse ancora» (p.78).[76] Negli ultimi due componimenti del Lavacro, il poeta-figlio rimpiange, con la stessa composta premura la scomparsa del padre: «Piansero i tuoi figli indifesi / […] aspettando ancora e per sempre / il vano ritorno!».[77]
La vocazione sociale del poeta è presente, infine, insieme con qualche, allusiva lirica di congedo («avverto il lento declinare dell’ombra»),[78] nell’ultima sezione del libro, In Memoria. Josè Russotti, sensibile, in ispecie, al dramma dell’emigrazione, rievoca lo scempio del corpicino del piccolo Aylan, «curvo sul muto arenile di Bodrun», dove «al duro infrangersi dell’onda / si estinsero i tuoi sogni»,[79] o leva un inno solidale in ricordo di un eroe siciliano, militante di Democrazia proletaria, noto per le sue denunce contro Cosa Nostra, da cui fu assassinato il 9 maggio 1978: «la mia anima impura /non rinuncerà al tuo canto possente / dell’ultima volta: grido superbo / di agile armonie» (A Peppino Impastato),[80] o leva un canto per Mimmo Asaro, il poeta contadino, pressoché dimenticato, che ha rubato «parole alla terra / e le lasciò andare al vento» (Un canto per Mimmo Asaro, il poeta contadino).[81]
Una strana sezione, interna alla sezione In Memoria, è costituita da una sola lirica, Per Amalia, dedicata alla poetessa Amalia De Luca, amica e sodale di Russotti, peraltro presente nella raccolta con quattro sue liriche che aprono ciascuna delle quattro sezioni della raccolta stessa. Della poetessa palermitana, versata ai ritmi lievi, armoniosi, sincopati di una poesia luminosa, ricca di cieli, venti, mari, fiori, uccelli, con aperture improvvise all’assoluto, Russotti rimemora, con profonda simpatia, «il tocco lieve delle fragili ali», le «ciglia di teneri turioni», le parole «di rara bellezza», il corpo che resiste al «tempo delle stagioni», la «voce scavata dal profondo dell’anima», ma soprattutto la serena cordialità di chi lo chiama «nel cuore del silenzio per dirgli che l’ibiscus / non fiorisce più nel suo terrazzo».[82]
Quanto dire, in conclusione, che il poeta siciliano di Malvagna si autentica, senza meno, come una delle voci più originali e autentiche della poesia contemporanea. E vien fatto di pensare che quella saldatura tra passato e presente, perseguita invano dal poeta Russotti nella vita, si realizzi perfettamente sulla pagina, nei suoi componimenti poetici in dialetto e lingua.
[1] Josè RUSSOTTI, Fogghi mavvagnoti, Edizione libera, Malvagna (ME), 2002.
[2] Ivi, p. 28.
[3] Ivi, p. 33.
[4] Ivi, p. 10.
[5] Ivi, p. 24.
[6] J. RUSSOTTI, Spine d’Euphorbia, Il Convio Editore, Castiglione di Sicilia (CT), 2017.
[7] Ne ha detto, con dovizia di particolari, lo stesso Russotti, in una esaustiva pagina (Come sono diventato un poeta) redatta dopo la presentazione, presso la Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, di Brezza ai margini (ved. infra) nel 2022.
[8]Ivi, p.15.
[9]Iv, p. 45.
[10] J. RUSSOTTI, Arrèri ô scuru. Dietro al buio. Poesie in vernacolo siciliano e lingua italiana, Controluna, Roma 2019.
[11] Ivi, p. 18.
[12] Ivi, p. 24.
[13] Ivi, p. 56.
[14] Ivi, p. 60.
[15] Ivi, p. 68.
[16] Ivi, p. 72.
[17] Ivi, p. 74.
[18] Ivi, p. 80.
[19] J. RUSSOTTI, Brezza ai margini, Edizioni Museo Mirabile, Marsala, 2022.
[20] Ivi, p. 15.
[21] Ivi, p. 16.
[22] Ivi, p. 17.
[23] Ivi, p. 18
[24] Ivi, p. 19
[25] Ivi, p. 20.
[26] Ivi, p. 21.
[27] Ivi, p. 22.
[28] Ivi, p.24.
[29] Ivi, p. 25.
[30] Ivi, p. 29.
[31] Ivi, p.30.
[32] Ivi, p. 31.
[33] Ivi, p. 32.
[34] Ivi, p. 33.
[35] Ivi, p. 38.
[36] Ivi, p. 39.
[37] Ivi, p. 37.
[38] Ivi, p. 35.
[39] Ivi, p. 36.
[40] Ivi, p. 37.
[41] Ivi, p. 41.
[42] Ivi, p.43.
[43] J. RUSSOTTI, Chiantulongu Piantolungo. Poesie nella parlata malvagnese e in lingua italiana, Edizioni Museo Mirabile, Marsala, 2022.
[44] Ivi, pp. 24-25.
[45] Ivi, pp.36-37-
[46] Ivi, pp. 40-41.
[47] Ivi, pp. 52-53.
[48] Ivi, pp. 70-71.
[49] Ivi, pp. 84-85.
[50] Ivi, pp.86-87.
[51] Ponti di rive opposte, Nulla die (di Massimiliano Giordano), Piazza Armerina, 2023.
[52] Ivi, p. 31.
[53] Ivi, p. 48.
[54] Ivi, p. 20.
[55] Ivi, p.37.
[56] Ivi, p. 26.
[57] Ivi, p. 40
[58] Ivi, p. 18.
[59] Ivi, p. 30.
[60] Ivi, p. 37.
[61] Ivi, p. 18.
[62] Ivi, p. 43.
[63] Ivi, p. 26.
[64] Ivi, p. 38.
[65] Ivi, p. 40.
[66] Ivi, p. 48
[67] Ivi, p.39.
[68] Ivi, p. 20
[69] Ivi, p. 19.
[70] Ivi, p. 37.
[71] Ivi, p. 55.
[72] Ivi, p. 57.
[73] Ivi, p. 58.
[74] Ivi, p. 75.
[75] Ivi, p. 77.
[76] Ivi, p. 78.
[77] Ivi, p. 83.
[78] Ivi, p. 95.
[79] Ivi, p. 91.
[80] Ivi, 93.
[81] Ivi, p. 94.
[82] Ivi, pp. 99-100. Della poetessa palermitana è stata pubblicata, nel 2021, dalla Fondazione Thule Cultura di Palermo, la raccolta completa di Poesie 2002-2021, preceduta, invero, da una vasta raccolta di saggi critici sulla produzione poetica della stessa (AA.VV., Il problema dell’essere e il richiamo spirituale nella poesia di Amalia De Luca, a cura di Tommaso Romano e Giovanni Azzaretto, Thule, Palermo 2020), che ne ratifica la levatura europea.
Questi testi vengono pubblicati nella sezione “Rivista Nuova Euterpe” del sito “Blog Letteratura e Cultura” perché selezionati dalla Redazione della Rivista “Nuova Euterpe”, n°02/2024. L’autore ha autorizzato alla pubblicazione senza nulla avere a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro.

 Berlino, 23 marzo, 23.41 di un anno indefinito (i roghi divampano sempre nelle fragili anime umane), un palazzo “rivestito di intonaco rosa” prende fuoco nell’ultimo romanzo di Simona Sparaco Nel silenzio delle nostre parole (DeA Planeta 2019) e le lingue sono anche quelle dei suoi inquilini da troppi anni colpevolmente, tragicamente mute.
Berlino, 23 marzo, 23.41 di un anno indefinito (i roghi divampano sempre nelle fragili anime umane), un palazzo “rivestito di intonaco rosa” prende fuoco nell’ultimo romanzo di Simona Sparaco Nel silenzio delle nostre parole (DeA Planeta 2019) e le lingue sono anche quelle dei suoi inquilini da troppi anni colpevolmente, tragicamente mute.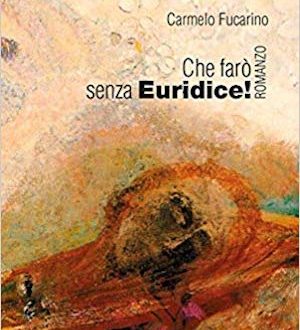 Il mito di Orfeo ha segnato profondamente la cultura occidentale nell’ambito della letteratura, dell’arte e della musica. Ḗ naturale, perciò, che chi come Carmelo Fucarino si è nutrito di letteratura e arte tenda a dare connotazione simbolica ad ogni proprio dato esistenziale, sia luogo sia persona. Nel romanzo il mito antico di Orfeo ha la funzione di dare forma e ordine di rappresentazione alla realtà mutevole e sfuggente della vita, sottraendola ai limiti della logica razionale per avviarla ad una comprensione più alta e complessa. Accanto al testo virgiliano e all’
Il mito di Orfeo ha segnato profondamente la cultura occidentale nell’ambito della letteratura, dell’arte e della musica. Ḗ naturale, perciò, che chi come Carmelo Fucarino si è nutrito di letteratura e arte tenda a dare connotazione simbolica ad ogni proprio dato esistenziale, sia luogo sia persona. Nel romanzo il mito antico di Orfeo ha la funzione di dare forma e ordine di rappresentazione alla realtà mutevole e sfuggente della vita, sottraendola ai limiti della logica razionale per avviarla ad una comprensione più alta e complessa. Accanto al testo virgiliano e all’