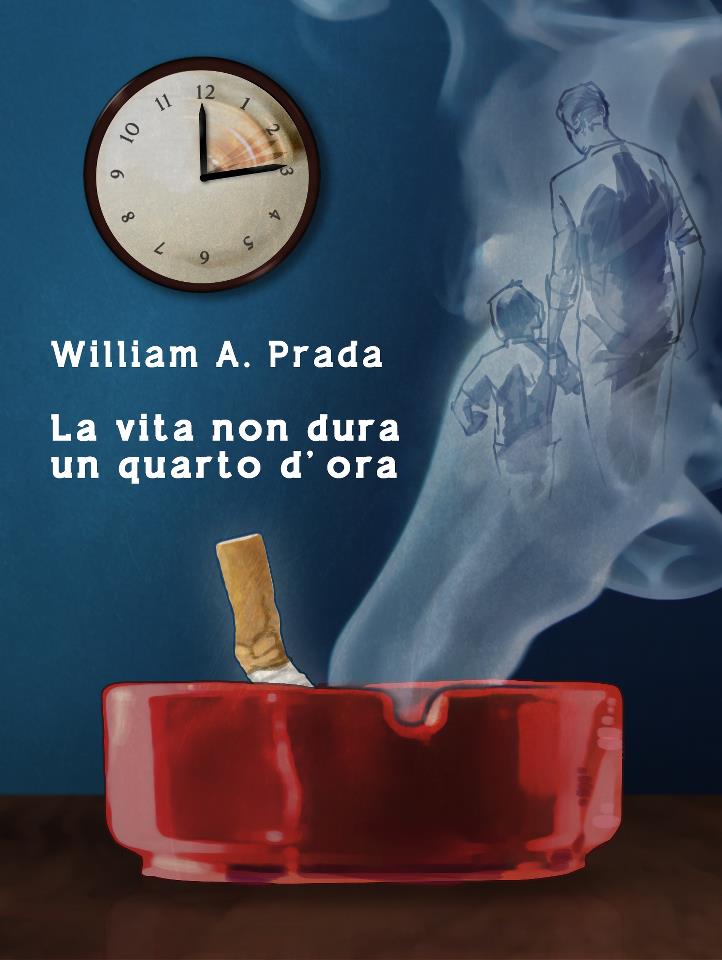 La vita non dura un quarto d’ora
di WILLIAM A. PRADA
Editore: Narcissus.me
La vita non dura un quarto d’ora
di WILLIAM A. PRADA
Editore: Narcissus.meISBN: 9788867558452
Prezzo: € 0,99 (IVA inclusa)
Formato: ePub
Altri formati disponibili:Mobi
Protezione: protetto con Watermark
di Lorenzo Spurio
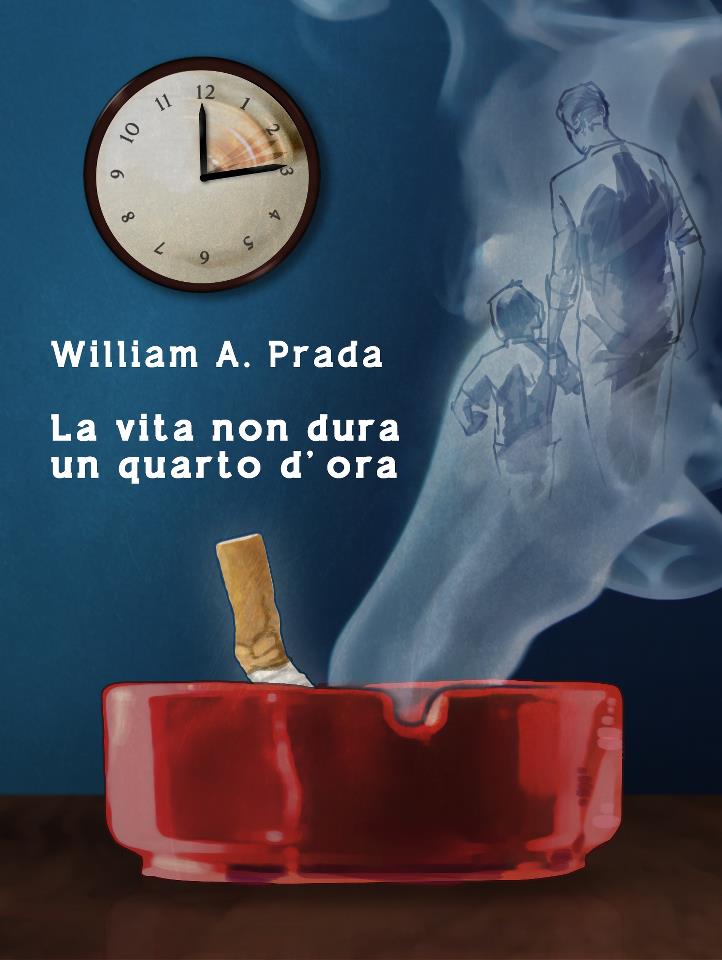 La vita non dura un quarto d’ora
di WILLIAM A. PRADA
Editore: Narcissus.me
La vita non dura un quarto d’ora
di WILLIAM A. PRADA
Editore: Narcissus.me
La caverna di ghiaccio rimane gelata anche quando fuori c’è il sole. (p. 24)
 Questo libro è un acuto proclama sull’indignazione e la presa di coscienza della nullità dell’uomo nel suo presente storico. Il lettore leggerà di ossa, tagli, mutilazioni, sangue e sudore, di anziani con gli occhi rimossi dalle orbite e di acque radioattive. Gianni Carlin in questa sua opera prima mostra un certo pessimismo su molti mali della società patinata dell’oggi: la mancanza di meritocrazia, i falsi sentimenti, la prostituzione, la perdita d’identità dell’uomo e lo fa in una maniera cruda e tagliente che obbliga il lettore ad avere una reazione.
Questo libro è un acuto proclama sull’indignazione e la presa di coscienza della nullità dell’uomo nel suo presente storico. Il lettore leggerà di ossa, tagli, mutilazioni, sangue e sudore, di anziani con gli occhi rimossi dalle orbite e di acque radioattive. Gianni Carlin in questa sua opera prima mostra un certo pessimismo su molti mali della società patinata dell’oggi: la mancanza di meritocrazia, i falsi sentimenti, la prostituzione, la perdita d’identità dell’uomo e lo fa in una maniera cruda e tagliente che obbliga il lettore ad avere una reazione.
La poetica è a tratti ermetica a tratti marcatamente enigmatica e il poeta arricchisce le sue liriche che pongono attenzione sulla materialità e sulla corposità degli elementi a cui allude; man mano che si sfogliano le pagine, ci pervade un senso di oppressione che, anziché desolarci, ci aiuta a prendere coscienza su determinate realtà.
E in questo percorso dove Carlin mescola parodia, black humor e tragico, centrale è la figura del tempo, immortalato in varie liriche come motivo primo d’indagine e di confronto con l’umano esistere. Non è il tempo inteso nel suo lento incedere, nella sua forma canonica, ma un tempo che domina e si fa totalizzante, in grado anche di rallentare quello che, invece, è da sempre stato considerato inesorabile, la Morte. In una lirica il lettore si sorprenderà nel leggere di un anziano che desidera morire (non è chiarito il motivo, ma possiamo intendere che soffra di una grave malattia che non gli lascerà scampo) “ma la Morte si è fermata/ a leggere il giornale e a bere qualcosa./ Che brutta cosa la Vita/ quando vuoi morire” (p. 12). La Morte intesa come il tempo che si annulla qui sembra “godersi la sua esistenza” e vendicarsi dell’uomo che, invece, non aspetta altro che il suo arrivo. E così Carlin materializza la Morte come un comune essere vivente in attitudini quotidiane come quella di leggere un giornale o di bere qualcosa. Curioso e sarcastico al tempo stesso. Anche irriverente, forse. Varie liriche sono sprovviste del titolo e mi pare di capire che questo debba essere interpretato in un qualche modo: o l’autore ha preferito non anticipare nulla al lettore oppure l’attribuzione di un titolo era un’operazione praticamente impossibile e inconcepibile per determinate poesie.
C’è fastidio e sdegno nei confronti di militari saliti sul podio d’eroi della collettività per aver partecipato a una qualche campagna militare e Carlin osserva: “Se volete essere degli eroi non dovete essere vivi” (p. 14); lo stesso sentimento si respira in “Soldato” in cui il poeta non solo identifica nel soldato, nel guerrafondaio, un animo dal “cervello spento” (p. 52), ma gli augura una sorte beffarda: “Soldatino,/ ti auguro ti facciano il culo” (p. 52).
Carlin usa un linguaggio forte e scarnificato facendo riferimento a situazioni di violenza, di disperazione e d’angoscia; in alcuni casi ne fuoriesce anche una chiara critica sociale o di certi strati della popolazione, coloro che “hanno venduto il culo alla vita” (p. 27) o, per usare altri versi “Gente che ha passato la vita/ a rubare senza pudore/ e ora vuole pure la pensione” (p. 42). Lo shock che deriva dalla durezza delle immagini e dall’esuberanza linguistica che spesso lo porta ad utilizzare uno stile “scatologico” (in “Causa ed effetto” il poeta scrive senza remore: “Cazzo, che voglia di farmi fare un pompino.”, p. 32) spiazzano il lettore.
C’è sgomento, irritazione e voglia di dire le cose come stanno.
Non serve abbellire o mitigare la realtà, sembra dirci il poeta.
Questa va raccontata com’è: è brutta, dolorosa e infingarda. L’uomo può continuare a bearsi di una poesia edificante e barocca, ma si illuderà e non vi troverà se stesso.
I tagli, il “cuore marcio”, il “sangue nero” e le stesse cimici del titolo del libro sono tutte metafore di questo nostro mondo falsamente autentico, spersonalizzante, degradato, corrotto e in cui l’uomo non ha più chiaro il suo scopo. La copertina del libro, immette da subito il lettore in un’ambientazione visionaria, subdolamente favolistica, dove al fianco di un cervo visto ai Raggi X c’è un derelitto con un rosario di dimensioni esagerate, una prostituta con tacchi a spillo e in lontananza un musico che suona un flauto.
Ma su ogni immagine, su ogni effervescenza, sembra che il poeta stenda una finissima pellicola trasparente, una membrana opaca che permetta al tutto di conservarsi, di cristallizzarsi per sempre. Ma poi l’io lirico interviene con una lama e squarcia quelle superfici effimere per riportare tutto alla tragica realtà:
Verranno giorni buoni, ma quelli cattivi saranno sempre dietro l’angolo. (p. 29).
(scrittore, critico-recensionista)
E’ SEVERAMENTE VIETATO DIFFONDERE E/O PUBBLICARE LA PRESENTE RECENSIONE SENZA IL PERMESSO DA PARTE DELL’AUTORE.
Il mondo sospeso
Poesia di Giuseppina Vinci
Il mondo sospeso e la nostra vita
Il peso del mondo sorretto dal vuoto
Il Tempo, come un dio
Guarda il mondo e il suo andare
Sospirare e gemere
E Lui, indifferente, non passa, non geme
È eterno.
QUESTA POESIA VIENE QUI PUBBLICATA PER GENTILE CONCESSIONE DELL’AUTRICE.
E’ SEVERAMENTE VIETATO E/O DIFFONDERE LA PRESENTE RECENSIONE SENZA IL PERMESSO DA PARTE DELL’AUTRICE.
Perché non è finita finché ritorna il giorno che limpido c’invita di nuovo a un altro sogno. (in “E sarà di nuovo giorno, p. 25)
 Difficile e forse addirittura coraggioso è il recensire il recente libro della scrittrice, poetessa, nonché valida collaboratrice Marzia Carocci, perché la sua attività letteraria, le sue pubblicazioni e soprattutto il suo impegno concreto nel mondo culturale contemporaneo è, oltre che encomiabile e invidiabile, prerogativa per considerarla una delle potesse più valide e amate del nostro tempo. Non si tratta di un’asserzione iperbolica: chi la conosce anche solo di nome per il suo serio impegno sa che sto dicendo il vero, mentre a chi non la conosce inviterei a leggere qualcosa di lei: poesie, ma anche recensioni, perché va ricordato che Marzia Carocci è un anche un attento critico che si occupa di note di prefazioni, recensioni e quanto altro, il tutto all’insegna della promozione di lavori di qualità che, non essendo supportati da grandi case editrici, rimarrebbero nell’ombra se nessuno si assumesse l’onere di promuoverli adeguatamente: in altre parole, il “poeta incompreso” della sua omonima lirica o i “ragazzi spesso non capiti” di “La gioventù” (p. 46). Negli anni ho avuto modo di leggere varie poesie di Marzia, tra quelle che lei pubblicava in Facebook e quelle apparse in varie antologie poetiche e sono stato enormemente contento della sua collaborazione anche alla rivista di letteratura Euterpe che dirigo.
Difficile e forse addirittura coraggioso è il recensire il recente libro della scrittrice, poetessa, nonché valida collaboratrice Marzia Carocci, perché la sua attività letteraria, le sue pubblicazioni e soprattutto il suo impegno concreto nel mondo culturale contemporaneo è, oltre che encomiabile e invidiabile, prerogativa per considerarla una delle potesse più valide e amate del nostro tempo. Non si tratta di un’asserzione iperbolica: chi la conosce anche solo di nome per il suo serio impegno sa che sto dicendo il vero, mentre a chi non la conosce inviterei a leggere qualcosa di lei: poesie, ma anche recensioni, perché va ricordato che Marzia Carocci è un anche un attento critico che si occupa di note di prefazioni, recensioni e quanto altro, il tutto all’insegna della promozione di lavori di qualità che, non essendo supportati da grandi case editrici, rimarrebbero nell’ombra se nessuno si assumesse l’onere di promuoverli adeguatamente: in altre parole, il “poeta incompreso” della sua omonima lirica o i “ragazzi spesso non capiti” di “La gioventù” (p. 46). Negli anni ho avuto modo di leggere varie poesie di Marzia, tra quelle che lei pubblicava in Facebook e quelle apparse in varie antologie poetiche e sono stato enormemente contento della sua collaborazione anche alla rivista di letteratura Euterpe che dirigo.
Il libro in questione, Némesis, edito nel 2012 dall’Associazione Carta e Penna di Torino ci immette da subito in un’ambientazione di difficile collocazione: l’immagine di copertina, la foto di una bambola scheggiata della quale risalta, però, il rosso delle labbra sensuali sembra trasmettere un senso d’incertezza e al contempo di paura, come se qualcosa –che non ci è dato sapere- è appena successo e che quell’espressione di spavento, quelle cicatrici sul volto siano, dunque, il “risultato” di qualcosa. Il titolo, Némesis, che potrebbe far venir in mente a un recentissimo romanzo del grande americano Philip Roth, sta a significare quei momenti difficili del passato che vedono poi un momento di “rivelazione” che in pratica li fanno risollevare, una sorta di epifania o come viene detto in Wikipedia, come “una compensazione”. Parlare di “nemesi”, dunque, presuppone considerare la realtà liquida nella quale il nostro essere si trova come un immenso vivente dominato da forze imperscrutabili, ingovernabili che, in una certa misura, dettano a nostra insaputa le nostre azioni, in altre parole di fatalismo. Una nemesi, dunque, presuppone un prima e un dopo, un periodo di tristezza, un altro di rappacificazione, un tramonto e un sorgere. Ma l’attenzione non è tanto su questi due elementi, quanto sul processo di cambiamento stesso, sul momento “rivelatore” che consente appunto di passare dal prima al dopo.
La silloge si apre con la lirica intitolata “8 marzo 1908”, già letta e contenuta in Poeti contemporanei e non. Antologia di poesia civile edita da Agemina (2012) nella quale la poetessa affida tutto al ricordo di quella data dolorosa nella storia dell’umanità: il rogo che si diffuse in una fabbrica americana producendo una grande quantità di vittime donne portò l’attenzione sulle cattive condizioni di lavoro e sullo sfruttamento (tanto lavorale che non) della donna nella società. La festa della donna nasce per ricordare il sacrificio di donne con la “D” maiuscola che soffrirono le ingiustizie della storia e la prepotenza degli uomini sulla loro pelle. Della lirica i versi più belli sono quelli che affondano la loro essenza nel vivo cromatismo: “ricorda che quel fiore profumato/ è rosso sotto un giallo camuffato/ del sangue delle donne forti e fiere/ che vollero lottare per cambiare” (p. 7).
 Ci sono liriche dolorose, ma al contempo ricchissime dal punto di vista dei sentimenti e sono principalmente quelle che hanno un qualche legame al tema del tempo come in “A mio padre” dove l’uso continuo di quel condizionale “vorrei” ci dice che la poesia non è altro che un sogno ad occhi aperti, un qualcosa di illusorio, una sorta di tentativo di voler riconquistare quello che in un tempo andato non si è potuto fare o non si è avuto il tempo di fare. Ed è forse proprio il tempo, quel gigante invisibile e sempre presente, a rappresentare la “nemesi”, quello stacco lucido da un prima a volte doloroso o che si ricorda con nostalgia al presente che, invece, è immancabilmente diverso dal prima, addirittura differente da come ce l’avremmo immaginato: “La vita ci conduce dove vuole/ ma niente può nascondere e occultare/ i sogni ed i ricordi sono eterni/ bagaglio di un’essenza da cullare”, scrive la poetessa in “Ad un caro amico ritrovato” (p. 9). Come per dire: siamo noi stessi solo perché abbiamo avuto un passato (privato e collettivo) e perché abbiamo ricevuto e dato emozioni. Una vita senza affetti, infatti, si ridurrebbe a niente: desolazione e senso di nullità. La Carocci sottolinea in queste liriche quanto l’amore, l’amicizia, l’affratellamento e le piccole cose possano alimentare quella ragion d’esserci nel presente e quella forza motrice per andar avanti e non lasciarsi scoraggiare. La morte di un genitore, allora, non è solo vivido manifesto di un dolore che mai più verrà colmato, ma anche un sorriso incantato sul viso della poetessa.
Ci sono liriche dolorose, ma al contempo ricchissime dal punto di vista dei sentimenti e sono principalmente quelle che hanno un qualche legame al tema del tempo come in “A mio padre” dove l’uso continuo di quel condizionale “vorrei” ci dice che la poesia non è altro che un sogno ad occhi aperti, un qualcosa di illusorio, una sorta di tentativo di voler riconquistare quello che in un tempo andato non si è potuto fare o non si è avuto il tempo di fare. Ed è forse proprio il tempo, quel gigante invisibile e sempre presente, a rappresentare la “nemesi”, quello stacco lucido da un prima a volte doloroso o che si ricorda con nostalgia al presente che, invece, è immancabilmente diverso dal prima, addirittura differente da come ce l’avremmo immaginato: “La vita ci conduce dove vuole/ ma niente può nascondere e occultare/ i sogni ed i ricordi sono eterni/ bagaglio di un’essenza da cullare”, scrive la poetessa in “Ad un caro amico ritrovato” (p. 9). Come per dire: siamo noi stessi solo perché abbiamo avuto un passato (privato e collettivo) e perché abbiamo ricevuto e dato emozioni. Una vita senza affetti, infatti, si ridurrebbe a niente: desolazione e senso di nullità. La Carocci sottolinea in queste liriche quanto l’amore, l’amicizia, l’affratellamento e le piccole cose possano alimentare quella ragion d’esserci nel presente e quella forza motrice per andar avanti e non lasciarsi scoraggiare. La morte di un genitore, allora, non è solo vivido manifesto di un dolore che mai più verrà colmato, ma anche un sorriso incantato sul viso della poetessa.
In “Amore immortale” scopriamo la poetessa-madre in una lirica d’amore verso i suoi figli nella quale, come spesso accade nelle liriche della Carocci, fa capolino il tempo, quasi fosse un ospite non gradito, un nemico indissolubile. La riflessione sul tempo è chiara ed espressa in termini facilmente comprensibili a tutti: “Sfugge poi il tempo e scorrono gli anni” scrive, per concludere in un chiaro encomio all’amore che salva e che unisce anche oltre la morte: “Non sarà il tempo, trascorso e andato/ che arresterà questo mio amore” (p. 11).
Il tempo ritorna in tutte le possibili manifestazioni in questa silloge d’inestimabile valore: le rughe (p.12, 45,46) segno fisico della giovane età ormai sfiorita, il ritardo (una dilazione, improvvisa, nel tempo che solitamente provoca scoraggiamento e che nella lirica “Agape” dedicata al marito, invece, è diventato ormai segno di “ritualità”), la stanchezza fisica che il “peso del tempo” (p. 13) arreca, il “come allora” dell’omonima poesia; i “bimbi già vecchi” in “Dolore” (p.23) , cresciuti troppo velocemente e privi di una dolce infanzia a causa della violenza della guerra e i “giorni usurati” (p.42). Stupenda la poesia “Assorta” in cui la poetessa osserva la madre a distanza cercando di capirne i pensieri, i ricordi più o meno felici del suo passato, e tituba se avvicinarsi o no quasi da sentirsi invadente o inopportuna, ma poi è la forza di un gesto, quel “prendere la mano” che apre il cuore della poetessa e lo avvicina a quello della madre.
Ma una delle cose più curiose di questa silloge è che, anche se la poetessa parla sempre di questo duello perenne con il tempo o del tempo che divora il presente per condurre l’uomo alla vecchiaia e alla fine dei suoi giorni, lei non parla mai di morte. Non usa questa parola troppo dura, fredda, che annulla le speranze e preferisce descriverla con versi più elaborati che ci trasmettono un’immagine di eleganza e ci fanno pensare alla morte come una danza che corteggia l’uomo: “[il] traguardo d’un tempo/ codardo e impietoso/ che in fondo ci attende crudele” (in “Anche io avrò il tuo tempo”, p. 13). In “Come allora” la morte è semplicemente “la via de non ritorno” (p.19).
In “Carnevale” la poetessa affonda in un momento di colori e travestimenti, qual è appunto quello della festa di Carnevale e durante la quale “[fingerà] per non farsi scoprire” (p. 17). C’è da una parte un’insaziabile sentimento fanciullesco e ludico che torna a galla, quasi con la volontà di sfidare se stesso e gli altri, dall’altra, però, c’è la volontà della poetessa di osservare, travisata, gli altri e il mondo, senza esser vista né riconosciuta. Il bisogno di cambiare prospettiva, di indossare gli abiti di un altro e di sentirsi un po’ questa persona e soprattutto la necessità di celarsi al mondo, è forse rivelatrice di come la poetessa consideri importante il tema dell’identità passata. Mascherandoci e ritornando bambini possiamo illuderci di rivivere quei momenti andati per sempre e di rinverdire ricordi ormai appassiti: “Di domani non voglio parlare,/ la mia maschera ride perenne,/ cosa importa se dietro io vivo,/ altri mondi, altri sogni per me” (p. 17).
Il tempo che divora e che consuma non viene mai insultato, offeso o vezzeggiato dalla Carocci, ma è esso stesso oggetto di riflessione dei suoi pensieri; parlare di esso significa cercare di conoscerlo, respirarlo e farselo amico. La Carocci dialoga con esso, quasi volesse delle risposte che puntualmente non giungono. Non si scoraggia e lo richiama, lo interpella, lo chiama in causa. E’ lui che comanda tutto e l’uomo deve prenderne atto.
Non si sfugge dal tempo, non si annulla, non possiamo dilatarlo: “Ma niente contro lo scandir/ degli anni io posso”, scrive in “Madre” (p. 54).
Possiamo viverlo, però, mitigarlo, sfidarlo o, come ci dice la Carocci, “trasformarlo”:
Non sono più bambina, né giovane ragazza ma il tempo che è passato, lo voglio trasformare. (in “E sarà di nuovo giorno”, p. 24)
La sensibilità di una poetessa come la Carocci è così variegata ed eccelsa proprio perché parte da un’attenta esegesi sul tempo e sul ruolo che esso svolge nelle nostre vite e, soprattutto, nelle nostre riflessioni. Così il ricordo della nonna e i giochi dell’infanzia sembrano a prima vista essere perduti e sostituiti da quei “nostalgici giorni” (p. 33) del presente, un tempo in cui la malinconia, la tristezza e la continua lotta con la dimenticanza, scrivono le ore, ma il passato non è perduto perché rivive nei sogni dove la poetessa ritrova quei tempi e riscopre momenti passati, re-incontra i suoi cari e quasi dialoga con essi. Così la mamma, il genitore premuroso che ha dato amore e cresciuto il figlio, una volta anziano diventa come un infante a cui il figlio da’ amore, premure e attenzioni cantandogli una dolce ninna nanna (“Ninna nanna”, p. 61).
Lorenzo Spurio (scrittore, critico-recensionista)
Jesi, 19-02-2013
E’ SEVERAMENTE VIETATO DIFFONDERE E/O PUBBLICARE LA PRESENTE RECENSIONE SENZA IL PERMESSO DA PARTE DELL’AUTORE.
Grande fascino desta il primo verso ‘’d’in su la vetta della torre antica’’ la vetta, le altezze, si allungano verso il cielo, come guglie di una cattedrale che si elevano verso l’infinito, altri spazi, altri mondi; colui che sta su una vetta non può non essere che diverso dagli altri, colui che ha desiderato raggiungere la vetta aspira a una vita differente perché è differente, aspira all’infinito, a una esistenza ‘’elevata’’.
 Il passero dalla vetta della torre può ammirare un paesaggio bello ricco di luce perché la primavera ha illuminato la campagna e intenerito i cuori, il nostro Poeta ammira la natura e la sua bellezza, non può non ammirarla perché essa ‘’intenerisce il cuore’’. La Torre simboleggia la durezza del carattere, l’impenetrabilità del dolore, la corazza di una personalità triste, melanconica, sente di essere forte perché se ne sta in disparte; solitario ha scelto la solitudine e crede di poter vivere da solo. Non può ammirare e gioire delle bellezze della natura come tutti gli altri passeri, come tutti gli altri giovani. Scegliere la solitudine è la Scelta della sua vita, della sua breve vita. Perché rinunciare alla gioia? Breve ma pur sempre viva e presente.
Il passero dalla vetta della torre può ammirare un paesaggio bello ricco di luce perché la primavera ha illuminato la campagna e intenerito i cuori, il nostro Poeta ammira la natura e la sua bellezza, non può non ammirarla perché essa ‘’intenerisce il cuore’’. La Torre simboleggia la durezza del carattere, l’impenetrabilità del dolore, la corazza di una personalità triste, melanconica, sente di essere forte perché se ne sta in disparte; solitario ha scelto la solitudine e crede di poter vivere da solo. Non può ammirare e gioire delle bellezze della natura come tutti gli altri passeri, come tutti gli altri giovani. Scegliere la solitudine è la Scelta della sua vita, della sua breve vita. Perché rinunciare alla gioia? Breve ma pur sempre viva e presente.
La brevità della gioia dovrebbe impedire di abbandonarsi alla solitudine. Egli si è abbandonato alla Solitudine.Pur breve, la gioia va vissuta anche se seguita dall’inevitabile dolore. Antica, par ricordare l’ ‘’antico’’ marinaio del poeta inglese Coleridge. Antico, remoto, non vecchio, quasi intoccabile,antico come il Dolore che è sempre stato e sempre sarà, ricorda Keats ( the pain that has been and may be again) nella sua celeberrima urna greca. Condizione comune a tutti gli esseri umani, non puoi evitarlo. Dolore silenzioso, orgoglioso, remoto come ho scritto in una mia breve composizione. Il passero canta la propria solitudine e alla fine del giorno accetta la fine. Il Poeta sente di rimpiangere i momenti non vissuti, momenti che avrebbero potuto riscaldare il cuore. Anche Jonathan Livingstone sceglie la solitudine, ma vola, sui mari, sui monti, si stacca dal gruppo, dalla esistenza fatta di obbedienza alle regole stabilite dal capo. Il gabbiano Jonathan gioisce, spazia, soprattutto perché lontano dal gruppo che non ama volare come lui. Volare è la vita per Jonathan, ma il passero, il Poeta non vola, si stacca dal gruppo non per volare, spaziare, librarsi, gioire ma per rimanere immobile nella solitudine e dunque nella sofferenza.
Il gruppo punisce Jonathan per non essersi adattato, per aver trasgredito, ma lui non cambia, rimarrà lo stesso, amerà volare e continuerà a volare, ossia a vivere.
Il gabbiano di Baudelaire, schernito e annientato, è il Poeta condannato per essere diverso, per essere incompreso, per essere genio. Tutti ciò che appare diverso deve essere annientato. La norma è l’istituzione, e dunque, se fuori dalla norma, deve essere emarginato.
 Il poeta, incompreso perché geniale deve essere mortificato e dunque morire. Qui il Nostro, forse schernito dalla comunità recanatese, deliberatamente sceglie di non condividere la sua vita con altri giovani e giovinette del paese. Avrà molto sofferto. La sua adolescenza sarà stata simile a quella di tanti altri giovani, non amati soprattutto nell’ambiente familiare; niente che possa intenerire il suo cuore; durante quegli studi matti e disperati, si affanna a trovare una causa al dolore causa che difficilmente troverà. Un Thomas Hardy che non accetta la necessità del dolore. Una Natura, le stelle che brillano, fredde e luccicanti rappresentano una Volontà indifferente alla sorte delle umane genti.
Il poeta, incompreso perché geniale deve essere mortificato e dunque morire. Qui il Nostro, forse schernito dalla comunità recanatese, deliberatamente sceglie di non condividere la sua vita con altri giovani e giovinette del paese. Avrà molto sofferto. La sua adolescenza sarà stata simile a quella di tanti altri giovani, non amati soprattutto nell’ambiente familiare; niente che possa intenerire il suo cuore; durante quegli studi matti e disperati, si affanna a trovare una causa al dolore causa che difficilmente troverà. Un Thomas Hardy che non accetta la necessità del dolore. Una Natura, le stelle che brillano, fredde e luccicanti rappresentano una Volontà indifferente alla sorte delle umane genti.
Una Volontà immanente, non soltanto indifferente ma che scherza con gli esseri umani deboli e fragili ‘’destinati’’ alla sofferenza. Non un Dio, ma ‘forze oscure’’ come Hardy le definiva, oscure perché ne sconosci l’origine, si accaniscono per far sì che l’uomo soffra e gioiscono della sua infelicità. Raggiungono la meta, il fine. Tess perirà a Stonehenge, condannata per aver assassinato Alec, ma Tess non è altro che simbolo dell’umanità, vittima di forze oscure. Simbolo della umanità senza speranza, condannata alla morte, alla Fine. Anche Hardy si chiederà il motivo di tanto dolore. Non saprà mai darsi una risposta. Se non quella di credere alla grande solitudine dell’uomo e alla sua inevitabile sorte di dolore e abbandono. Il nostro Poeta, come il passero perirà, si rammaricherà della vita, della propria vita trascorsa nel rifiuto, Nessuno mai l’ha consolato, ‘all’apparir del VERO tu misera cadesti’’ dell’altra nota poesia ‘’A Silvia’’, le illusioni che avrebbero potuto confortarlo sono illusioni; la speranza nelle illusioni è anch’essa perita.
Solo il Nulla non perirà.
Giuseppina Vinci
Docente di Lingua e civiltà inglese al Liceo classico Gorgia di Lentini.
Un passaggio verso le emozioni (2010-2012)
di Giorgia Catalano Prefazione a cura di Emanuele Marcuccio Photocity Edizioni, Pozzuoli (Na), 2012 ISBN: 978-88-6682-321-6 Pagine: 63 Costo: 8,14 € Link diretto all’acquisto Recensione di Lorenzo Spurio
A piccoli passi, andiam verso la vita verso noi stessi, verso lo specchio della nostra anima (in “Anima”, p. 7)
 Con Un passaggio verso le emozioni Giorgia Catalano esordisce nel mondo della poesia, sebbene abbia già pubblicato varie liriche in antologie. Come sottolinea in maniera acuta il poeta e aforista palermitano, nonché curatore della silloge, Emanuele Marcuccio, la sua poesia è ricca di musicalità grazie alla presenza di forme retoriche e di stratagemmi metrico-poetici che rimandano a una poetica di tipo classico.
Con Un passaggio verso le emozioni Giorgia Catalano esordisce nel mondo della poesia, sebbene abbia già pubblicato varie liriche in antologie. Come sottolinea in maniera acuta il poeta e aforista palermitano, nonché curatore della silloge, Emanuele Marcuccio, la sua poesia è ricca di musicalità grazie alla presenza di forme retoriche e di stratagemmi metrico-poetici che rimandano a una poetica di tipo classico.
Le liriche condividono un senso di nostalgia e tristezza per un passato ormai andato: nella lirica che apre la raccolta, “Fioco lamento” c’è desolazione, silenzio e un senso d’abbandono che, però, porta la poetessa a prendere una decisione importante: “Rubo un sorriso/ ad un cucciolo d’uomo,/ spezzo l’affanno del tempo/ che fu” (3). E nella lirica che segue, “Ripenso”, i pensieri dolorosi assumono materialità e vengono equiparati a dei panni: per rinverdire quei momenti passati e per privarli dell’angoscia ai quali erano legati sarà necessaria una purificazione: “Così, odorosi di bucato/ li indosserò come abito nuovo” (4). Bastano due semplici liriche per comprendere quali sono le tematiche profonde che caratterizzano un poeta e queste due, scelte non a caso, ne sono la prova: la Catalano affronta i temi del tempo e del suo indissolubile scorrere, del passato e del ricordo, del dolore e dell’assenza e del bisogno che l’uomo ha nella sua contemporaneità di “fare i conti” con quello che è stato. Siamo quelli che siamo stati ed è impossibile annullare il passato, è vero, ma la Catalano ci insegna che forse il presente fluido dell’oggi può insegnarci a ricomprendere il passato, a rivederlo, a riviverlo, sempre che siamo disposti a farlo, prendendo le distanze da quel dolore vivo che invece caratterizzò quei momenti.
Nella poesia “Tremo”, quella che a mio modesto parere tocca l’apice dell’espressività lirica e al contempo è in grado di trasmettere la violenza delle immagini, Giorgia Catalano ci “narra” dell’angoscia che può nascere in una persona che viene ferita psicologicamente e fisicamente, un dolore vergognoso che genera disperazione e incomprensione: “Tremo/ vicino alle tue mani/ percosse e deturpate” (8).
Ovviamente la poetessa ci regala liriche anche più lucide ed ottimistiche, come “Per te, piccola” ispirata alla nascita della piccola Martina e che, in qualche modo, celebra il mistero della vita che puntualmente si rinnova. Ci sono liriche colorate e profumate come “Porta Palazzo” dove la poetessa riflette su culture ed etnie diverse guardando una donna in burka “dallo sguardo cupo” (10) per poi riflettere anche sulla presenza cinese nel nostro paese: “Gente che va e che viene,/ che s’adopera in acquisti” (10) e anche la poesia “Tasselli”, una sorta di manifesto della sua poetica, dove le canoniche attività del libero pensatore (leggere, pensare, sperare, poetare) vengono considerate tasselli, ossia parti che solo uniti tra loro danno forma e unità a un qualcosa che, lentamente, “si fa/ immagine” (19). In “A te, poesia”, la poetessa annuncia il suo amore per questo genere letterario che è consolazione, guarigione e custode di mali tanto da portarla ad utilizzare un linguaggio iperbolico: “Vivo per te” (28) che ben mette in luce quanto il rapporto della Catalano con la poesia sia vivido e autentico.
Mi piace concludere questo mio breve commento con la speranza che trasuda dalla lirica intitolata “Anime spoglie” dove la morte di un ragazzo viene accolta dal Cielo con un lampo che “squarcia/ l’unica bianca nube seppellita da cumuli/ anneriti dalla disperazione” (12) descritto come un fiore che di colpo appassisce, all’improvviso per tramontare per sempre. Dov’è allora la speranza in una lirica luttuosa come questa? La speranza è il dolore stesso che, ormai come un fardello che la madre del protagonista porterà fino alla fine dei suoi giorni, “abita/ nel suo cuore” (13) come un tremendo compagno e un dolce nemico che, tuttavia, le farà compagnia. Così come avviene in “A chi non c’è più” dove l’idea di un aldilà è in grado di mitigare quel dolore e quell’assenza: “Ci sarà sempre/ un tuo sguardo/ amorevole e attento,/ posato su di me” (15).
Jesi, 01-02-2013
 Giorgia Catalano è nata a Ventimiglia (IM) nel 1971. Nel 1989 ha conseguito la maturità magistrale. Inizia a scrivere poesie in età adolescenziale. A partire dal 2010 varie sue liriche sono apparse in diverse antologie poetiche e riviste letterarie online. L’autrice ha un suo blog che prende il nome dal titolo di questa sua prima raccolta poetica dove pubblica poesie, foto, pensieri e altro.
Giorgia Catalano è nata a Ventimiglia (IM) nel 1971. Nel 1989 ha conseguito la maturità magistrale. Inizia a scrivere poesie in età adolescenziale. A partire dal 2010 varie sue liriche sono apparse in diverse antologie poetiche e riviste letterarie online. L’autrice ha un suo blog che prende il nome dal titolo di questa sua prima raccolta poetica dove pubblica poesie, foto, pensieri e altro.
E’ SEVERAMENTE VIETATO DIFFONDERE E/O PUBBLICARE LA PRESENTE RECENSIONE IN FORMATO INTEGRALE O DI STRALCI SENZA IL PERMESSO DA PARTE DELL’AUTORE.
TEMPO
A CURA DI RITA BARBIERI
Attendere. Come al telefono quando la linea è occupata.
Come in fila dal medico, in attesa del proprio turno per la visita.
Come al bancone del bar, mentre aspetti che il barista ti elargisca la tua prima dose di caffeina quotidiana, necessaria per affrontare la giornata.
Aspettare un tempo che sembra scorrere all’indietro: oasi perduta di miraggi e ricordi che, invece di essere dimenticati, riscopri presenti e attuali come una notizia appena uscita sul giornale.
 Attendere segnali, decisioni, mosse e contrattacchi. Come nelle partite, nelle guerre, nelle sfide. In amore.
Attendere segnali, decisioni, mosse e contrattacchi. Come nelle partite, nelle guerre, nelle sfide. In amore.
Sentirsi in balia dell’altro, di un destino che a volte è amico e molte altre è invece crudele avversario.
Alti e bassi, mareggiate e risacche. Distanze che si allungano e si accorciano come ombre, a seconda dei punti di vista. Si dilatano sotto l’effetto ottico di luci mutevoli e intermittenti.
Il tempo è denaro e, come tale, si guadagna, si investe, si spende, si spreca. E talvolta si perde. Come per i soldi, recuperarlo è difficile: finisce subito e lascia debiti e creditori che non saranno mai risarciti.
Ogni cosa a suo tempo. Un’affermazione che riempie di fiducia, di speranze, di illusioni… Aspettiamo che i tempi cambino, maturino come frutti su un albero. Che si adattino a noi, alle nostre volontà, ai nostri desideri.
Quasi mai succede.
E noi siamo ancora lì a aspettare che, invece di raccoglierli, i frutti cadano da soli.
Non ci sono tempi giusti o tempi sbagliati. Ci sono solo situazioni, realtà provvisorie e passeggere: il tempo scorre. Una clessidra che qualcuno ha già rovesciato per noi: ogni granellino che scivola via è un pezzo di vita che smette di essere un enigmatico mistero.
Il tempo, per fortuna, lascia segni e tracce. Cauterizza benevolo anche le peggiori ferite e riabilita dai danni più gravi. Regala un po’ di buonsenso a chi può permetterselo e agli altri lascia la sensazione di aver assistito a una lezione di cui non si è capito bene il senso. Forse qualcuno lo rispiegherà prima o poi.
Il tempo è un ben strano maestro di cui fidarsi. Non bisogna fargli troppe domande, né mettergli fretta: lui ha il suo programma da seguire e a noi, allievi inesperti, non resta che provare a seguirlo ciecamente tentando, nel mentre, di imparare il più possibile…
Rita Barbieri
QUESTO TESTO VIENE QUI PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DELL’AUTRICE. E’ SEVERAMENTE VIETATO DIFFONDERE E/O PUBBLICARE IL PRESENTE TESTO IN FORMATO INTEGRALE O DI STRALCI SENZA IL PERMESSO DA PARTE DELL’AUTRICE.
 “Persecuzione” di Alessandro Piperno è il primo volume di un’opera complessiva, che con evidente riferimento alla Recherche di Proust l’autore ha intitolato “Il fuoco amico dei ricordi”. D’altra parte ciò non può né deve stupire, dal momento che Piperno è uno straordinario studioso del grande scrittore francese con cui condivide l’origine ebraica. La funzione della memoria è, proprio in tale prospettiva, di grande importanza e offre lo spunto a numerose riflessioni e considerazioni.
“Persecuzione” di Alessandro Piperno è il primo volume di un’opera complessiva, che con evidente riferimento alla Recherche di Proust l’autore ha intitolato “Il fuoco amico dei ricordi”. D’altra parte ciò non può né deve stupire, dal momento che Piperno è uno straordinario studioso del grande scrittore francese con cui condivide l’origine ebraica. La funzione della memoria è, proprio in tale prospettiva, di grande importanza e offre lo spunto a numerose riflessioni e considerazioni.
La citazione dal De consolatione di Boezio “Sei rimasto in silenzio per la vergogna o per lo stupore?” posta prima dell’inizio del romanzo, pone subito il lettore di fronte a un enigma che lo accompagnerà fino alla fine del racconto.
Il celebre professore primario di oncologia pediatrica, Leo Pontecorvo, amato e stimato nell’ambiente di lavoro come tra le mura domestiche, si trova improvvisamente costretto a difendersi da un’accusa infamante avanzata contro di lui da una tredicenne, fidanzatina del figlio.
La personalità di Leo è delineata, all’inizio, a mio avviso, con intenzionale ambiguità, per lasciare nel lettore un certo dubbio sulla sua effettiva integrità morale.
Certamente Leo è l’opposto di Rachel, sua moglie, che è pura razionalità.
Anche lei di origine ebraica, ma di estrazione sociale assai più modesta, spesso rinfaccia al marito la sua appartenenza a quella ricca borghesia che s’era potuta permettere di risiedere in Svizzera negli agi, durante le persecuzioni naziste e fasciste. Leo e Rachel sembrano rappresentare i due opposti stereotipi dell’ebreo, uno remissivo e rassegnato di fronte ai soprusi, l’altra più aggressiva e determinata nel raggiungere e conservare i privilegi conquistati faticosamente.
Ed è in questa prospettiva che il personaggio di Rachel si delinea in tutta la sua ferocia e la sua negatività: senza esitare e senza neanche chiedersi se le accuse contro il marito abbiano un sia pur minimo fondamento, lo allontana dalla sua vita e dall’affetto dei figli, costringendolo a un isolamento fisico e spirituale, chiuso nel seminterrato della loro villa, da cui lui avrà della vita dei suoi cari solo una visione parziale e dal basso, sbirciando dalle finestre a livello terra.
Certo la descrizione del carattere di Leo suscita più di una volta il dubbio che la sua generosità sia piuttosto dabbenaggine, che la sua superficialità sia solo apparente e nasconda invece una forma di repressa consapevole perversione; tuttavia, l’evoluzione del personaggio che va perdendo ogni connotazione umana, fino a identificarsi con l’orrido scarafaggio di creazione kafkiana, induce ad amare considerazioni su quello che è tutto il mondo che lo circonda, dall’avvocato Herrera, al piccolo paziente salvato, Luchino, che ormai adulto ipocrita si è trasformato in un incubo ricorrente, all’assistente che lo accusa di strozzinaggio, dopo aver ricevuto da lui soldi in prestito senza interesse.
Ciò che sembra essere più devastante nella mente di Leo, però, è lo svanito rapporto con i figli, di cui ripercorre la vita dalla nascita, rivivendo con angoscia i momenti difficili e problematici.
E dunque la fine di Leo è segnata: è una fine squallida, come può esserla quella d’un insetto o d’un topo di fogna, anche se poco prima di morire si rivede sul grande letto matrimoniale dove trovano posto tutte le persone da lui amate, dalla madre, a Rachel, ai figli, in un tentativo immaginario di abbraccio consolatorio.
E dunque l’interrogativo iniziale si ripropone alla fine, rimanendo senza sicura risposta : “Sei rimasto in silenzio per la vergogna o per lo stupore?” .
ANNA MARIA BALZANO
QUESTA RECENSIONE VIENE PUBBLICATA SU QUESTO SPAZIO PER GENTILE CONCESSIONE DELL’AUTRICE.
E’ SEVERAMENTE VIETATA LA DIFFUSIONE E/O LA RIPRODUZIONE DI QUESTO TESTO SENZA IL PERMESSO DA PARTE DELL’AUTRICE.
Gita al faro di Virginia Woolf
recensione di Anna Maria Balzano
 Con Gita al faro di Virginia Woolf, il romanzo del Novecento si arricchisce di nuovi elementi, rispetto a quelli già introdotti da altri romanzieri appartenenti alla stessa epoca. Tralasciando il caso di Joyce, che con il suo Ulisse merita un discorso a sé, molto complesso e articolato, pensiamo a Proust, a Svevo, a Mann: siamo su un piano del tutto diverso rispetto al romanzo storico o a quello d’avventura dell’ottocento. L’influenza delle teorie freudiane ha ispirato i più grandi personaggi novecenteschi, portati all’introspezione psicologica, all’analisi dei sentimenti e dei rapporti interpersonali.
Con Gita al faro di Virginia Woolf, il romanzo del Novecento si arricchisce di nuovi elementi, rispetto a quelli già introdotti da altri romanzieri appartenenti alla stessa epoca. Tralasciando il caso di Joyce, che con il suo Ulisse merita un discorso a sé, molto complesso e articolato, pensiamo a Proust, a Svevo, a Mann: siamo su un piano del tutto diverso rispetto al romanzo storico o a quello d’avventura dell’ottocento. L’influenza delle teorie freudiane ha ispirato i più grandi personaggi novecenteschi, portati all’introspezione psicologica, all’analisi dei sentimenti e dei rapporti interpersonali.
Insieme con Mrs Dalloway, Gita al faro (To the Lighthouse, 1927) è l’opera più significativa di Virginia Woolf.
Il romanzo si divide in tre parti: La finestra, Il tempo, Il faro. Ogni parte è strettamente organica all’altra.
La prima si estende per oltre la metà del romanzo e prende spunto dall’abitudine della protagonista Mrs Ramsay, di osservare, seduta davanti alla finestra con un lavoro a maglia, ciò che accade all’esterno della vetusta casa di campagna, e di scrutare con occhio apprensivo le condizioni meteorologiche, con la speranza di poter esaudire il desiderio del più piccolo dei suoi otto figli, Giacomo, di andare al Faro.
La finestra, però, non è solo il luogo da cui Mrs Ramsay osserva l’esterno: essa è anche, metaforicamente, la finestra sulla sua anima, il mezzo che le permetterà di aprire uno spiraglio alla conoscenza di se stessa.
Sin dalle prime silenziose osservazioni della protagonista, il lettore si accorge di essere di fronte ad un personaggio femminile di tipo nuovo e assai più complesso. Mrs Ramsay si afferma subito come una donna raziocinante, sicura delle sue decisioni e delle sue scelte, sicura delle sue qualità, timorosa solo di essere in qualche modo superiore all’uomo che ha sposato, che, pur essendo un rinomato professore di filosofia, appare ai suoi occhi e attraverso i suoi occhi, come una deludente nullità. Qui il dramma d’una donna in bilico tra gli schemi tradizionali che all’epoca relegavano il sesso femminile al ruolo tranquillo di moglie e di madre tra le rassicuranti mura domestiche e l’esigenza nuova e impellente di rivendicare a sé una capacità raziocinante tendente a riconoscerle legittima autonomia.
Se si confronta il personaggio di Mrs Ramsay con quello di Mrs Bennet, creato da Jane Austen in Orgoglio e pregiudizio (1813) , si capisce immediatamente quanta strada si fosse fatta e come ci si stesse allontanando già ai primi del Novecento dallo stereotipo della donna subalterna all’uomo e alla famiglia.
Già Isabel Archer, il personaggio di Ritratto di signora di Henry James, aveva in qualche modo, anticipato questa sorta di “rivoluzione copernicana” nel ruolo della donna nella società. Non a caso, poco più di un ventennio dopo l’uscita di “Gita al faro”, Simone de Beauvoir scriverà un saggio bellissimo sul Deuxième Sexe , il secondo sesso, secondo proprio in ordine di dignità esistenziale. La de Beauvoir affermerà che l’opinione corrente ritiene la donna un’ “ovaia, una matrice”.
 Il dramma più sentito da Mrs Ramsay è dunque proprio il suo rapporto con il marito, al quale si sente consapevolmente superiore e per il quale non sente, forse proprio per questo motivo, più alcuna attrazione; eppure ella desidererebbe in certo qual modo riportare ordine nelle cose e nei sentimenti, cercando una fusione tra la sfera intima e i valori tradizionali.
Il dramma più sentito da Mrs Ramsay è dunque proprio il suo rapporto con il marito, al quale si sente consapevolmente superiore e per il quale non sente, forse proprio per questo motivo, più alcuna attrazione; eppure ella desidererebbe in certo qual modo riportare ordine nelle cose e nei sentimenti, cercando una fusione tra la sfera intima e i valori tradizionali.
In questa prima parte, dunque, la gita al faro diventa quasi un pretesto per portare avanti una storia con pochi eventi. Il gioco delle metafore, delle analogie e del simbolismo della Woolf è sottile e raffinato e non crea mai insofferenza nel lettore. Si prenda ad esempio l’analisi che la stessa signora fa dei raggi del faro: ella paragona se stessa al solo raggio che dei tre è fisso e dà sempre luce.
La seconda parte del romanzo è molto breve ed è dedicata al tempo: il tempo, come succedersi di eventi negativi, che includono la morte improvvisa, solo accennata, della signora e di due dei suoi figli. Morte dentro e degrado fuori della casa, abbandonata.
La terza parte intitolata “Il faro” vede il ritorno alla casa di quelli che rimanevano della famiglia e di parte dei loro ospiti, come in un tentativo di riportare le cose indietro, senza speranza di riuscirci. In questa parte il vero grande protagonista é l’Assenza/Presenza della signora Ramsay. Ella è ancora il punto di riferimento, per il figli Camelia e Giacomo che sembrano aver ereditato dalla madre gli stessi sentimenti che ella nutriva per il loro padre, per Mr Ramsay, che cerca ancora di affermare narcisisticamente il suo io e per Lily, l’amica pittrice che finalmente riuscirà a finire in un modo qualsiasi il quadro che era nella sua mente e che era rimasto incompiuto. Ciò grazie alla visione, una vera e propria epifania sulla verità intima della Signora Ramsay e del suo rapporto con gli altri.
L’amarezza più grande rimane quella di Giacomo che da bambino aveva tanto desiderato che la madre lo portasse al faro e non aveva potuto veder realizzato questo suo desiderio, a causa del maltempo, e ora che vi è giunto col padre è deluso. Dunque era così il faro, il mitico luogo che aveva sognato di vedere? “Una torre nuda sopra una squallida roccia”. Perché la realtà è sempre inferiore al sogno.
ANNA MARIA BALZANO
QUESTO TESTO VIENE PUBBLICATO SU GENTILE CONCESSIONE DELL’AUTRICE.
“Vita di donne”
di Su Tong
Recensione a cura di Rita Barbieri
Quando esordisce, a metà degli anni ’80, Su Tong è inserito nella corrente letteraria dell’avanguardia, che sostiene l’autonomia della letteratura dalla realtà e dà la massima importanza alla libertà creativa dello scrittore e alle infinite possibilità dell’artificio. Non c’è più l’obbligo di rappresentare la realtà secondo i canoni del realismo socialista e, inoltre, gli scrittori avanguardisti sono anche biograficamente e psicologicamente svincolati dal peso della Rivoluzione Culturale.
Nonostante questo, Su Tong ambienta la maggior parte delle sue opere nel passato, definito come il ‘luogo principe dell’immaginario’. Infatti è indubbio che il passato gli conceda maggiore libertà espressiva, non costringendolo al confronto con il reale. Ed è anche indubbio che il passato possa fornire la chiave per la ricostruzione di un’identità culturale comune dopo il trauma della Rivoluzione Culturale e che serva anche a riscrivere la Storia, raddrizzandone i torti.
 […] L’edizione italiana di Vite di donnecomprende due racconti: Vite di donne(Funü Shenghuo) e Altre Vite di donne(Lingyi Zhong Funü Shenghuo).
[…] L’edizione italiana di Vite di donnecomprende due racconti: Vite di donne(Funü Shenghuo) e Altre Vite di donne(Lingyi Zhong Funü Shenghuo).
Per leggere l’intera recensione vai a questo link:
http://blog.chinaitaly.info/consigli/vite-di-donne-di-su-tong/
Recensione a cura di RITA BARBIERI
Così sono gli uomini
E così sono i sogni
Se non son veri
Sono solo fantasmi.
(“Fantasmi”, p. 45)
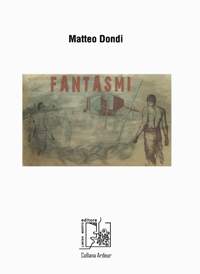 Dopo una prima silloge dal titolo Naos, pubblicata dalla casa editrice romana Il Filo, Matteo Dondi torna con una nuova pubblicazione dal titolo Fantasmi. Il libro che andrete a leggere – libricino, in realtà dato che conta di appena cinquantotto pagine- contrariamente al titolo non ha niente di fantastico, gotico o di ectoplasmatico. Il significato e il senso dell’intera silloge va forse ritrovato in una delle liriche iniziali dal titolo “Déjà vu” dove Matteo Dondi descrive il genere umano attorniato da un velo inconsistente e indistinto, una pellicola di vapore, un’ombra che vive “nei paraggi delle nostre vite”. E’ in questa simbiosi di materia e di alone immateriale che si realizza l’esistenza umana tra il corporeo e l’aereo, tra il materiale e l’aldilà. “Nell’estasi eterna di un dèjà vu/ Nell’odore acre di desideri bruciati/ Ridendo a crepapelle/ Troviamo la nostra fine” (p.25), conclude Dondi.
Dopo una prima silloge dal titolo Naos, pubblicata dalla casa editrice romana Il Filo, Matteo Dondi torna con una nuova pubblicazione dal titolo Fantasmi. Il libro che andrete a leggere – libricino, in realtà dato che conta di appena cinquantotto pagine- contrariamente al titolo non ha niente di fantastico, gotico o di ectoplasmatico. Il significato e il senso dell’intera silloge va forse ritrovato in una delle liriche iniziali dal titolo “Déjà vu” dove Matteo Dondi descrive il genere umano attorniato da un velo inconsistente e indistinto, una pellicola di vapore, un’ombra che vive “nei paraggi delle nostre vite”. E’ in questa simbiosi di materia e di alone immateriale che si realizza l’esistenza umana tra il corporeo e l’aereo, tra il materiale e l’aldilà. “Nell’estasi eterna di un dèjà vu/ Nell’odore acre di desideri bruciati/ Ridendo a crepapelle/ Troviamo la nostra fine” (p.25), conclude Dondi.
Matteo Dondi sintetizza nelle liriche presenti in questa raccolta le sue vedute –principalmente di carattere filosofico e religioso- in una serie di poesie dall’andatura lenta, cadenzata e ritmata. L’intera raccolta si fonda su alcuni temi centrali che poi ritornano in maniere e forme diverse per tutto il libro: il tempo che scorre, il dubbio sull’aldilà, la morte. Non mancano, però, anche riferimenti più concreti al suo vissuto di uomo-scrittore, riscontrabile nei tanti ricordi, episodi di un passato lontano che però restano vividi nella mente del poeta come avviene in “Adolescenza” dove Matteo Dondi imprime: “Beata l’adolescenza/ che tutto accoglie/ e con la piega spavalda/ agli angoli della bocca/ ogni avversità affronta” (p. 46).
Come sottolinea Luca Milasi nella lunga nota introduttiva, la poetica di Matteo Dondi si basa su una pluralità di stili letterari ed è per questo corposa, plurimaterica, difficilmente catalogabile in un genere o in una corrente. Prevalgono i toni mesti e crepuscolari per l’esplicita volontà del poeta di richiamare quell’ “assente sempre presente” che è la Morte e che, dal giorno della nostra nascita, in qualche modo ci avvolge e ci riguarda. E’ forse compito del poeta, acuto esegeta del mondo che gli è toccato di vivere, domandarsi su di essa, forse per esorcizzarla o per tentare di conoscerla meglio e allontanarla da sé. Matteo Dondi utilizza metafore, analogie e costruzioni verbali per far continuo riferimento ad essa: a volte è un’ombra, a volte è l’imbrunire della sera, altre volte un fantasma, altre volte ancora il tutto si semplifica in versi come “In attesa del peggio” (p. 30). Il manifesto della “signora oscura” è forse presente nella lirica intitolata “Gravità= M2” dove quella “m” elevata alla seconda potenza ha una forza doppiamente maggiore. La “m” richiama la malattia, stato patologico dell’uomo che nei casi peggiori o insanabili conduce alla morte, l’altra parola a cui la “m” si riferisce. Ma la cosa più grave, sembra suggerire il poeta, non è la morte in se stessa, ma l’oblio che da essa deriva, la cancellazione dei ricordi, dei momenti, del passato, la dimenticanza, il fare tabula rasa di una persona, della sua esistenza. Nella lirica, infatti, conclude: “Morte, dolore, ancora morte/ Poi oblio” (p. 43).
La silloge, però, rifugge la morbosità e non condivide a pieno una prospettiva completamente pessimista o addirittura allarmista: segnali di positività, di speranza ci sono ed essi sono soprattutto presenti nelle invocazioni a Dio: “Dio fatti presente” (p. 28) o nei ringraziamenti: “Grazie a te o Dio” (p. 48).
Chi è l’autore?
Matteo Dondi è nato nel 1978. Si è laureato ad DAMS di Bologna con una tesi sul compositore Alessandro Peroni di cui ha curato il catalogo delle opere. Musicista e autore, ha pubblicato varie produzioni discografiche, fondato e militato in numerose band; nel 2003, con il videoclip “She’s still rockin’”, da lui scritto, suonato, diretto e interpretato è giunto in finale al “Premio Videoclip Italiano” (MEI, Faenza). Come critico e giornalista collabora con alcune riviste. Nel 2008 ha pubblicato la raccolta di poesia Naos (Il Filo Editore, Roma). E’ presente come autore nella raccolta poetica DemoKratika (Limina Mentis Editore, Villasanta).
scrittore, critico-recensionista
Collaboratore di Limina Mentis Editore
E’ SEVERAMENTE VIETATO DIFFONDERE E/O PUBBLICARE LA PRESENTE RECENSIONE IN FORMATO INTEGRALE O DI STRALCI SENZA IL PERMESSO DA PARTE DELL’AUTORE.
I giorni, le ore
di Paola Surano
Editrice Urso, Avola, 2012
ISBN: 9788896071885
Costo: 9,50
Recensione a cura di Lorenzo Spurio
..e ti ritrovi a contemplare
sprazzi della tua vita
senz’ordine e senza ragioni.
E tuttavia ti emozioni.
(Da “Il Passato”, p. 29)
 La poesia di Paola Surano risulta al lettore estremamente piacevole perché fresca e attuale nei contenuti e perché la poetessa è capace di cogliere dal mondo che la circonda una serie di suggestioni che provengono da differenti campi dell’esperienza: il ricordo del passato che aziona nella mente un fulmineo e immateriale flashback, la celebrazione di paesaggi incontaminati dall’uomo nei quali – pure – si ravvisa una presenza religiosa, le serate di musica jazz e tanto altro. In questo percorso, il tempo è cruciale come indica lo stesso titolo della raccolta “I giorni, le ore”. Il primo componimento dal titolo “I giorni” è uno spaccato di quotidianità: ci sono giorni felici, altri tristi, alcuni in cui siamo in dolce compagnia, altri in cui sprofondiamo in una tetra solitudine ma per quanto possiamo trascorrere momenti “tetri senza sorriso”, si ravvisa sempre un fondo di luce buona, “ e nonostante, viviamo” (p. 7). Si capisce dalla prima lirica che la poetessa ha una grande coscienza del valore della vita che, appunto, con questa ricca silloge, celebra in maniera lodevole.
La poesia di Paola Surano risulta al lettore estremamente piacevole perché fresca e attuale nei contenuti e perché la poetessa è capace di cogliere dal mondo che la circonda una serie di suggestioni che provengono da differenti campi dell’esperienza: il ricordo del passato che aziona nella mente un fulmineo e immateriale flashback, la celebrazione di paesaggi incontaminati dall’uomo nei quali – pure – si ravvisa una presenza religiosa, le serate di musica jazz e tanto altro. In questo percorso, il tempo è cruciale come indica lo stesso titolo della raccolta “I giorni, le ore”. Il primo componimento dal titolo “I giorni” è uno spaccato di quotidianità: ci sono giorni felici, altri tristi, alcuni in cui siamo in dolce compagnia, altri in cui sprofondiamo in una tetra solitudine ma per quanto possiamo trascorrere momenti “tetri senza sorriso”, si ravvisa sempre un fondo di luce buona, “ e nonostante, viviamo” (p. 7). Si capisce dalla prima lirica che la poetessa ha una grande coscienza del valore della vita che, appunto, con questa ricca silloge, celebra in maniera lodevole.
Si potrebbe azzardare col dire che la poesia di Paola Surano sia di tendenza crepuscolare, vedendo in questa accezione non tanto descrizioni di quadretti mesti di situazioni di dolore o di vittimismo o di quella che Gozzano definì “le buone cose di pessimo gusto”, ma nella semplicità delle immagini che la poetessa narra: un bambino che si stupisce del volo di una farfalla, un viandante instancabile che non dà valore al suo tempo mortale, un uomo al mare che, solo, getta sassi verso l’acqua, quasi con un moto di ribellione nei confronti del suo stato. La solitudine, in effetti, ritorna più volte nel corso dell’intera silloge, quasi a voler ricordare come l’uomo, pur essendo spesso attorniato di gente, può sentirsi psicologicamente solo, in balia dei suoi soli ricordi: “Io so come è vuota la mente/ come è fredda l’anima/ quando è sola” (p. 10). La più chiara espressione di sensibilità crepuscolare della Surano, un miscuglio di realismo amaro attraversato da spiragli di luce e speranza, si ritrova forse in “Come un giardino in inverno” dove in mezzo a tanto freddo, foschia, buio e desolazione, la poetessa scorge “solo qualche sempreverde” (p. 13).
“Serata jazz” si discosta, invece, da questa impostazione quasi che per la sua carica sonora, energica e dirompente possiamo avvicinarla a una poesia futurista: “[le note] che si innalzano/ si rincorrono, si fondono/ s’assottigliano/ s’assomigliano” (p. 16). I versi scandiscono un incedere impetuoso e cadenzato che ci fa immaginare molto bene la situazione alla quale Paola Surano si è ispirata.
In “Ti ho aspettato” si respira il senso di angoscia misto a un fremito d’impazienza della poetessa nei confronti di un qualcuno, l’attesa logorante è però mitigata dalla vista delle stelle in cielo che sembrano quasi traghettare l’animo della donna verso il finale molto positivo. Le stelle per Paola Surano non sono una semplice rappresentazione della grandezza del nostro Creatore ma molto di più: rappresentano quella parte di mondo che è altra da noi, lontana anni luce, difficilmente identificabile ma che ci dà luce, ci fa interrogare e la cui presenza è per la poetessa necessaria (non a caso il titolo di una sua precedente silloge era proprio “Alla luce di un’unica stella”, Ibiskos Editrice, 2000, da me recensito qui).
La poetessa ci fa fare un viaggio nel tempo: un percorso tra i momenti passati rievocati attraverso dei flashback (in particolare nella poesia “Il Passato”, p. 29) che, forse, portano con sé un po’ di nostalgia e rammarico, nel presente liquido che sfugge, difficile da definire e da afferrare come vorremmo, nel futuro imperscrutabile in cui in ogni secondo il presente si trasforma (“non sapevi che il futuro non si aspetta/ non sapevi che il futuro va vissuto: poi è subito passato”, p. 26): ci sono analessi, prolessi, accelerazioni e rallentamenti come se ci trovassimo in un romanzo picaresco. In “Dopo di te” Paola Surano osserva “e il tempo passa/ troppo lentamente” (p. 25). E’ sempre così quando dobbiamo riscrivere la nostra realtà dovendo far a meno di qualcosa o qualcuno che è venuto a mancare per sempre.
E in effetti le poesie di Paola Surano sono un continuo miscuglio di tempi ormai andati, di altri a venire e di quello che ci è toccato di vivere al presente, quasi che la caratterizzazione di passato-presente-futuro stia troppo stretta alla poetessa che, invece, ama fare continue e preziose incursioni nel tempo andato o pensieri di speranza nel tempo a venire. Il presente così non è altro – come aveva già sostenuto S. Agostino partendo da altre considerazioni – il tempo unico dal quale tutto diparte: passato e futuro sono proiezioni della mente, il primo non possiamo riprendercelo, il secondo non possiamo conoscerlo se non fantasticando.
Non manca nella silloge una chiara attenzione della poetessa nei confronti del sociale, ravvisabile ad esempio in “Distratta-mente” dove a un mondo televisivo patinato fatto di sponsor e di belle immagini ritoccate che pubblicizzano prodotti (chiaro riferimento al consumismo esasperato) si stagliano, invece, immagini di derelitti, poveri, scene da vera tragedia greca “fiumi di sangue, aerei impazziti/ i carri armati/ -e gli uomini bomba!” (p. 17). Forte il tema sociale anche in “Solo un elenco” (p. 42) nella quale Paola Surano ricorda il clima rivoltoso, sessantottino, la propaganda femminista ma anche il clima di terrore degli anni ’70 “terrorismo, BR, gambizzati/ morti ammazzati, rapimenti/ avvertimenti” (p. 42). Segno di una Italia ormai distante e che, forse, in troppi hanno finito per dimenticare.
La silloge si arricchisce di quadretti paesaggistici multicolori dei quali ci sono dati anche le sensazioni che provengono dall’udito e dall’odorato: “Di luce di albe rosate/ e tramonti infuocati/ scrivo/ di colori e profumi/ che abbiamo conosciuto” (p. 23).
Paola Surano ci accompagna in un mondo che a una prima vista potrebbe sembrare triste e monocromatico ma che evidenzia, invece, il potere della speranza, la grandezza del sentimento e l’importanza di credere in noi stessi. Sono poesie che generalmente partono da uno sguardo attento ma critico nei confronti di una realtà abbandonata, in stasi (un giardino in inverno) o, diversamente da un evento in moto (una tempesta) per giungere però alla comprensione che il mondo è fatto di luci ed ombre, di gioie e dolori, donandoci così una stupenda esegesi delle nostre esistenze terrene. Il messaggio che ne fuoriesce è estremamente positivo: siamo padroni di noi stessi e siamo noi a contribuire al nostro destino: “Il mondo aspetta di essere inciso/ dall’orma dei tuoi passi” (p. 40) è il promettente invito che la poetessa fa a un bambino appena nato ma che, credo, si rivolga a ciascuno di noi, qualsiasi sia la nostra età o la nostra cultura.
Chi è l’autrice?
Paola Surano è nata a Busto Arsizio, dove ha svolto per trentacinque anni la professione di avvocato; in pensione dal 1 luglio 2011, continua a svolgere l’attività di giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese. Scrive poesie e racconti dagli anni del liceo classico e ha “avuto il coraggio” di togliere le sue poesie dal cassetto negli anni ’90, sulla spinta del gruppo “Scrittodonna” attivo presso il Liceo Pascal di Busto che pubblicava annualmente un “Agendario” dove venivano inserite poesie a margine dei giorni della settimana. Partecipa a vari concorsi di carattere nazionale, ottenendo lusinghieri riconoscimenti. Ha pubblicato tre raccolte di poesie “Alla luce di un’unica stella” (Ibiskos Editrice, 2000), “La vita in sottofondo” (Pensa Editore, 2011) e “I giorni, le ore” (Editrice Urso, 2012) e un libro di racconti “Nell’anima/nel mondo” (Oceano Editore, 2000).
a cura di Lorenzo Spurio
E’ SEVERAMENTE VIETATO RIPRODURRE E/O DIFFONDERE LA RECENSIONE IN FORMATO DI STRALCI O INTEGRALMENTE SENZA IL PERMESSO DA PARTE DELL’AUTORE.