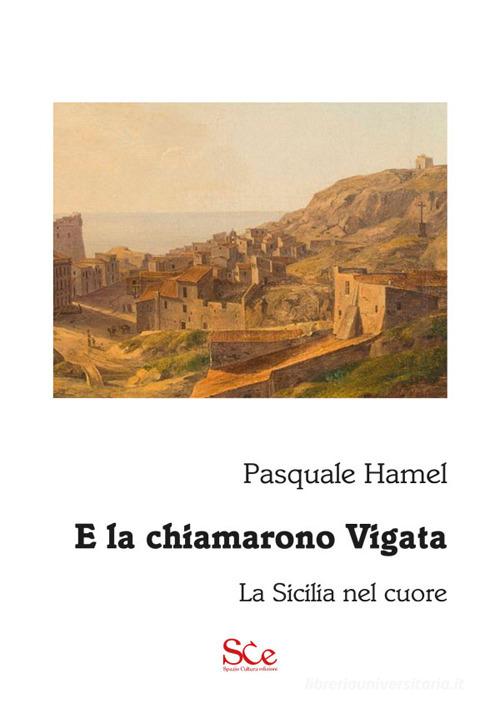In te mi riconforto».[1] Appunti sulla spiritualità tassiana

Nel corso dei secoli, attorno alla concezione religiosa tassiana e, più nello specifico, al rapporto del poeta con la dimensione del sacro, sono sorti e poi sedimentati dei pregiudizi che ne hanno inficiato una corretta e obiettiva valutazione. Ciò in virtù del fatto che le analisi sulla persona hanno prevalso su quelle inerenti allo studio dell’opera ad iniziare dal suo primo biografo, quel Giovan Battista Manso che scriverà di un poeta che «ebbe, per ispezial dono di Dio, dal vero splendore della santa fede per sì maraviglioso modo illuminata la mente, che né per debolezza di giudizio nell’età puerile, né per l’acutezza d’ingegno nel calor della gioventù, gli cadde giammai nel pensiero dubitazion veruna intorno a’ misteri della nostra cristiana religione».[2] La fase “agiografica” non cambiò molto neppure coi successivi studi, ovvero con la biografia di Pier Antonio Serassi e gli studi di Cesare Guasti, curatore dell’imponente epistolario.[3] Con il De Sanctis si passa direttamente all’altro versante, ossia ritenere la religiosità tassiana solo come aspetto formale, un giudizio negativo che è persistito nel tempo: «che cos’è dunque la religione nella Gerusalemme? È una religione alla italiana, dommatica, storica e formale: ci è la lettera, non ci è lo spirito. I suoi cristiani credono, si confessano, pregano, fanno processioni; questa è la vernice; quale è il fondo? È un modello cavalleresco, fantastico, romanzesco e voluttuoso, che sente la messa e si fa la croce. La religione è l’accessorio di questa vita: non ne è lo spirito».[4] Per avere delle valutazioni più “scientifiche” bisognerà attendere Eugenio Donandoni, che elabora sicuramente il giudizio più severo intorno alla portata della sfera spirituale tassiana allorquando scrive che il poeta «anche negli anni più fecondi della poesia religiosa, […] non arrivò mai ad un senso profondo e vivo della religiosità», concludendo che “la sua volontà rimane attaccata alla terra sempre. […] Dio non gli parla nella solitudine: […] nella solitudine egli pensa al mondo, che è rimasto alle sue spalle. [..] La religiosità delle rime sacre è quella esteriore o pomposa» e conclude, in modo lapidario, che «adorò, ma non sentì Cristo».[5] Seguirono le analisi di Francesco Flora che definisce il Tasso «poeta religioso in un senso tutto umano», di Giovanni Getto secondo cui la religiosità del poeta è «una consapevolezza dolente, di natura etica più che propriamente religiosa, ripiegata sulle sue stanche inquietudini, sui suoi timori di peccato e di morte, sulle forme vane che passano e dileguano»[6] e infine di Bortolo Tommaso Sozzi che, partendo dalla Gerusalemme Liberata, individua un elemento religioso «in senso diverso da quello tradizionale; religioso cioè non entro l’àmbito del cattolicesimo (benché l’ispirazione cattolica occupi quantitativamente molta parte del poema), bensì in una dimensione più larga e indefinita, come sentimento tragico della forza ostile, oscura e fatale che governa la vita, la storia e le cose».[7] Si aprono, allora, due percorsi, ovvero se il poeta sorrentino sia stato un fervido e sincero credente oppure in lui, al contrario, abbia albergato una fede superficiale: entrambi chiaramente non sono percorribili perché fortemente condizionati da ideologie contrapposte. Ulteriormente non percorribile è un altro itinerario (in realtà ve ne sono anche altri), ovvero quello di uno scrittore che ha un suo sentimento religioso della vita che non coincide, però, con quello celebrato dal culto ufficiale.[8] Occorre, per tracciare delle direzioni da seguire e tentare una lettura dell’esperienza spirituale tassiana, affidarsi agli ultimi decenni di studi sull’argomento nonché analizzarne lo sviluppo – perché c’è stato – nello stesso autore partendo dal vastissimo corpus delle lettere. La lettera del 15 aprile 1579, lunghissima, è indirizzata a Scipione Gonzaga e ha la parte più interessante nel punto in cui si apre una digressione costituita da un’apostrofe a Dio: la struttura è quella di una vera e propria emendatio rispetto alla condotta morale giovanile e alle precedenti posizioni filosofiche, ma soprattutto è uno spartiacque nelle vita dell’autore, preoccupato di dimostrare la sua conversione alla fede cristiana. Dai dubbi e dalle incertezze, nati dall’esercizio dell’intelletto, e dall’aver assimilato Dio alle idee di Platone, agli atomi di Democrito, alla mente di Anassagora, all’amicizia di Empedocle e alla materia prima di Aristotele, tramite la teologia negativa (ricavata dallo Pseudo-Dionigi) e un ragionamento sillogizzante aristotelico ricompone il conflitto e concilia le asserzioni contrastanti («io ti conosceva solo come una certa cagione de l’universo […]. Ma dubitava poi oltra modo, se tu avessi creato il mondo»), come si può seguire nei due passi riportati della lettera:[9]
«Dunque non mi scuso io, Signore, ma mi accuso, che tutto dentro e di fuori lordo e infetto dei vizi de la carne e de la caligine del mondo, andava pensando di te non altramente di quel che solessi talvolta pensare a l’idee di Platone e a gli atomi di Democrito, a la mente di Anassagora, a la lite e a l’amicizia di Empedocle, a la materia prima d’Aristotele, a la forma de la corporalità o a l’unità de l’intelletto sognata da Averroe, o ad altre sì fatte cose de’ filosofi; le quali, il più de le volte, sono più tosto fattura de la loro imaginazione, che opera de le tue mani, o di quelle de la natura tua ministra. Non è maraviglia, dunque, s’io ti conosceva solo come una certa cagione de l’universo, la quale, amata e desiderata, tira a sé tutte le cose; e ti conosceva come un principio eterno e immobile di tutti i movimenti, e come signore che in universale provvede a la salute del mondo e di tutte le specie che da lui sono contenute. Ma dubitava poi oltra modo, se tu avessi creato il mondo, o se pur ab eterno egli da te dipendesse: dubitava, se tu avessi dotato l’uomo d’anima immortale, e se tu fossi disceso a vestirti d’umanità; e dubitava di molte cose che da questi fonti, quasi fiumi, derivano. Percioché come poteva io fermamente credere ne i sacramenti, o ne l’autorità del tuo pontefice, o ne l’inferno, o nel purgatorio, se de l’incarnazion del tuo Figliuolo e de la immortalità de l’anima era dubbio?
Divenuto io, dunque, omai giusto misuratore de le deboli forze del mio intelletto, così fra me stesso ragionava: Chi mi dimandasse, che fosse la materia prima; che altro saprei rispondere, se non ch’ella non è, né il che, né il quanto, né il quale, né altra cosa è, che si possa o co ‘l dito mostrare o con le parole diffinire? E se pur questa risposta non mi piacesse, ricorrerei forse a qualche somiglianza; e direi, che tale ella è in rispetto de le forme naturali, quale è l’oro e l’argento in rispetto de le artificiali: percioché sì come di questi metalli si posson fare e monile e medaglia e coppa da bere e vasi da oprar ne la tavola o da por ne la credenza per ornamento; così ella è atta a ricevere la forma de la vite, de la palma, del leone, del destriero e de l’uomo o di che altro si sia. Dunque, se de la materia prima, vilissima e ignobilissima cosa, io non ho altra cognizione, né posso darla altrui, se non quella che o negando o paragonando s’appresenta a l’intelletto; ardirò io d’aspirare a l’altissima cognizione d’Iddio nobilissimo e perfettissimo? o presumerò di significare altrui quello che io non intendo? o mi parrà strano o maraviglioso, se io non sono atto a conoscerlo o a parlarne in modo o con paragone, che a la sua maestà sia convenevole? perciochè la luce del sole è oscura, e la grandezza de l’oceano è una brevissima stilla d’acqua, s’a Dio s’assomiglia. Negherò dunque di sapere quel che sia Dio, ma non già di saper ch’egli sia.
E continua ancora: «Negherò dunque di sapere quel che sia Dio, ma non già di saper ch’egli sia; essendo questo sì chiaro, che può esser certissimo principio a provar l’altre cose de le quali si dubita». La presenza di Dio, infatti, è nella stessa armonia mundi. Così procedendo si arriva alla conclusione del dissidio (pur se l’utilizzo del futuro ha qualche venatura dubitativa):
Crederò dunque che sia Dio; e crederò di lui quel di più che per rivelazione se ne sa: ch’egli sia trino e uno; e che il suo Verbo nel ventre verginale di Maria si vestisse d’umanità; e che egli ascendesse in cielo, e che lasciasse Piero vicario in terra: e crederò che la vera e certa determinazione così di questi, come di tutti gli altri articoli de la fede, si debba prender da’ pontefici romani, che sono di Piero legittimi successori.
Queste pagine sono state lette da Claudio Gigante come «il pianto drammatico di chi teme di essere escluso dalla Grazia»,[10] ossia come documento del percorso di ricerca della fede che il poeta compie e dichiarerà successivamente di avere portato a compimento. Ne sono testimonianza altre due lettere: la prima del 1580 e la seconda del 1585. Quella indirizzata al marchese Giacomo Boncompagni è una sorta di confessione, con finalità autoapologetiche, sui dubbi di fede che il Tasso nutriva sia come “filosofo” (circa l’immortalità dell’anima, la creazione del mondo, l’autorità papale) che come cristiano:
Il disfavore […] ch’io aveva ricevuto da la Chiesa, la quale a me s’era môstra non madre ma madrigna […] era cagione non solo ch’io fondassi ogni buona speranza di favore ne la parte imperiale, ne la quale potea fondarlo senza separarmi da la Chiesa in quel c’a la fede appartiene».[11]
È una ricerca, quella tassiana, intesa a superare l’insoddisfazione, il tormento, le incertezze e non certo la rappresentazione di una persona scettica o aliena dalla fede cristiana. E nella lettera al Cataneo del 1585, quando la prigionia stava per concludersi, c’è l’ammissione di una condizione totalmente nuova:
Ma Iddio sa ch’io non fui né mago né luterano giammai; né lessi libri eretici o di negromanzia, né d’altra arte proibita […] né ebbi opinione contra la santa Chiesa cattolica; quantunque io non neghi d’aver alcuna volta prestata troppa credenza a la ragione de’ filosofi; ma in guisa ch’io non umiliassi l’intelletto sempre a’ teologi, e ch’io non fussi più vago d’imparare che di contradire. Ma ora che la mia infelicità ha stabilita la mia fede, e fra tante sciagure ho questa sola consolazione, ch’io non ho dubbio alcuno.[12]
Tasso si avvicinerà a Dio attraverso la sofferenza, le sventure e le vicissitudini; la fede è l’approdo di quello «sforzo teso a superare gli ostacoli che la ragione stessa gli poneva innanzi» e «va considerato come una mèta cercata e desiderata, non come un triste epilogo indotto da pressioni esterne o, peggio, da “follia”»[13]. La testimonianza di queste tre lettere, tutte del periodo di Sant’Anna, ci indicano chiaramente l’avvio di un percorso che il poeta sorrentino, negli anni successivi, perseguirà sempre più: sia le letture (San Tommaso e la patristica occidentale)[14] che le opere (le Rime sacre, Il Mondo creato e il rifacimento della Liberata) andranno ormai di pari passo alle questioni religiose.
[1] Il verso riportato nel titolo è tratto da Torquato Tasso, Rime, Roma, Salerno editrice, 2 tomi, 2, n. 1696 (A Dio), v. 6, p. 1949.
[2] Giovan Battista Manso, Vita di Torquato Tasso, a cura di Bruno Basile, Roma, Salerno editrice, 1995, p. 218. Nella stessa pagina aggiunge che il poeta fu continuamente riverente e devoto «a Santa Chiesa e a’ suoi ministri, che giammai ne favellò motteggiando, o scherzando, come alcuni fanno». Intorno alla religiosità tassiana si veda il fondamentale studio di Giuseppe Santarelli, Studi sulle rime sacre del Tasso, Bergamo, Centro di Studi tassiani, 1974 (soprattutto le pagine 11-49, La religiosità del Tasso).
[3] Nella Vita di Torquato Tasso scritta dall’abate Pierantonio Serassi, Bergamo, Locatelli, 17902, 2 tomi, 2, pp. 276-277, si legge: «Egli sin dalla prima fanciullezza fu molto divoto, ed osservantissimo della cattolica Religione; e sebbene nel bollore della giovanezza si fosse lasciato alquanto trasportare da’ piaceri amorosi; si ravvide tuttavia presto, e diedesi di nuovo ad una vita molto religiosa ed esemplare; il qual tenore osservò poi costantemente insino alla morte». Per ciò che scrive il Guasti si rimanda a Della vita intima di Torquato Tasso, in Torquato Tasso, Le Lettere, disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, 5 voll., V, pp. XXI-XXII.
[4] Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana, a cura di Benedetto Croce, Firenze, Sansoni, 1965, 2 voll., 2, p. 562.
[5] Eugenio Donadoni, Torquato Tasso. Saggio critico, Firenze, Luigi Battistelli, 1920, 2 voll., 2, pp. 203, 204, 205 e 209. Nel vol. 1, a proposito della Liberata, aveva scritto «Tutta forma è nel poema anche la religiosità» (p. 356).
[6] Per le citazioni cfr. Francesco Flora, Storia della letteratura italiana, Milano, Mondadori, 1941, vol. II, p. 548 e Giovanni Getto, Malinconia di Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 19864, p. 303.
[7] Bortolo Tommaso Sozzi, Introduzione, in Opere di Torquato Tasso, Torino, Utet, vol. I, 1974, p. 20.
[8] Sulla spiritualità tassiana si vedano anche: Luigi Russo, La Gerusalemme liberata del Tasso, in «La Rassegna della Letteratura Italiana», 6, 1 (gennaio-marzo 1955), pp. 1-11; Antonio Corsaro, Percorsi dell’incredulità. Religione, amore, natura nel primo Tasso, Roma, Salerno editrice, 2003; Rosa Giulio, Tempo dell’inquisizione, tempo dell’ascesi. Spiritualità religiosa e forme letterarie dal Tasso al Settecento, Salerno, Edisud, 2004; Ottavio A. Ghidini, Poesia e liturgia nella Gerusalemme liberata, in «Studi Tassiani», 56-58 (2008-2010), pp. 153-180; Decio Pierantozzi, La Gerusalemme liberata come poema religioso, in «Studi Tassiani», 32 (1984), pp. 29-42; Angelo Alberto Piatti, “Su nel sereno de’ lucenti giri”. Le «Rime sacre» di Torquato Tasso, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010; Marco Corradini, Ottavio A. Ghidini (a cura di), Senza te son nulla. Studi sulla poesia sacra di Torquato Tasso, Roma – Milano, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016; Corrado Confalonieri, Provare per credere. Tasso, Dante e l’incarnazione nella Gerusalemme liberata, in «Lettere Italiane», vol. 70, n. 2 (2018), pp. 254-284.
[9] La lettera si legge in Torquato Tasso, Le Lettere, ed. cit., II, pp. 7-45, n. 123 e si cita rispettivamente dalle pagine 15 e 19-21.
[10] Cfr. Claudio Gigante, Tasso, Roma, Salerno editrice, 2007, p. 36.
[11] Torquato Tasso, Le Lettere, ed. cit., II, n. 133, p. 84-85.
[12] Torquato tasso, Le Lettere, ed. cit., II, n. 456, pp. 478-479.
[13] Claudio Gigante, Tasso, cit., pp. 36-37.
[14] Nelle lettere (almeno dall’estate del 1586) si registrano richieste dei libri di San Tommaso e Gregorio Magno, di Gregorio di Nazianzo e Filone Ebreo, e soprattutto di un’edizione delle opere di Sant’Agostino (una stampa edita a Ginevra nel 1555). «In quest’ultimo periodo della vita umana e poetica di Tasso, il rapporto con il sacro, la dimensione religiosa acquistano un ruolo predominante, l’incubo dell’Inquisizione non tormenta più i sonni di Torquato, che ha ormai trovato un perfetto equilibrio con le gerarchie ecclesiastiche e con i canoni della poetica aristotelica. Non più una necessità di simulare, un artificioso compromesso con la fede, ma una sua scelta coerente, motivata dall’aspirazione al trascendente, dall’ascesi all’Assoluto, che il poeta esprime nelle forme liturgiche delle sue liriche spirituali, nelle angosciate preghiere delle rime sacre» (Rosa Giulio, Tempo dell’inquisizione, tempo dell’ascesi, cit., p. 88).
Questo testo viene pubblicato nella sezione “Rivista Nuova Euterpe” del sito “Blog Letteratura e Cultura” perché selezionato dalla Redazione della Rivista “Nuova Euterpe”, n°02/2024. L’autore ha autorizzato alla pubblicazione senza nulla avere a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro.