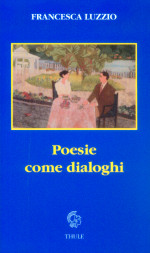Una settimana di sesso o di vacanza?
Un commento su “Una settimana di vacanza” di Christine Angot
A cura di Lorenzo Spurio
 Non conoscevo la scrittrice francese Christine Angot fino a che in una delle tante e-mail promozionali che le librerie on-line inviano, non ho visto la copertina di una sua opera: “Una settimana di vacanza”[1]. Mi colpì inizialmente la copertina nella quale si vede il viso angoloso di una donna –l’immagine fa pensare a una delle tante “demoiselles d’Avignon” del celebre quadro di Picasso dove dipinse le prostitute di un quartiere barcellonese. Della donna ritratta colpiscono gli occhi al centro, rivolti direttamente al lettore, sebbene la donna sia di profilo, il rossetto lucido e una macchia di sangue (sembrerebbe) non uniforme sulla gota della donna. Il titolo, “Una settimana di vacanza” non aiuta a sviscerare il significato della copertina e, come si vedrà, neppure il contenuto del romanzo.
Non conoscevo la scrittrice francese Christine Angot fino a che in una delle tante e-mail promozionali che le librerie on-line inviano, non ho visto la copertina di una sua opera: “Una settimana di vacanza”[1]. Mi colpì inizialmente la copertina nella quale si vede il viso angoloso di una donna –l’immagine fa pensare a una delle tante “demoiselles d’Avignon” del celebre quadro di Picasso dove dipinse le prostitute di un quartiere barcellonese. Della donna ritratta colpiscono gli occhi al centro, rivolti direttamente al lettore, sebbene la donna sia di profilo, il rossetto lucido e una macchia di sangue (sembrerebbe) non uniforme sulla gota della donna. Il titolo, “Una settimana di vacanza” non aiuta a sviscerare il significato della copertina e, come si vedrà, neppure il contenuto del romanzo.
Ci troviamo di fronte a un romanzo piuttosto breve che dal punto di vista tematico ha poco da narrare: si tratta di una settimana di vacanza di un uomo e donna dei quali non ci viene mai detto il nome. Escludiamo dal tipo di rapporto che hanno, e che ora vedremo, che si trattino di marito e moglie e anche di due fidanzatini; l’idea predominante che ci si fa leggendo la storia è che ci sia una qualche stortura nel rapporto tra i due, o per lo meno nel rapporto canonico uomo-donna come siamo soliti pensarlo. Lui è più anziano di lei ed ha un buon lavoro (vari elementi fanno pensare che sia un docente di linguistica presso una qualche università) che gli consente di vivere egregiamente dal punto di vista economico, è sposato e sembra non avere figli. Il rapporto coniugale sembra ormai essersi disfatto –anche se non viene detto- e questo può essere intuito dalle tante storie libertine che ha avuto con varie ragazze.
La narrazione è esterna, il narratore osserva le due persone da fuori come se stesse al di là del vetro e raccontasse tutto quello che vede, ma spesso interviene l’uomo soprattutto mediante una serie di domande, obblighi ed esortazioni alla donna affinché faccia qualcosa.
La donna, che in realtà è una ragazza, è giovane ed è ancora vergine e non ha mai voce nel corso di tutto il romanzo; l’uomo si rapporta continuamente a lei chiedendole favori sessuali, pratiche orali e la completa disponibilità a soddisfarlo. Viene da pensare che la ragazza sia minorenne e che proprio per questo motivo il tizio l’abbia portata con sé in un hotel, lontano da sguardi molesti. Questa idea viene avvalorata anche dal fatto che la ragazza sia “vergine” e in realtà potrebbe essere poco più di una bambina che si sottopone alle richieste dell’uomo senza comprenderle né mostrando forza nell’imporre un rifiuto. Se la ragazza è minorenne, l’uomo sta commettendo consapevolmente un reato; la ragazza non parla mai nel libro o, meglio, parla sempre attraverso la voce dell’uomo che ci dice cosa fa o non fa. In realtà è sempre disponibile a soddisfare l’uomo in ogni suo desiderio sessuale e si noti che l’atteggiamento dell’uomo dal punto di vista erotico è morboso e maniacale con ossessive e preoccupanti richieste (richieste-obblighi) di effettuare su di lui del sesso orale.
I sentimenti sembrano essere scansati via dalla stanza dell’albergo anche se l’uomo spesso –forse per addolcire la sua foga di predatore- dice di amarla e di non essersi mai sentito così coinvolto. Tutta la narrazione è fondata sull’ossessione del blowjob, sulle richieste sempre più spinte e non condivise da un punto di vista mentale dalla controparte, dal libertinaggio sfrenato e dalla mancanza d’amore. Il sesso è espressione di pervertimento e di mania insaziabile che, avvenendo al di fuori delle leggi che sanciscono la normalità (il consenso del partner, la maggiore età del partner), inseriscono la storia all’interno del mondo della devianza che viene subita e che rimane sottaciuta. Il linguaggio è freddo, diretto, clinico, come se si leggesse con attenzione un elenco o un bugiardino medico, senza possibilità di accogliere empatia, calore, condivisione e, soprattutto, di dar voce alla controparte femminile.
La donna, che come abbiamo detto probabilmente è una ragazza nel suo processo di maturazione o, addirittura, (si spera di no) una ragazzina in età pre-puberale, non ha voce sia perché l’uomo non le consente di esprimersi, sia perché ha un’età così giovane che ancora non ha conoscenza del mondo e non sa come rapportarsi a quello che le viene richiesto di fare. Si noti l’incipit del romanzo, degno dell’ampia tradizione underground nella narrativa americana:
E’ seduto sulla tavoletta di legno bianco del water, la porta è rimasta socchiusa, ha un’erezione. Ridendo tra sé e sé, toglie dall’involto di carta una fetta di prosciutto cotto che hanno comprato insieme al minimarket del paese e se la posa sul pene. Lei è in corridoio, appena uscita tal bagno, cammina, sta andando verso la camera per vestirsi, lui la chiama, le dice di spingere la porta.
“Hai fatto colazione stamattina? Non hai fame? Non vuoi un po’ di prosciutto?”
Lei s’inginocchia davanti, si piazza tra le gambe che lui ha aperto per accoglierla e prende con la bocca un pezzo di prosciutto, che mastica e poi inghiotte. (p. 9).
Nella stanza dell’hotel non si pensa altro che a rapporti sessuali prima orali, poi anali e infine vaginali, dopo tanta reticenza dell’uomo perché ossessionato dal fatto di non farle perdere la verginità tanto che al lettore possono dar noia, se non ci fosse qualche breve diversivo, come la lettura del libro “Cani perduti senza collare” di Gilbert Cesbron che spesso viene evocato.
La ripetitività dei rapporti erotici e la mancanza di una pluralità di voci che consenta di trasmettere una visione differenziata su quegli eventi o che metta in luce questioni, idee o interpretazioni sulle quali l’uomo possa controbattere, genera una certa monotonia dal punto di vista tematico ed è lo stesso uomo, colui che potremmo definire il “dolce aguzzino”, ad osservare: “Non possiamo passare tutta la giornata nella toilet” (p. 20) con “nella toilet” l’uomo intende a far sesso orale in uno spazio piccolo e scomodo. Difatti si trasferiranno ben presto nella camera, sul letto e proseguiranno instancabili.
 La possibilità che lei sia una ragazzina è avvalorata anche dal fatto che lei non conosce molte cose, di sesso è completamente ignorante, ed è lui a spiegarle posizioni, come avviene la penetrazione etc; c’è, inoltre, anche un altro elemento, il fatto che l’uomo obblighi la ragazza a chiamarlo “papà” che fa pensare che ci sia una significativa differenza d’età tra i due.
La possibilità che lei sia una ragazzina è avvalorata anche dal fatto che lei non conosce molte cose, di sesso è completamente ignorante, ed è lui a spiegarle posizioni, come avviene la penetrazione etc; c’è, inoltre, anche un altro elemento, il fatto che l’uomo obblighi la ragazza a chiamarlo “papà” che fa pensare che ci sia una significativa differenza d’età tra i due.
Nel romanzo affiora più volte lo spettro della pedofilia, ma è solo una interpretazione, pure lecita, ma che non viene riconosciuta né sconfessata, a differenza di quanto ad esempio avveniva in “Lolita” di Nabokov dove la componente erotico-ossessiva non era slegata da un attaccamento emotivo con la ragazzina.
La ragazza è una persona debole, timida e fortemente titubante, elementi caratteriali che in quelle condizioni compromettono ulteriormente il livello di consapevolezza e di presa di decisioni: “Prima di rispondergli, per non fare errori, lei formula le frasi a mente. Al momento di lanciarsi per pronunciarla, però, s’impappina. Deve ricominciare da capo. […] Lei non sa più cosa voleva dire, si confonde, la frase diventa sempre più incomprensibile” (p. 47). La ragazza è sola, non comprende ciò che l’uomo le propone e l’assoggetta a fare e sembra addirittura aver paura delle sue reazioni per cui finisce per accontentarlo nei suoi desideri ai quali la ragazza si sottopone meccanicamente senza trarne piacere.
Il tema della differenza d’età è reso esplicito poi alcune pagine dopo, circa a metà dell’opera quando il “dolce aguzzino” la rimprovera duramente trattandola come una bambinetta (cosa che in realtà è): “Quanti anni hai? Non sai che il latte inacidisce? Cos’hai nella zucca? Non sai queste cose? Le sanno tutti” (p. 61). Forse la ragazza queste cose non le sa semplicemente perché è ancora una bambina e non ha la stessa esperienza del mondo che ha lui e soprattutto perché simili comportamenti sessuali sono o dovrebbero essere estranei dalle esigenze di un bambino. Poche pagine più avanti lui osserva sdegnato “Mi sembri proprio una bambina” (p. 70); “Piange. […] Le dice di non gridare. […] Le dice che è ridicola. Che con quei grossi singhiozzi sembra proprio una bambina” (p. 92).
La storia erotica della coppia viene inserita all’interno di alcuni episodi della storia ufficiale che non concernono la Francia, il paese d’origine dell’autrice, ma la Spagna. Si parla della morte del dittatore Franco, che sappiamo essere avvenuta nel 1975 e dunque del suo funerale, della fine della dittatura e del traghettamento verso la Spagna democratica. Ancora una volta la ragazza non sa chi sia Franco (forse non sa nemmeno cosa sia la Spagna) e lui, il professorino, risponde seccato e maleducato all’atteggiamento d’incomprensione della ragazza nei confronti di ciò che accade in quei momenti nel mondo (in Spagna, in particolare): “Lei non sa chi sia” (p. 64).
Dopo quest’ampia analisi il lettore non deve però pensare che l’uomo sia un seduttore, né un tombeur de famme che ricerca ossessivamente il piacere carnale con la donna, in quanto come abbiamo detto, è probabile che nella sua “settimana di vacanza” si sia intrattenuto con una ragazzina e dunque sia un pedofilo e, addirittura, è poco convinto della sua sessualità quando veniamo a sapere che nel passato ha tentato anche un rapporto con un uomo: “Le racconta che un giorno è stato sul punto di fare un’esperienza omosessuale. Che alla fine l’esperienza non ha avuto luogo e lui se ne rammarica” (p. 65). Ci troviamo di fronte, dunque, una personalità camaleontica e poliedrica dal punto di vista delle preferenze sessuali, che giunge a diventare pericolosa e dalla quale prendere le distanze. Ovviamente questo viene fatto sulla base di una interpretazione personale che si dà della storia/degli eventi/dei personaggi, poiché la Angot è sempre attenta a non far trapelare di più di quello che potrebbe dire per veicolare al lettore la giusta interpretazione, cioè quella che lei intende inviare. Va ricordato a questo punto che la scrittrice ha spesso impiegato il sesso e la devianza nelle sue narrazioni quali metafora di sistemi di potere e di superiorità portati alle estreme conseguenze (il romanzo “L’incesto” del quale in Italia si è parlato poco e male, figura tra i libri “fuori catalogo” e dunque non ordinabili e questo non sarà un caso). Poiché quando si parla di sessualità e lo si fa in una maniera contorta, che coinvolge ma allo stesso tempo nausea, allora la condanna parte con una semplicità indicibile. “L’incesto” era tanto più fastidioso perché ispirato a dei motivi biografici dell’autrice, in particolare alla relazione incestuosa vissuta in età giovanile con il padre.
Quanto all’utilizzo della storia pubblica non ho compreso completamente perché la Angot inserisca la storia nella seconda metà degli anni ’70 alla vigilia della morte di Francisco Franco. Forse la dittatura, quale espressione di violenza, autorità e azzeramento delle libertà, è specchio allargato del rapporto di violenza e dominazione che contraddistingue l’uomo e la donna e il fatto che la Angot parli di fine della dittatura e quindi di ripristino della democrazia (anche se il processo sarà lento) può forse significare che la ragazza, dopo l’esperienza vissuta nella “settimana di vacanza”, si rifiuterà di accettare un’altra volta gli obblighi dell’uomo, manifestandosi donna totalmente libera di scegliere. Ma questo non accadrà come leggiamo poi nel finale del romanzo.
L’explicit è altrettanto ambiguo perché, non appena la “settimana di vacanza” si conclude, i due si separano e l’uomo che sa che non potrà contare nei giorni successivi sulla sua sex-machine, è infastidito e turbato e mostra un atteggiamento sfuggente, inspiegabile e maleducato nei confronti della ragazza: “Le dice che è irritato, che lei è stata odiosa, che è assolutamente priva di tatto. Che dice cose al limite della maleducazione. […] Per il momento è irritato, in collera, preferisce stare solo anziché con una persona così priva di delicatezza che gli racconta di un sogno ingiurioso; che non può proprio sopportarla, non può vederla. Per un tempo indeterminato” (pp. 103-104). L’uomo è infuriato perché la ragazza ha osato prendere la parola, cosa che lui non ammette, e forse ha utilizzato un linguaggio colorito nel parlare in pubblico, linguaggio che lui stesso le ha insegnato e fatto sperimentare, ma che se viene usato in pubblico, per una persona “seria” e di rispetto come lui che è un professore, è inaccettabile.
L’orco è tale nella sua tana, ma una volta alla luce del giorno si veste di normalità e addirittura di pudicismo.
La ragazza che da bambina, e dunque vergine, esce da quella stanza dell’hotel donna, col caro prezzo scontato dell’abuso, avrà forse la vita rovinata. L’uomo, il “dolce aguzzino”, nella sua prossima vacanza, forse, rovinerà la vita a una nuova lolita e nessuno, ancora una volta, crescerà se non ci sarà un serio aiuto da parte della collettività nel far denunciare l’abuso subito alla ragazza o nel segnalare l’ossessione del sesso dell’uomo a un qualche specialista che possa tentare una forma di trattamento psicologica e sociale.
Però, è anche vero che la letteratura è una trasposizione della realtà, ma è anche un sogno, per cui forse la scrittrice ha fatto bene –anzi, benissimo- a non svelare le vere pieghe della storia perché in questo modo il lettore avrebbe demonizzato semplicisticamente l’uomo come “aguzzino” e la ragazza come “preda”; proprio per questo, per l’incertezza di fondo che aleggia volutamente sulla storia che comunque sa di strano e di perverso, ho nominato l’uomo un “dolce aguzzino”, c’è chiaramente del detto e del non detto.
Come ho avuto modo di osservare in un precedente articolo, la letteratura può essere immagine della realtà, ma non sarà mai la realtà e proprio per questo motivo nel romanzo possiamo benissimo fare a meno di un sistema correttivo della psicologia malata o di sostegno per la ragazza, perché in fondo sono creature letterarie e il compito del romanzo non è certo quello di trasmettere una critica al machismo, ingrediente della cultura patriarcale della Spagna a cui si fa riferimento.
I Nostri sono creature letterarie, sembianze di finzione e come tali l’autore deve percepirle, adottarle e analizzarle, esimendosi di condannare le lubriche azioni dell’uomo e la freddezza della Angot nel narrare una materia complicata e che ancora oggi, a trent’otto anni dal tempo della storia di questo plot, può dar fastidio o addirittura far ribrezzo.
Lorenzo Spurio
Scrittore, critico letterario
Jesi, 31 Luglio 2013
Una settimana di vancanza
Di Christine Angot
Guanda, 2013
Pagine: 105
ISBN: 9788823504127
Costo: 13 €
E’ SEVERAMENTE VIETATO DIFFONDERE E/O PUBBLICARE LA PRESENTE RECENSIONE SENZA IL PERMESSO DA PARTE DELL’AUTORE.
[1] Christine Angot, Una settimana di vacanza, Parma, Guanda, 2013.








 poesie “La grande legge” e “ La pagina bruciata”, entrambe edite da Marco Del Bucchia rispettivamente a maggio e novembre; è risultato secondo classificato nella sezione “Giovani” del concorso Nazionale “Città di San Giorgio a Cremano” con la lirica “Iris” ; E’ membro cofondatore della corrente artistico-letteraria del Labirintismo, il più grande movimento d’avanguardia del 2000 con più di 200 iscritti. Nel 2014 si è classificato al 3°posto nella 5^ edizione del premio letterario internazionale “Le parole dell’anima” Città di Casoria (NA) con il libro di poesie “ La pagina bruciata” ;al 2° posto alla IX edizione del Premio Artistico – Letterario Internazionale Napoli Cultural Classic con l’inedita “ Il crepuscolo”. E’ stato inserito nelle antologie “Poesia per Dio” , curata dalla casa editrice “La Ziza” con la poesia inedita “La scelta” (marzo 2014) e “Fondamenta instabili”, curata da deComporre Edizioni. Alcune sue poesie sono apparse su blog e riviste online come “ L’ombra delle parole” di Giorgio Linguaglossa, “Alla volta di Leucade” di Nazario Pardini, “ La distensione del verso” di Sandra Evangelisti, “ Le Reti di Dedalus” di Marco Palladini e “Poetrydream” di Antonio Spagnuolo.
poesie “La grande legge” e “ La pagina bruciata”, entrambe edite da Marco Del Bucchia rispettivamente a maggio e novembre; è risultato secondo classificato nella sezione “Giovani” del concorso Nazionale “Città di San Giorgio a Cremano” con la lirica “Iris” ; E’ membro cofondatore della corrente artistico-letteraria del Labirintismo, il più grande movimento d’avanguardia del 2000 con più di 200 iscritti. Nel 2014 si è classificato al 3°posto nella 5^ edizione del premio letterario internazionale “Le parole dell’anima” Città di Casoria (NA) con il libro di poesie “ La pagina bruciata” ;al 2° posto alla IX edizione del Premio Artistico – Letterario Internazionale Napoli Cultural Classic con l’inedita “ Il crepuscolo”. E’ stato inserito nelle antologie “Poesia per Dio” , curata dalla casa editrice “La Ziza” con la poesia inedita “La scelta” (marzo 2014) e “Fondamenta instabili”, curata da deComporre Edizioni. Alcune sue poesie sono apparse su blog e riviste online come “ L’ombra delle parole” di Giorgio Linguaglossa, “Alla volta di Leucade” di Nazario Pardini, “ La distensione del verso” di Sandra Evangelisti, “ Le Reti di Dedalus” di Marco Palladini e “Poetrydream” di Antonio Spagnuolo.