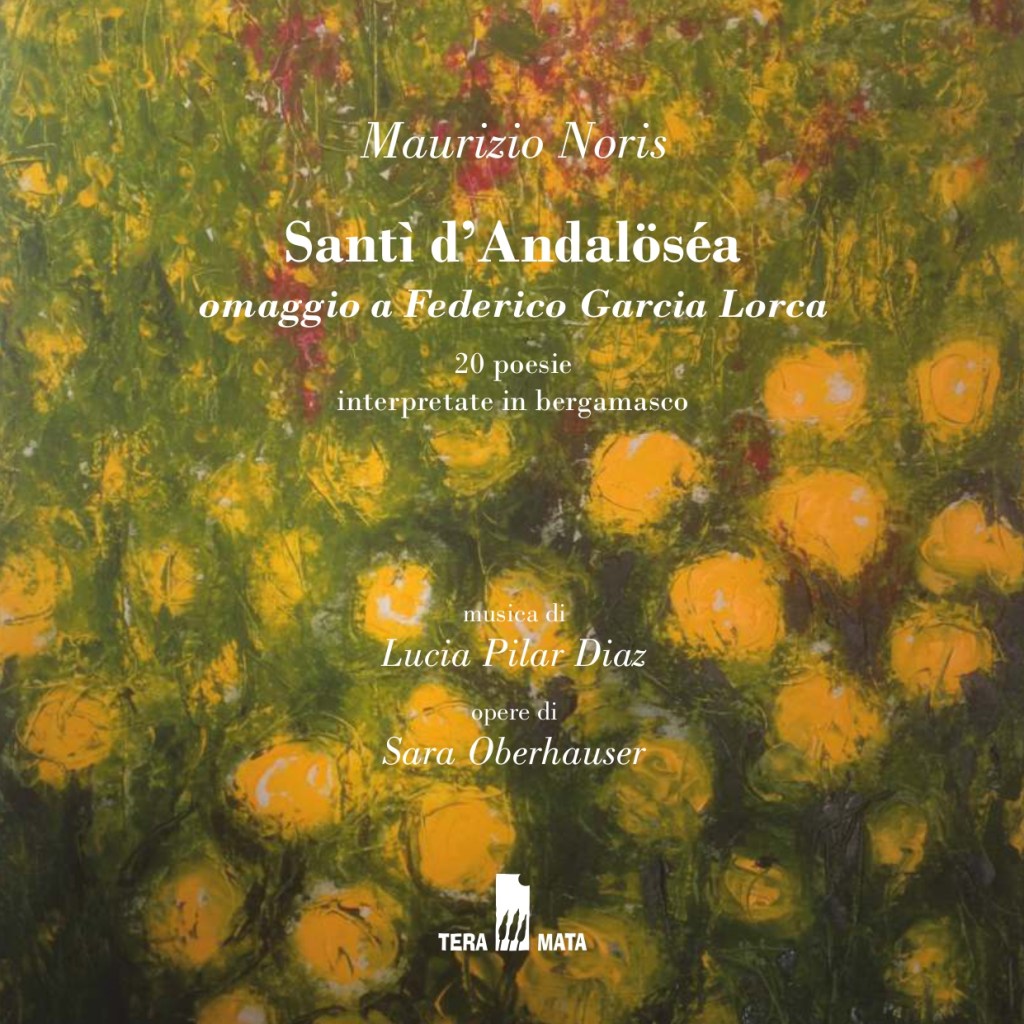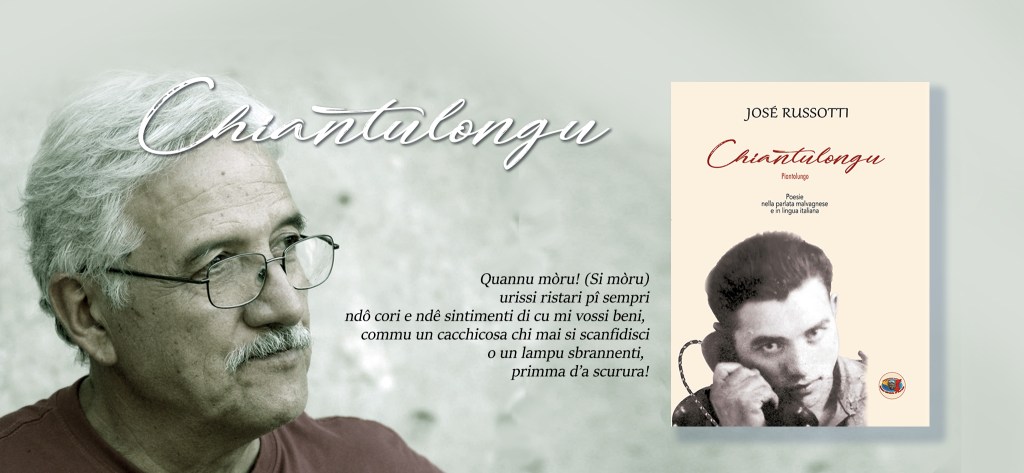A Federico García Lorca (1898-1936), come uomo e come artista, è toccato di diventare un mito del nostro tempo, per cui a tutti i problemi posti dalla sua opera letteraria (colta, oscura e innovatrice nello stesso tempo) si aggiunge quello di capire perché una poesia, come la sua, abbia infranto tutte le barriere della impopolarità della poesia moderna, provocando entusiasmi, creando mode e facendo proseliti. Teatro, incisioni discografiche, televisione, balletto: tutto è servito a creare e a sostenere il fenomeno “Lorca”.
Forse, al fondo di questa straordinaria fortuna, c’è il sentimento del tragico, la disarmata dichiarazione di dolore di cui la sua poesia è portatrice, la sua perenne e inesausta inquietudine esistenziale. A ciò si aggiunga un insieme di circostanze, tra le quali la morte del poeta, avvenuta nel 1936, in un momento in cui l’attenzione internazionale era concentrata sulla guerra civile spagnola, che appariva come un’allusione a un ancora più ampio e odioso conflitto che minacciava, in quella stessa temperie, l’Europa e il mondo.
Federico García Lorca divenne quasi il simbolo della fragilità di ciò che è nobile e gentile, ma è esposto, nel medesimo tempo, alle forze della distruzione. La sua poesia rinnovava l’immagine tradizionale della Spagna, restando tuttavia nel suo solco. La Spagna come patria di sentimenti nobili e violenti, di un primitivismo che possiede un’eleganza e una raffinatezza istintive, si ritrovava nella sua opera poetica e nel suo teatro. Lorca, scrisse a suo tempo Elio Vittorini (uno dei pionieri, con Carlo Bo ed Oreste Macrì, della sua fortuna in Italia), era «la semplice gioia di vivere», in contrasto con un Montale o un Eliot, la cui poesia è verticale, intrisa di esistenzialismo, inquinata dal male di vivere. In García Lorca le esperienze surrealiste del flamenco e della corrida divennero elementi fondativi del suo successo che raggiunse, sia in Italia che nel resto del mondo, dimensioni senza precedenti per un poeta.
Nella sua opera, inoltre, si compendia e si trasferisce, in una sfera sublime di poesia e su un piano di ardua forma d’arte, tutto il complesso mondo di esperienza storica e mitologica di una generazione di poeti che trapassa dal fatto psicologico e corale della contemporaneità a una struttura organica e consapevole della tradizione letteraria spagnola. Solamente da questa considerazione storico-formale, che trascende il concetto positivista di generazione letteraria, è possibile osservare il significato autentico, il senso vero, di un’opposizione al purismo di un Valery, di un Guillén, di un Juan Ramón Jiménez, al disumano, all’arbitrario e al cerebrale dell’estetica dell’azzardo e delle mode; opposizione che si dà non per esclusione, ma per un vivo e ostinato desiderio di conoscenza ed esperienza della crisi e delle avanguardie europee, affinché non restasse nulla di intentato, nulla di rifiutato e respinto, sul piano umano, che fosse possibile estrarre dalle poetiche più informali e sterili del Novecento.
Il mio incontro con la poesia di Federico García Lorca risale ai primi anni Cinquanta e fu propiziato dall’ascolto del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, recitato da Arnoldo Foà in una celeberrima incisione discografica. Ero a quei tempi uno studente e non pensavo alla poesia se non come a un indigesto oggetto di studio. L’ascolto di quel poemetto, reso ancora più suggestivo dalle profonde e suadenti tonalità vocali di Foà, più che sorprendermi e darmi gioia, mi sbalordì. Non avevo mai letto, o sentito recitare fino a quel momento, versi con quel ritmo ossessivo, con quella forza evocativa, con quel rigoglio metaforico, con quella carica espressiva, con quell’avvertenza superstiziosa per il numero.
Il poemetto era stato composto nel 1935 in memoria di un amico torero e letterato, rimasto ucciso nel corso di una corrida nell’arena di Manzanares. È una stupenda sintesi della poesia lorchiana e si presenta come una sorta di sinfonia funebre in quattro tempi. Il primo tempo, La cogida y la muerte, descrive la morte tragica dell’amico con un sapiente intarsio di tocchi realistici e di visioni liriche, scandite dall’ossessionante ritornello A las cinco de la tarde (“Alle cinque della sera”) che, in cinquantadue versi, viene ripetuto per ben ventisei volte; il secondo tempo, La sangre derramada, in forma di romanza classica spagnola, è l’elogio vero e proprio, sublime mescolanza di elementi tradizionali e di nuove espressività drammatiche; il terzo tempo, Cuerpo presente, e il quarto, Alma ausente, sono delle purissime meditazioni, di un ardente e pur contenuto lirismo, intorno alla morte e al destino dell’uomo, estrema e altissima elegia di un grande poeta che, piangendo davanti al corpo senza vita dell’amico, piangeva senza saperlo la propria e ancora più tragica morte. E, come in altri grandi poeti e artisti (Manrique, Quevedo, Goya, Unamuno) un’intensa e incontenibile brama di vita sgorga in Lorca da un sentimento tremendo della morte, facendosi arte in un supremo sforzo di conoscenza e di salvezza.
Ed è proprio in questo contesto, emotivo e riflessivo nello stesso tempo, che è possibile cogliere il senso e la misura della poesia di Lorca. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías è il suo pezzo di maggior elaborazione ed orchestrazione con uno sfondo che offre una continua possibilità di risonanza. Lo si può definire una sorta di racconto per simboli, in cui il poeta, oltre a ripercorrere, su di un’ossessiva avvertenza del tempo, il motivo del dolore e della tragedia che si è consumata, gioca la carta della drammaturgia, sviluppa il racconto allargando sempre più la propria visione, mentre il tema della morte, applicato alla comune realtà, ci fornisce l’interpretazione, giustifica lo scatto poetico sempre più sicuro e improvviso, la costruzione del verso, tenuta su una linea sempre più semplice e suggestiva.
Lo schema metrico-ritmico della prima parte del Llanto, con l’iterazione del verso a A las cinco de la tarde ha un precedente in un altro testo di Lorca, intitolato Son de negros en Cuba, nel quale il ritornello “Iré a Santiago” è ripetuto per ben diciotto volte in soli trentotto versi. Ciò offre l’occasione per soffermarsi su un’altra opera lorchiana, nella quale tale testo è contenuto; un’opera che costituisce uno dei vertici della poesia spagnola del Novecento e cioè Poeta en Nueva York, indubbiamente l’opera più ambiziosa del poeta di Granada e una delle chiavi della poesia surrealista, sia pure di un surrealismo da intendersi non come “sistema” ma come parte integrante della concezione globale che García Lorca aveva della sua esperienza poetica.
Aveva scritto, infatti, nel 1928 che «La luce del poeta è la contraddizione. Il poeta non mira né pretende di convincere nessuno. Sarebbe indegno della poesia se assumesse questa posizione, in quanto la poesia non vuole adepti ma amanti. La poesia alza siepi di rovo e sparge cocci di vetro perché le mani di coloro che la cercano si feriscano per amor suo»”. E il lettore, che per la prima volta si pone senza pregiudizi di fronte a questa opera, capirà facilmente quello che egli chiedeva: un’attitudine nuova dinanzi al fenomeno poetico, un’inquietudine accecante verso le sue forme di comunicazione.
Poeta en Nueva York fu composta tra il 1929 e il 1930 e la metropoli statunitense, come lo stesso titolo suggerisce, ne è il tema principale. Ma la città è anche una metafora dell’intensa crisi spirituale che il poeta stava attraversando. Ad uno sguardo superficiale può sembrare perfino che il suo ritmo sia gioioso, ma, ad una lettura più attenta e meditata, ci si accorge che Poeta en Nueva York è un terribile canto di disperato dolore e di allucinante presentimento di morte, in cui il drammatismo andaluso di Romancero e del Cante jondo si fa angoscia universale. Se il motivo occasionale è costituito dallo sgomento causato dall’incontro di Lorca con la smisurata città americana tanto disumanamente diversa dalla piccola Granata natia, in realtà la fantasmagoria, che il poeta evoca, esprime con inaudita potenza l’assurdità dell’esistenza e l’inconsistenza della realtà delle cose.
A contatto con la realtà newyorchese, ossia con una «civiltà senza radici», scatta in García Lorca una presa di posizione anticapitalistica, non nuova certamente nella cultura spagnola e in tanta cultura europea, ma che non è, come nell’anticapitalismo tradizionale, nostalgia di un altro tempo o un alibi per uno sterile isolamento, bensì rifiuto e ribellione in una dimensione totalmente contemporanea. Se, come è stato scritto, Lorca scopre la storia in occasione del suo viaggio a New York, è sempre come scoperta di un processo attuale, di uno scontro in atto.
La metafora visionaria, che anima Poeta en Nueva York, è per il poeta la strada per cercare di rivelare e risolvere nella poesia questo scontro, questa lacerazione. Attraverso l’accostamento di diversi piani della realtà, il paesaggio interiore si materializza mentre quello esteriore si interiorizza; solo che qui l’accostamento è simbolo di un’irrevocabile separazione. I miti lorchiani manifestano, in questa raccolta, segni in positivo e in negativo. Al positivo stanno le entità mitiche del Romancero (l’albero, il bambino, la farfalla, il paesaggio: insomma la natura), al negativo troviamo al contrario il cemento, la città, la discriminazione sociale, ossia tutto ciò che è prodotto dell’uomo e della cultura. Per tutta l’opera predominano il bianco e il nero, simboli di opposizione totale: dalla gamma semantica del vuoto, della nausea, fino alla maledizione e a forme inequivocabili di profetismo.
Quello di Lorca è la scoperta di un mondo inflessibile, d’una realtà straziante, della scissione tra soggettività ed oggettività, tra uomo e mondo, incarnato dalla macchina e dal denaro, dalla tecnica e dal profitto. Tra l’altro, siamo negli anni della crisi e New York, gonfia di rumore e disperazione, mostra di sé tutto il negativo che possiede. Lorca scrive freneticamente e in quello che scrive si riflette la sua angoscia per gli operai in sciopero, per i bambini abbandonati, per le condizioni di miseria in cui vive la gente di colore. La violenza e l’ingiustizia del capitalismo gli ispirano composizioni piene di immagini di degradazione e di dolore. Un’esperienza che gli servirà come stimolo per cercare, nel laboratorio della sua fantasia, una nuova voce e rimuovere quanto residua di vecchio nella sua poesia precedente.
Attraverso la scoperta della discriminazione, dell’oppressione e dell’ingiustizia sociale, egli si muove infatti verso una nozione dell’umano che è ormai lontanissima da quella ottocentesca, una nozione che avverte il conflitto a tutti i livelli: dall’individuo alla società. Così il mondo dei gitani, che nel Romancero recava in sé l’ambiguità di apparire troppo compatto (esposto cioè solo esternamente alla minaccia della morte o della guardia civile), appare ora come il termine di un conflitto. Su questa base egli muove verso una critica pragmatica con l’invenzione di un linguaggio del tutto nuovo, che attesta anche la sua definitiva adesione al surrealismo, adesione, peraltro, confermata dalla sua esperienza poetica successiva, rappresentata dalle liriche d’amore di Diván de Tamarit (1935) e, ad un livello ben più alto di capolavoro assoluto, dal Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Solo che in questa ricerca Lorca, che, come si sa, proviene da una cultura rimasta “autre”, non porta la cattiva coscienza dell’etnocentrismo come è accaduto a tanti scrittori francesi e tedeschi. La sua cultura di spagnolo, e di spagnolo meridionale e anche irregolare, gli consente di scoprire quasi naturalmente, nel centro della società capitalistica newyorchese, un’altra cultura, quella cioè dei subalterni e degli emarginati, e di sentirla subito come opposizione in senso antagonistico.
C’è in Poeta en Nueva York un testo che si intitola L’aurora, nel quale sono contenute nomenclature lessicali e sintagmi che bene mettono in evidenza l’antagonismo lorchiano nei confronti della civiltà delle macchine e della discriminazione razziale, che di lì ad una quindicina d’anni (ma Lorca non ne sarà testimone) conquisterà anche la vecchia Europa con le conseguenza che tutti conosciamo:
L’aurora di New York
ha quattro colonne di fango
e un uragano di nere colombe.
L’aurora di New York geme
per immense scale
cercando tra le lische
tuberose di angoscia disegnata.
L’aurora viene e nessuno la riceve in bocca
perché lì non c’è domani né speranza possibile.
A volte le monete in sciami furiosi
trapassano e divorano bambini abbandonati.
I primi che escono capiscono con le loro ossa
che non vi saranno paradiso né amori sfogliati;
sanno che vanno nel fango di numeri e leggi
nei giochi senz’arte, in sudori infruttuosi.
La luce è sepolta con catene e rumori
in impudica sfida di scienza senza radici.
Nei sobborghi c’è gente che vacilla insonne
appena uscita da un naufragio di sangue.
Si noti la positività del titolo in contrapposizione a una serie di spezzoni testuali dai contenuti decisamente negativi: «colonne di fango», «uragano di nere colombe», «acque putride», «lì non c’è domani né speranza possibile», «non vi saranno paradiso né amori sfogliati», «sudori infruttuosi», «la luce è sepolta con catene e rumori», «nei sobborghi c’è gente che vacilla insonne / appena uscita da un naufragio di sangue», ecc. Il quadro che Lorca ci presenta, in questo testo, è apocalittico e denuncia tutta la sproporzione, tutto lo scarto esistente tra un sentimento regionale, domestico e popolare come quello ad esempio del Libro de poemas del 1921 (pervaso da una suggestione ingenua della realtà naturale, dalla vena sottile, trasparente e immobile d’uno sguardo lontano) e il Lorca problematico, innestato sulla pianta di una consapevolezza della ingiustizia e della tragedia in atto.
In tal senso, Poeta en Nueva York si offrecome un’esperienza poetica creazionista, e, sotto certi aspetti, ultraista nell’uso della metafora multipla, conseguentemente ad una rinnovata lettura della tradizione poetica spagnola aperta, per convergenze parallele, al surrealismo francese, al mondo dell’onirismo e dell’inconscio. Attraverso questa via riappare, nella sua poesia, la storia come storia individuale e collettiva; una storia che guarda al mondo informe e disordinato della quotidianità per dominarlo, tra nostalgie arcaiche e slancio avveniristico. Una scelta che lo porterà verso l’azione, intesa come verifica possibile per chi abbia rifiutato la strada minoritaria della contemplazione e della perfezione formale.
PIETRO CIVITAREALE
Questo saggio viene pubblicato con l’autorizzazione espressa da parte dell’Autore, il noto poeta e critico letterario Pietro Civitareale, saggista attento e amante dell’opera letteraria di Lorca. “Federico García Lorca: dal Llanto por Ignacio Sánchez Mejías a Poeta en Nueva York” è stato precedentemente pubblicato nel suo volume Letteratura e dintorni (Arsenio Edizioni, Martinsicuro, 2020).
La riproduzione del presente testo, in formato integrale e/o di stralci, su qualsiasi tipo di supporto non è consentita senza l’autorizzazione da parte dell’Autore.