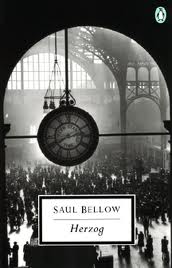Nel periodo immediatamente successivo alla diffusione della notizia della fucilazione del poeta granadino Federico García Lorca, avvenuta nell’agosto del 1936 nella campagna sterrata tra Víznar ed Alfacar, un gran numero di intellettuali, soprattutto di nazionalità spagnola e che avevano avuto l’opportunità di averlo conosciuto di persona e non solo tramite i suoi scritti, come oggi è dato a noi posteri, scrissero e dedicarono liriche, più o meno intimiste, talora aggressive e sfiduciate verso l’abominio della guerra civile, tal altra incentrate sugli sprazzi di amicizia rievocati nella tragica occasione. Tra di loro Antonio Machado, celebre per le raccolte poetiche Campos de Castilla e Soledades nelle quali è possibile rintracciare una pagina vivida di alcune tra le più importanti tendenze di inizio secolo scorso: il novecentismo e il modernismo.
Antonio Machado, che apparteneva a una generazione precedente a quella di Lorca, e ad un ambiente regionale profondamente diverso dall’Andalusia torrida e fiera dei romances di Lorca, ossia quello della Castiglia autentica, di quello scenario castizo nel quale la tradizione ci dice che fu culla della lingua e della cultura castigliana prima e spagnola poi, dedicò al granadino scomparso la celebre poesia “El crimen fue en Granada” volendo intendere con Granada non tanto la città dove pure Lorca con la sua famiglia visse per vari anni ma, come si dice in spagnolo, el entorno, ossia la zona di provincia ad essa prossima dove, appunto, secondo le documentazioni più attestate, avrebbe trovato la morte. Il condizionale è d’obbligo perché dalla data della sua fucilazione, modalità dell’esecuzione sulla quale gran parte degli storici sono concordi quasi da descrivere una posizione unanime, sino ad oggi si è prodotta una grande quantità di testi improntati a una resa biografica delle vicende di Lorca e vere e proprie cronache documentarie fatte di investigazioni, repertazione di materiali e tanto altro per cercare di poter scrivere in maniera più verosimigliante alla realtà quanto di drammatico accadde.

La stampa spagnola ha llevado a cabo, ossia ha portato avanti, nel corso degli anni e in maniera sempre più attenta e scrupolosa in tempi a noi più vicini, un particolare interesse documentario verso gli ultimi istanti della vita dell’uomo, del luogo del suo assassinio (ancora dibattuto e non localizzato con certezza) e soprattutto del seppellimento. Persistono, infatti, considerazioni diverse in merito al luogo di sepoltura che negli ultimi anni alcuni gruppi ideologici che conservano la memoria del poeta sono giunti alla richiesta di scavo di alcune delle zone identificate con i materiali documentari per provvedere all’esumazione del corpo ed, eventualmente, ad esami del DNA. Ma tale direzione delle ricerche storiche, che debbono essere necessariamente condotte per poter far chiarezza e cancellare la possibilità della formulazione di piste revisioniste che ne infangherebbero la memoria, è stata ben presto sbarrata dalla famiglia García Lorca quando decise di non dare il consenso all’esumazione dei possibili resti del congiunto per motivazioni di carattere personale.
Alcuni studiosi hanno anche avanzato la possibilità che Federico García Lorca in effetti non si troverebbe sepolto in qualche recondito spazio della campagna andalusa dato che uno dei suoi ultimi amanti, l’uruguayo Enrique Amorim, grazie alle sue fornitissime possibilità economiche avrebbe provveduto alla traslazione (o al vero e proprio furto?) della salma fatta arrivare sino a Salto (Uruguay) dove oggi sarebbero conservate le sue ossa in una cassa murata all’interno del monumento in onore a Lorca. Posizione questa che ha avuto poca eco e che non è mai stata accreditata sebbene lo scrittore peruviano Santiago Roncagliolo abbia deciso di dedicare un intero volume, con documenti alla mano, a sostegno di questa tesi[1]. Senza ombra di dubbio restano documentati l’affetto e l’amore di Lorca per Amorim al quale dedicò pure dei bozzetti e con ampia probabilità una serie di poesie che hanno finito, poi, per costituire la raccolta di Poemas del amor oscuro, ma reputo azzardata (pur non avendo letto il volume di Roncagliolo) la sua posizione soprattutto alla luce di una impraticabilità dell’esumazione dei resti avvenuta in sordina dalla famiglia, dagli enti locali e dalla Spagna tutta.
Ma per ritornare ad Antonio Machado nella lirica citata ci troviamo dinanzi a una elegia che utilizza un tono indignato con parole dure, tese a fotografare l’attimo di dolore catturato nella viltà della fucilazione: “Mataron a Federico / cuando la luz asomaba. / El pelotón de verdugos / no osó mirarle a la cara […] / Muerto cayó Federico / -sangre en la frente y plomo en las entrañas”[2].
Il pianto che parte da Granada, dal luogo del tragico misfatto, si fa nazionale, internazionale e cosmico abbracciando quanti hanno indefessamente difeso l’ideologia repubblicana (democratica) contro il franchismo (il totalitarismo). Il dolore è pungente, totalizzante e disarmante, privo di retorica e le descrizioni lapidarie di Machado sono altamente visive, tanto che riusciamo a veder scorrere sotto ai nostri occhi le immagini dell’abominio.
La seconda strofa del carme luttuoso che si intitola “El poeta y la muerte” è come un lento passaggio su uno stradello che ci incammina al camposanto. Il poeta ora non è più in compagnia del nemico, del torturatore, dell’annientatore delle libertà ma al contempo non è neppure solo: Machado trasmette qui un ultimo accorato tentativo dialogico di García Lorca; quasi non accettando la sua dipartita fa ancora parlare l’amico Federico in uno squarcio di conversazione profondamente lirica in cui il poeta appena deceduto si intrattiene con la Morte. Il crimine, come recita il titolo della poesia, accadde a Granada ma esso fu pianto in ogni angolo del mondo.
Pablo Neruda, con il quale García Lorca strinse una conoscenza piuttosto importante per entrambi durante gli anni di frequentazione della Residencia de Estudiantes a Madrid in una lirica a lui dedicata (prima della sua morte) lo definiva in maniera alquanto poetica con l’espressione sintetica di un naranjo enlutado[3] ravvisando nel Granadino sia la componente più primitiva, naturalistica e popolare caratterizzante la sua appartenenza all’Andalusia, terra di zagare e profumi speziati, sia una infelicità o una turbolenza di fondo nell’animo del poeta (forse dovuta dalla critica situazione politica venutasi a creare in Spagna con l’avvento della guerra civile e il fatto che venisse stigmatizzato dalla cultura ufficiale o ancora la sua condizione di omosessuale di certo non apprezzata né consentita dalla società ultra-moralizzatrice del periodo).
Queste sono solamente due delle testimonianze alla memoria di García Lorca che debbono necessariamente essere tenute da conto quando ci si avvicina alla sua poliedrica personalità come avviene in questo caso in cui l’amico e poeta palermitano Emanuele Marcuccio pone alla mia attenzione due liriche ispirate e dedicate al poeta granadino. Sono poesie già di mia conoscenza sia per averle apprezzate in lettura, sia per averle commentate in almeno una presentazione dei libri dell’autore ed anche per essermi occupato delle relative traduzioni in spagnolo.

Per uno come Emanuele Marcuccio che si è formato sui classici ed ha amato instancabilmente la poesia tradizionalista, si veda Leopardi, anima d’influenza notevole nella sua prima produzione e poi Pascoli e Carducci, aver posto l’attenzione nei riguardi di Federico García Lorca è cosa già di per sé notevole: sia per aver allargato lo sguardo verso una letteratura straniera, sebbene sia praticamente “sorella” di quella italiana, sia nello specifico per essersi interessato alla figura di un intellettuale come quello di García Lorca che ha al suo interno un universo di mondi tutt’altro che tradizionalisti e canonici. Di García Lorca in questi suoi due componimenti a Marcuccio non interessa tanto la sua produzione poetica (che dimostra, comunque, di conoscere per la scelta azzeccata e consona di alcune terminologie e simboli) né quella teatrale (García Lorca fu uno dei maggiori drammaturghi del secolo scorso, influenzato nel suo teatro da varie ispirazioni: dal surrealismo al comico-burlesco, sino alla serie dei drammi rurali, nonostante in Italia il suo nome venga richiamato spesso unicamente in relazione alla sua attività poetica), ma un evento determinante della stessa componente biografica dell’uomo: la sua morte.
García Lorca morì nel 1936, nell’anno che detta l’inizio di una dolorosissima guerra civile dove i repubblicani si scontrarono contro la frangia nazionalista dei militari appoggiati anche dai monarchici, dai carlisti e dalla Chiesa. Le tante battaglie che infuocarono il paese non furono solo dettate da una strenua difesa delle rispettive ideologie ma riguardarono per l’appunto anche la dimensione religiosa tanto che esponenti del bando repubblicano (socialisti, comunisti, anarchici, laici) provvidero anche a una serie di attacchi, saccheggi e distruzioni di luoghi religiosi con un gran numero di preti massacrati e giustiziati in processi sommari.
Chi conosce l’universo poetico di García Lorca sa che esiste nella sua visione del mondo una dimensione religiosa, un Dio, spesso insito nell’ambiente che lo circonda sebbene eviti di appellarsi a lui, di invocarlo o di pregarlo in una maniera che ci consentirebbe di definirlo una persona animata da un sentimento cattolico. Sappiamo anche che dal punto di vista ideologico e per il suo serio impegno nel sociale che lo portava sempre a schierarsi in prima linea per la difesa e la tutela dell’emarginato, il poeta si collocava all’interno della dimensione anti-militare, anti-nazionale. I nazionalisti, strenui difensori di un concetto di moralità intoccato e devoti al potere dell’onore, si scaglieranno duramente contro García Lorca ritenuto un rojo pericoloso perché persona con un grande seguito e portavoce di ideali repubblicani, democratici.
Ed è così che poco dopo le attività del teatro itinerante “La Barraca” ideato assieme ad Eduardo Ugarte sono stroncate e messe a tacere del tutto perché Lorca viene a rappresentare per i nazionalisti una spia comunista, un acerrimo nemico, profondamente temuto proprio per le grandi masse che lo apprezzano e lo seguono. Qualcosa di simile avverrà con la messa in scena dell’opera teatrale Yerma nella quale Lorca mette in scena la storia di una donna che, a causa della sua infertilità e della anaffettività e trascuratezza del marito, finirà per perdere la testa e rendersi colpevole di uxoricidio. Nell’opera, al di là del tragico epilogo, la finalità era quella di diffondere e inscenare un universo domestico in cui la donna (che nella visione dei nazionalisti deve essere assoggettata all’uomo, l’unico padrone, perché ad egli è inferiore) non solo non accetta i divieti coniugali che le impongono di essere relegata in casa e di non intrattenere conversazioni con nessuno, ma addirittura si arma della propria forza fino ad allora repressa ed affronta, con violenza, il marito, fino a vincerlo e ucciderlo. Sono contenuti, questi, estremamente pericolosi che mettono in scena un ribaltamento sconveniente per i nazionalisti nel modo di intendere la famiglia spagnola: non più il patriarca o padre-padrone che comanda e la donna che esegue, ma la donna che, stanca e sfiduciata, razionalmente portatrice di una visione ugualitaria, cerca ed ottiene l’equiparazione dei sessi, smitizzando i pilastri della società retrograda.
Perché García Lorca viene assassinato? È presto detto: perché è una persona temuta e fastidiosa per il neonato regime totalitario, perché è portavoce di ideali repubblicani nutriti dalla difesa della democrazia e dal rispetto delle libertà, perché è un intellettuale di spicco con una grande presa sulla società, perché con la sua letteratura (il teatro itinerante “La Barraca” e la trilogia drammatica) è portavoce di una società provinciale retrograda e dispotica in cui la donna è considerata inferiore, perché sfida lo stringente concetto di onore di impronta settecentesca, lo minaccia, lo de-costruisce e ne mette in luce le idiosincrasie nel suo periodo; perché è omosessuale e in quanto tale portatore di una stravaganza di fondo che non collima con la rettitudine e l’austerità del pensiero anti-liberale dei nazionalisti difensori dell’idea del “sesso forte”.
Ma non è solo questo, infatti in tempi a noi più recenti alcuni studiosi hanno voluto leggere nell’omicidio di Lorca non il motivo ideologico-politico ben noto a tutti, quanto, invece, un terribile episodio di vendetta, un regolamento di conti tra esponenti di famiglie storicamente avversarie nella Vega[4] granadina. In particolare è Miguel Caballero Pérez il difensore di questa tesi che viene esposta in maniera documentata nel suo recente libro nel quale non manca di portare episodi concreti di animosità e vere e proprie lotte familiari per il controllo e il prestigio nella zona.[5] Questo per dovere di cronaca per quanti vorranno effettuare maggiori letture ed analisi in tale direzione ben tenendo in considerazione, comunque, che a tutt’oggi la pista più creduta e credibile, data per ufficiale, sia quella che vide Lorca assassinato per ragioni ideologiche (la sua adozione alla Repubblica) e per oscenità/discredito della morale (la sua omosessualità).
Per tornare ai componimenti di Emanuele Marcuccio è necessario osservare come il linguaggio tendenzialmente rilassato del poeta si faccia in queste liriche fortemente spietato, condensato nelle immagini e pregno di desolazione. In “Assassinio: Terzo omaggio a García Lorca”[6] (poesia scritta il 18 dicembre 1997):
Putrida vena,
d’un orizzonte disseccato.
I nardi esplorano
il loro chiacchiericcio inconsueto,
e nuvole di fango inondano
coi loro piombi infuocati.
Un’alba azzurra
si stende solitaria
su ambiguo crocevia,
e un riverbero di verde luna
si accende, su occhi di fumo.
Marcuccio esordisce con un verso forte dal quale traspare vivida una suggestione olfattiva nauseante collegata da subito al tema della corporeità e del sangue (una delle immagini-simbolo nella produzione di García Lorca): “putrida vena”. Il Nostro però sembra volersi interessare qui, più che al fermo immagine di una scena di guerra in cui la morte è fagocitata dal processo di decomposizione del corpo che produce un olezzo “putrid[o]” alla definizione del paesaggio, cioè al tratteggiamento del locus che ospita la nefanda azione umana. È quello di uno scenario abbandonato, stepposo, arido e apparentemente privo di presenze umane; quell’ “orizzonte disseccato” è uno spazio-trappola nel quale il Sole, unico indiscusso sovrano e il silenzio dei campi sembrano eludere ogni altra presenza che, invece, si farà viva e in maniera alquanto sadica nel corso della lirica.
L’occhio del Marcuccio si posa con meticolosità negli “angoli” di quella campagna che apparentemente è una campagna comune e che non ha nulla di particolarmente rilevante se non fosse che i nardi (fiori che pullulano di vita nelle poesie lorchiane[7]) vengono colti nel loro “chiacchiericcio inconsueto”. Sono i primi testimoni del massacro, la natura è pavidamente spettatrice dell’abominio che di lì a poco si consumerà dinanzi ai propri occhi, impotente e addolorata essa stessa. Le “nuvole di fango”, se si eccettua il verso d’apertura, è la prima immagine perturbante che interviene nella lirica a descrivere un cielo coperto e minaccioso, ben diverso da quel sole accecante che il lettore ha potuto cogliere, non nominato, nei precedenti versi che descrivevano un “orizzonte disseccato”.
Inizia in questo modo la parabola degradante della poesia: Marcuccio costruisce in primis con soverchia attenzione il setting dell’azione passando poi a connotarne con particolarità alcuni degli elementi che lo compongono sino a che il cielo sembra abbuiarsi di colpo e farsi di “fango”, indistinto, melmoso, viscido e pesante; il grigiore vacuo del cielo lascia ben presto il posto a quello ben più doloroso delle munizioni d’artiglieria colte nel momento del fuoco.
Il silenzio della campagna, prima armonizzato dalla presenza di un lieve “chiacchiericcio” dei nardi, ora è rotto per sempre in maniera irreparabile. I “piombi infuocati” sono stati azionati e hanno colpito i bersagli[8]. È il momento della morte fisica del poeta, della sua caduta scomposta a terra, faccia sull’erba secca, della fine delle speranze e al contempo un ammutinamento della natura che, indifesa e oltraggiata, non è capace di osservare il sangue che cola a terra.
La poesia è sapientemente costruita tenendo in considerazione un’ampia realizzazione temporale che si delinea in un prima della fucilazione e in un dopo. Il post-mortem lorchiano è investito da una “alba azzurra” che ha perso, però, la coralità autentica della natura e il conforto del cantore del popolo e infatti essa appare “solitaria” quasi da stonare con quella scena di morte che si è consumata nelle ore precedenti sotto di essa.
Tutto a questo punto resta galleggiante nell’indefinitezza, nell’impossibilità di caratterizzazione, ora che è morto il poeta che più di ogni altro aveva cantato la Terra: l’alba è “solitaria” e anche il crocevia nei pressi dei luoghi della tragedia è “ambiguo”. Sia perché, come detto sopra, il luogo dell’esecuzione di Lorca non venne mai identificato con indubbia certezza e permangono ancor oggi posizioni discordanti in merito, sia perché è inutile dinanzi alla Morte che esacerba dolori e sconfigge il tempo utilizzare un metro toponomastico: non ha senso identificare quale sia il crocevia della Morte perché in ogni spazio ora si rammenta il lutto e ci si strugge.

Marcuccio mostra di aver letto con profondità le liriche del Nostro e di conoscerle con doviziosità, soprattutto nel momento in cui mostra interesse verso la componente cromatica degli elementi, aspetto che costituisce uno dei nerbi costitutivi della liricità lorchiana. Ed ecco che dopo il giallo accecante dei campi “disseccat[i]”, il grigio scuro delle nuvole, l’argento pesante del piombo fuso, il rosso dell’incandescenza dei colpi d’arma da fuoco e del sangue, sopraggiunge prima l’azzurro a rischiarare l’ambiente come una sorta di purificazione e ancora, la luna nel suo “riverbero di verde”. La luna quale simbolo nella “mitologia” lorchiana è sempre sintomo o sinonimo di morte così come lo è il verde: si pensi ad Adela in La casa de Bernarda Alba che, contro il parere della madre che la obbliga a vestire il lutto per la morte del padre, decide d’indossare l’abito verde e deroga a una serie di atteggiamenti che le sono stati imposti tanto da divenire una delle “ribelli” lorchiane più note. Chi conosce il dramma sa anche che a dispetto di tanto vitalismo ed energia (altro significato del verde visto nel cambiamento e nella fertilità) al termine la ragazza troverà la morte in una delle scene più commoventi dell’intero teatro del Nostro.
Ed è così che in chiusura, dopo aver tratteggiato l’ambiente naturalistico che accoglie la morte e avendoci fornito l’immagine sonora della fucilazione, che Marcuccio ritorna a serrare le fila sul corpo martoriato del poeta. I suoi “occhi di fumo”, ormai vacui ed eternamente incantati, privi di lucidità e di movimento sembrano rilucere sotto quella luna argentea e rimandare l’errore sperimentato negli ultimi istanti di vita. La luna è così testimone di una morte dolorosa che ogni notte, con il suo lento incedere nel cielo, sembra riproporsi con la sua inaudita ferocia. Quegli occhi svuotati, ormai fatti cenere rappresentano lo sguardo mitico di un uomo che ha combattuto con la parola in difesa del diverso e che ha ricevuto l’oscuramento dell’esperienza visiva quale condanna estrema, proprio lui che era affranto di luce e signore indiscusso nell’utilizzo della tavolozza dei colori.
Nell’altra poesia lorchiana di Marcuccio (“Omaggio a García Lorca”, scritta il primo maggio 1997)[9]
Felce d’azzurro,
scrosci di tempesta vespertina,
autunno vaporoso e nodoso,
rammarico dell’ormai svanito,
vita rossa di sangue coagulato,
erpici identici e convessi
in un plotone di fucileria,
schizzi incandescenti trasvolano
per la dura terra,
per un cielo di speranze placate,
di ardente divampamento di luce
a foggia di croce,
verso un punto centrale.
ritroviamo il livore del colore azzurro, ora legato all’immagine muschiosa della felce a descrivere uno scenario naturalistico più paludoso e umido, differente rispetto al precedente in cui l’azione bruciante del sole aveva prodotto campi “disseccat[i]”.
Pur condividendo una sintassi aspra e tagliente, in linea con la durezza degli elementi evocati, questa poesia si discosta dall’altra per aver maggiormente i connotati di una vera e propria elegia. La lirica, infatti, non fotografa il momento della fucilazione, del trapasso dell’uomo, e ha piuttosto la fisionomia di una commemorazione nei tempi successivi all’assassinio: si parla di “autunno vaporoso e nodoso” benché Lorca venne ucciso nell’estate del 1936 ed è da intendere, allora, il ricordo doloroso che Marcuccio ne fa attraverso il tempo, ripensando all’atto nefando che provocò la morte del poeta. Non a caso è richiamato il “rammarico dell’ormai svanito”: a questo punto la storia è stata scritta e non c’è niente da fare se non tributarne il ricordo (diversamente dall’altra lirica che, invece, verseggia l’accadimento nefasto quasi in presa diretta).
Il sangue non è liquido e neppure caldo, non sgorga dal corpo, i zampilli non imbevono la terra (come avveniva nell’elegia Llanto por Ignacio Sánchez Mejías che Lorca dedicò all’amico e torero) poiché il sangue si è rappreso, il sole lo ha seccato e il trascorrere del tempo lo ha “coagulato” privandolo della sua materialità fluida da divenire roccia di una vita ormai tramontata. E conseguentemente segue il ricordo visivo del momento dell’esecuzione con gli “schizzi incandescenti” di vita del poeta che, trivellato da colpi alle spalle, finiva per esalare gli ultimi respiri.
La terra si è fatta “dura” perché le stagioni l’hanno appiattita, impoverita, sfruttata ma anche perché è l’uomo che l’ha esacerbata e oltraggiata con l’azione ignominiosa e perché è lui a essere duro (cinico e insensibile). La vita, vista nel regolare scorrere dei fluidi, ha subito un arresto che l’ha condotta a un processo di deumidificazione e vera e propria corificazione. Solo il cielo, allora, proprio come avveniva nella lirica precedente, sembra mantenere il suo stato di materia, vacuo e aeriforme, uno spazio incontaminato che, però, fa da cappa stagnante a quanto sulla terra accade. L’accecante luce di un “ardente divampamento” sembra quasi il riflesso di un rogo disumano che ha la sembianza indistinta di una forma ectoplasmatica dotata di luce propria, impossibile da concepire che marca il luogo della disfatta e della viltà umana.
Le immagini costruite dal Marcuccio, la “putrida vena”, le “nuvole di fango”, gli “schizzi incandescenti”, l’ “ardente divampamento”, apparentemente stridenti perché costruite spesso su sistemi di sineddoche e sinestesie trasmettono con vividezza la scena di dolore e sono altresì capaci di far risaltare dimensioni sensoriali quali l’udito nel boato del fucile, la caduta, goffa, del corpo a terra e di far echeggiare quel silenzio massiccio e pungente che come un manto torna a coprire la scena dopo l’oltraggio al mondo della natura. La meticolosa resa visiva delle immagini tanto da poter parlare di un concretismo materico iperrealista, contribuisce nettamente alla trasposizione di un sentimento profondamente indignato e offeso verso lo scempio perpetuato. I tragici quadri paesaggistici ed emozionali si fanno così proclami di un’ingiustizia dolorosa dovuta alla messa al bando delle libertà fondamentali e al contempo costruiscono visivamente un manifesto convinto alla lotta non violenta e alla salvifica confessione nella Parola.
LORENZO SPURIO
Jesi, 10 agosto 2015
[1] Santiago Roncagliolo, El amante uruguayo. Una historia real, Alcalá Grupo Editorial, 2012.
[2] “Ammazzarono a Federico / quando la luce spuntava. Il plotone dei boia / non osò guardarlo in faccia […] / Cadde morto Federico / -sangue alla fronte e piombo negli intestini”.
[3] Un arancio in lutto.
[4] Pianura.
[5] Miguel Caballero Pérez, Las trece últimas horas en la vida de Garcia Lorca: el informe que da respuesta a todas las incognitas sobre la muerte del poeta: ¿Quién ordenó su detención?, ¿Por qué le ejecutaron?, ¿Dónde está su cuerpo?, La Esfera de los libros, 2011.
[6] Emanuele Marcuccio, Per una strada, SBC, Ravenna, 2009, p. 75.
[7] Si legga ad esempio l’incipit del “Romance de la luna, luna”: “La luna vino a la fragua / con su polisón de nardos” (“La luna arrivò alla fucina / col suo paniere di nardi”).
[8] Anche se ci interessiamo alla sorte del poeta va osservato che venne fucilato assieme ad altre persone che vennero poi gettate in un’unica fossa.
[9] Emanuele Marcuccio, Per una strada, SBC, Ravenna, 2009, p. 74. Entrambe le poesie fanno parte di un ciclo di quattro che, scritte tra il 1997 e il 2000, Marcuccio ha dedicato al grande poeta spagnolo, con l’intento di rivisitarne lo stile. L’intero ciclo è edito in Per una strada e nel marzo 2013 è stato da me tradotto in lingua spagnola.
Questo saggio è stato pubblicato sulla rivista «Quaderni di Arenaria – Nuova Serie», Palermo, vol. VIII, 2015, pp. 20-27, link: www.quadernidiarenaria.it/volumi/quadernidiarenaria-volume8.pdf, Sito consultato il 05/05/2021 (Si ringrazia il prof. Lucio Zinna per la pubblicazione sulla rivista) ed è stato riproposto sul profilo personale Academia.edu dell’autore.
La pubblicazione del presente saggio, in formato integrale e/o di stralci, su qualsiasi tipo di supporto, non è consentita senza l’autorizzazione da parte dell’Autore.

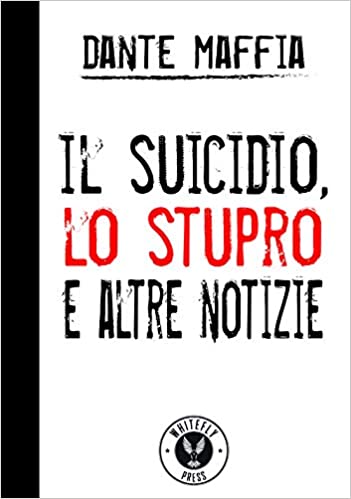
 Questo libro – col quale Di Spigno riconosce un debito alla poetessa Silvia Bre
Questo libro – col quale Di Spigno riconosce un debito alla poetessa Silvia Bre
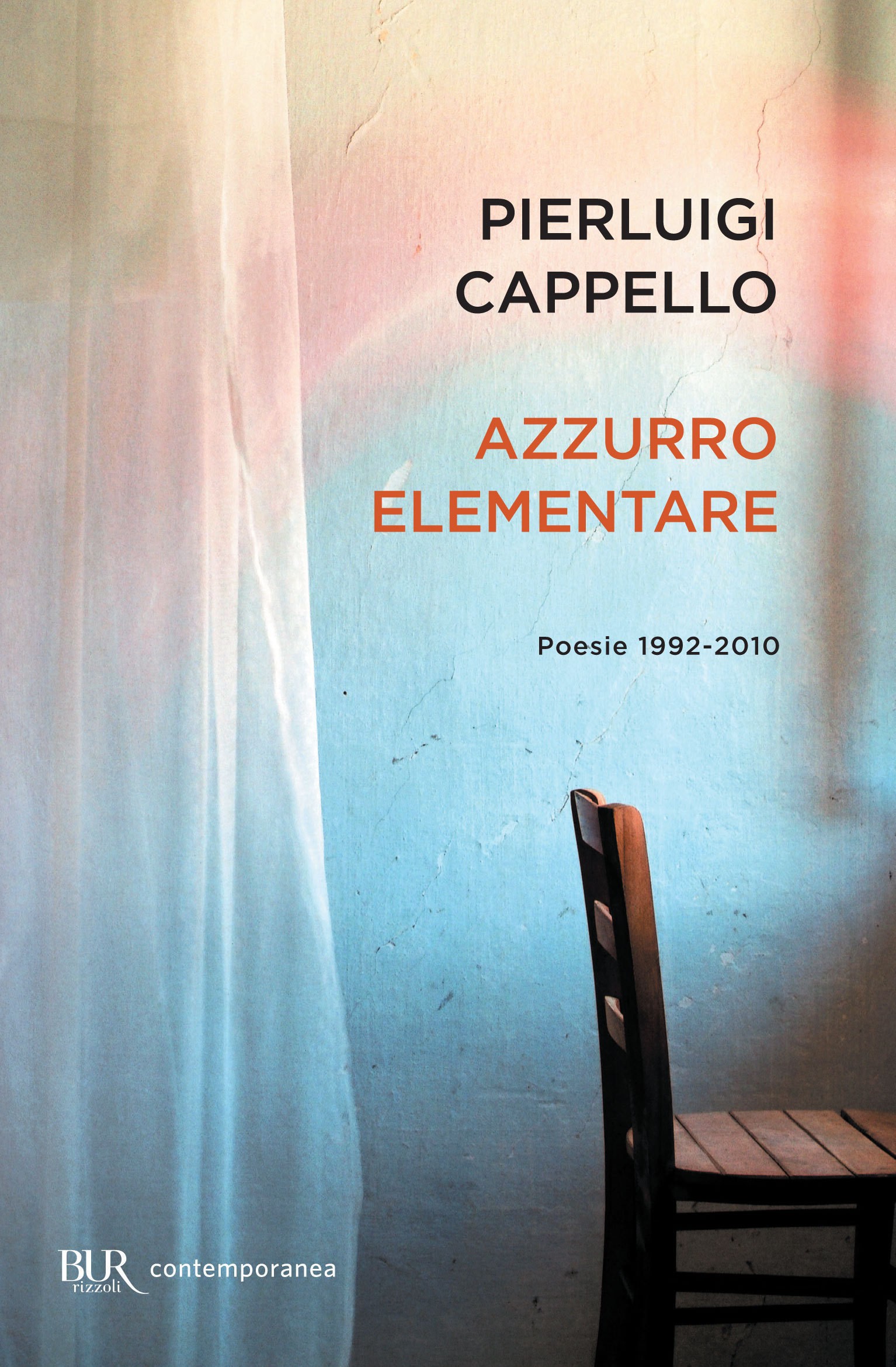 Il 2004 è l’anno della raccolta Dittico. Poesie in italiano e in friulano 1999-2003 divisa in due sezioni: Inniò e Ritornare. Un’opera in cui il friulano è alla ricerca della sua terra, qui riletta in toni intimi, e concepita come un universo popolato da ombre antropologico-secolari. La sua è una lingua senza finzioni, ombre, lacrime e maschere per rapportarsi con l’inedito dialogatore. Qui si evidenzia anche il sogno, inteso come una strada da percorrere nel più totale silenzio e dove l’unica luce visibile è l’oscurità della notte.
Il 2004 è l’anno della raccolta Dittico. Poesie in italiano e in friulano 1999-2003 divisa in due sezioni: Inniò e Ritornare. Un’opera in cui il friulano è alla ricerca della sua terra, qui riletta in toni intimi, e concepita come un universo popolato da ombre antropologico-secolari. La sua è una lingua senza finzioni, ombre, lacrime e maschere per rapportarsi con l’inedito dialogatore. Qui si evidenzia anche il sogno, inteso come una strada da percorrere nel più totale silenzio e dove l’unica luce visibile è l’oscurità della notte.
 Complicato approcciarsi in termini critici a un libro come questo recente di Valentina Meloni, la poetessa di origini romane oggi naturalizzata umbra, che ha dato alle stampe Le regole del controdolore (Temperino rosso edizioni, 2016) sotto eteronimo di “nanita” come è piuttosto nota nel web. Lo è non tanto per la vastità delle ambientazioni intime investigate o le tematiche che sottendono ai vari componimenti,ma proprio per un motivo basico, che si ravvisa alle fondamenta e che obbliga a una domanda di fondo: perché un libro come questo?
Complicato approcciarsi in termini critici a un libro come questo recente di Valentina Meloni, la poetessa di origini romane oggi naturalizzata umbra, che ha dato alle stampe Le regole del controdolore (Temperino rosso edizioni, 2016) sotto eteronimo di “nanita” come è piuttosto nota nel web. Lo è non tanto per la vastità delle ambientazioni intime investigate o le tematiche che sottendono ai vari componimenti,ma proprio per un motivo basico, che si ravvisa alle fondamenta e che obbliga a una domanda di fondo: perché un libro come questo?