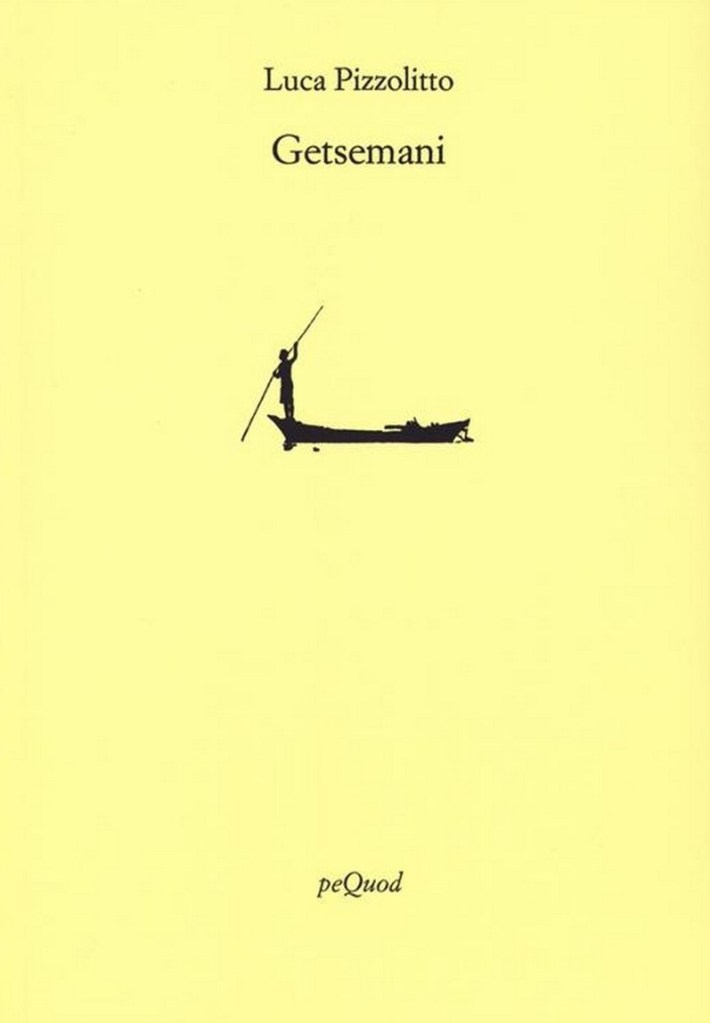Fase di ritrovo in un processo di evoluzione ribollente di trasferte attratte da disorientante progresso, il tempo attuale della poesia volge a quella che in più di un’occasione ho definito memoria eidetica: vale a dire, una memoria impegnata a disoccultare situazioni in prossimità e segni l’andare esterno-interno permanente attraverso un ordito lessicale che, privandosi del disagio procurato da sintagmi isolati (ma nondimeno consolatori), rapprende incidenze progressive lanciando significati profondi tanto della parola pensante, che del pensiero calibrato attraverso la grafia di un dire che sconfina dalla semplice azione scenografica. L’opera rende così merito di una lingua plurale di tipo barthesiano; una lingua che, trasfigurando la partitura per livelli non dissimili da un impianto musicale, configura la pluralità fonetica, quanto logico-viscerale (se possibile) della parola nella sua funzione etica, comprensiva e resistenziale; nella coralità di recondite pulsioni rapprese in una manifestazione costruttiva di condizioni pur se talora acquisite in elusiva incompatibilità.
Risuona in questa sede il richiamo alla poesia di Oronzo Liuzzi; alla reciprocità di parti attraverso le quali ad essa si offre durevolezza nell’ambito segno di spiritualità, una spiritualità che vediamo corrispondere al processo di conoscimento con le moltiplicanti note di un sé mai rarefatto, né tumefatto dall’ambiziosa consuetudine alla disgregazione. Anzi, è in un andamento senza tregua[1] che l’esperienza poetica riflette la sua meditazione su sfondi reali, implicando il sé del movimento «nel» movimento continuo di un sé disposto alla ricerca di un senso sotto il sole irresistibile[2], e consentendo alla coscienza di diffondersi nella permanente azione della parola.
In tal senso, la parola è arte del visualizzare incerti scampoli di uno spazio occupato da tensioni, iridato da rumori del vivere l’inebriante quotidiano: nelle esortazioni pensative, e prodigandosi al di fuori di prepotenti certezze, il verso calibra una neo-storia per scenari che, nell’evitare il freno all’ordito di una tempesta immaginale, si impossessa della città (…) trattiene assimila (…) interpreta attraversa (…)[3]. Così il continuo incedere dei pensieri (che intanto riconquistano un mondo addormentato[4]) dilania le cesure. Non basta: declina il distintivo processo semiotico in un reticolato di intuizioni che rimandano alla coralità crescente di un linguaggio esteso in un rapporto non programmato e che, in più, sfugge alla labirintica geometrizzazione, porgendosi all’ascolto di un sé coscienziale quale segno grafico della spiritualità del vivere di contro alla dilagante reificazione.
Da una postazione di consapevolezza fuor da qualsiasi frivolezza od anche da incauta attrazione al pensiero debole[5], il poeta recupera gli anni, i mesi, i giorni e le ore e contende il tempo interno all’esperienza del tempo esterno raggrumato in affaccio frontale su (…) un sogno un incubo / una pagina della mia vita / che non mi appartiene (…)[6]; accoglie le frange e le sfumature di un tempo coinvolto nei confini psichedelici del sogno aleatorio, da nostalgia nefasta e da speranza illusoria. Alla realtà come risorsa, invece, si volge il cammino del poeta per assottigliare sparse faglie tra il sé sussistente e il sé propenso a prospettarsi come scoperta continua oltre la cornice senza ritorno[7] di un Io proiettato nello specchio. Diramandosi tra i versi e tra una parola e l’altra, la volontà dissuade pensieri circoscritti in un’irrecuperabilità parlata e assume l’aspetto anti-iconico di un’intenzione per ovviare a quel che viene evocato – con intonazione variabile – quale viaggio verticale di coscienza, un viaggio che permette al poeta di librarsi oltre le trame sterili di un esistere vagheggiato in un’icona preconfezionata – laddove pure creiamo mondi di ciò che non siamo[8]. Nessun messaggio si riscontra, quanto, invece, l’orientamento a un’integrazione di parti sospese, nelle quali Oronzo Liuzzi coglie i cori dell’esistente oltre le lusinghe di una parvenza di vivere che, invero, pare inclinarsi alla somiglianza fatiscente del montaliano sonno eterno. E, infatti, attratto dall’impegno che la parola possiede nell’instillare percorsi di coscienza a sé prima che al lettore, Liuzzi si dedica alla scrittura d’arte verbo-visiva, conseguendo il clou interattivo tra materia e l’incedere costante verso la coscienza di sé, allungandosi sulle sensibilità ravvisate nel territorio vasto di un reale verificabile e incline al cambiamento, quanto, talora, inebriato da prevedibilità consolatoria. Qui il poeta non è solo: egli transita laddove l’occhio libero si muove esplora la mente vaga / si perde nell’aria rarefatta sospeso riflette crea / al tramonto emerge finalmente discendo / nell’entusiasmo del tempo il mio[9].
In tal senso la poesia contravviene a una regolamentazione intesa a irrorare di frastuoni inebrianti il ritratto dell’inerte dato. Non solo: dall’inerte presunto il poeta estrae quel che oramai allo strazio dell’imperturbabilità pare affidarsi, tanto che, nel turbato chiedersi, e nutrendosi con schiettezza degli andamenti che scuotono la lettura degli eventi, ne elabora le vette apicali rianimando il sé nel compiere il risveglio del significato delle cose, accingendosi di volta in volta a dar forma a una coscienza che non resti isolata e che si configuri in un inaspettato allontanamento da qualsiasi pallida illusione, quanto da pur stravaganti sostituzioni. È, dunque, una coscienza rinnovata a sollecitare il poeta quando il sipario del giorno si alza[10] e turbato e sospeso, viepiù intensifica la parola nelle sue facoltà (l_orrore domina le figure. / testimoniano il vivere del definito. deteriorano la mente con la paura.[11]), sicché il lessico del pensiero pone l’inatteso ordine ad ostacolo di contro alla rigidità di una sostituzione normalizzante e satura. Si tratta, invero, di un modo che permette alla parola poetica di trascendere riverberi astrattistici, immediatamente fruibili e, per ciò detto, instabili, e, di rimando, di farsi ponte di una co-operazione coscienziale che vede il sé districarsi dall’ermeticità dell’Io centrico e disporsi in un’intraprendente visione che – nell’inestinguibilità dei dettagli – procura la stessa impressione di novità davanti allo svolgimento della (…) vita interiore[12]. In questo acuto agire la ridondanza non trova sostegno e nemmeno le immagini ricorrono a lusinghiere strategie per far fronte a quella che è solo futile tempo dell’attesa. A quel tempo la sfida si propone fattiva e non già con un verso di fuga dallo scenario dei pensieri fondativi, quanto nell’inoltrarsi nelle profondità ascose. Qui l’azione dell’esplorare avanza nel vero e, con un gesto privo di didascalie tiranniche, si amplifica oltre la zona arida delle sensibilità rese clandestine da incubi in eccesso [che] accendono la notte[13].
In questi termini, disposta su una diversa traiettoria, la ricerca coscienziale al vedere/vedersi recupera il rituale di un’autonoma e impavida realtà di memoria che dispone l’esistente e il suo dolore, quanto l’esperienza e il suo dolore, in un’esegesi eteromorfa, laddove il conosciuto/conoscibile imbastisce tanto una successione logica dell’uno rispetto all’altro, quanto uno spostamento che prepari a una sostenuta dicibilità, volgendo all’incontro di coscienza tra il poeta riflettente (un sé che si dirama e che mai si acquieta[14]) e il sé molteplice (dentro un vuoto sento la trasformazione mescolo passato / presente rimuovo io voi noi le origini attraverso il chi sono[15]) in un neomorfico rituale che non ignora, né piega a patite certezze (osservo questo mondo altri mondi / penso il pensiero pensante / un personaggio in carne e ossa / in cerca di un autore / sono la forza dirompente del testo / le parole il dramma / sono il teatro nel teatro / la zona di confine tra l’essere e l’apparire[16] – è il sentire possente che pervade il poeta).

Senza furor di sentenza, assistiamo, quindi, allo svolgersi di una poesia che si inarca e si imbarca per ulteriori direzioni senza mai inabissarsi e né disperdersi, senza detenere prevedibili rotte; al contrario, la poesia scorge il suo faro in ogni posizione dalla quale intraprende un percorso pluriforme per mare e per terra e per aria, nell’intersezione espansiva degli ambiti dell’esistere tra i passi e nei tempi che, inattesi, si avvinghiano alla boa del momento mutevole per decidere la direzione, pensandosi e mai ritirandosi (pellegrino per sentieri ammutoliti / sovversivo nel falso movimento[17] – è la straziante confessione).
Gratificato da un lume che permette di accedere alle profondità, il lessico del poeta si raffina nel disporre senso critico al conosciuto, al visto e sentito e rilanciarsi laddove, nella voce della poesia e nel suo «adesso», (…) insorge libero il pensiero nuovo di libertà che parla il plurale / coraggio[18] e nella pluralità delle occasioni la coscienza della parola-verso diviene coscienza del poeta nel suo continuo approdare fedele nel mondo, malgrado dall’incessante ricerca etica quel mondo si mostri (…) artificio insomma non identificabile / disarma la schiettezza non lascia tregua la disabilità visiva / (…)[19]. Nella richiesta tra frange acuminate impercettibili, lo spirito che anima la parola priva di iconoclastiche controindicazioni – che si tratti di improperio o di nevralgico assedio d’abitudine – conferma il bisogno di un ordine non già da intendere nell’impoverimento delle digressioni, quanto nella liberazione dall’estraneità, portando all’apparentamento bergsoniano, e cioè, a una forma di consanguinea contiguità tra materiale e spirituale e che scuote quella che Liuzzi chiama disabilità visiva e che ravvisiamo quale impedimento resistente nella precarietà; quale sospensione elusiva e incatenata. Una mancanza, dunque, alla quale la visualità poetica si pone ad ostacolo e va a scompaginare l’atrofia della concatenazione con un legame di rinforzo silente e burrascoso, ma sempre attuativo, tra quanto dalla parvenza transita per raggiungere un’espressione auto-manifesta, che non prevede accanite sembianze, che non si fa metafora di riconduzione, e che semplicemente è nel ribaltamento frontale, laddove il pensiero di sé risiede nell’allungarsi, sconfinare e restringersi del verso, nell’instillazione di un innovativo codice di evocazione intrepida, non adeguandosi affatto all’etimologia contraffatta di un’estemporaneità al limite del converso (l’impetuoso segno del mistero // scoprire / chiedermi // suscitare risposta[20]). Quel che avviene è l’incastro che (…) nel corpo / nella parola // si trasforma con l’intera sua forza[21]. È, insomma, lo spazio libero nel quale il poeta ripone successive riflessioni di un sé di volta in volta cosciente e distante dall’inconcludente fallacia che, impellente ed ostinata, potenzia un gioco di parti nel territorio della routine del vuoto[22], laddove l’ego meridiano si impone in aspra solitudine.
Segnali di rilevanza si incidono a modalità crescente e nel tempo poetico di Oronzo Liuzzi e non suscita affatto sorpresa l’incedere articolato dalla versatilità del ritmo che investe la tessitura delle parole. Ad esse, alle parole, il poeta assomma una credibilità inarcata verso l’incessante spostamento sintomatico della varietà cognitiva di cui è portavoce la facoltà del pensare senza mai interrompersi. Non è tutto: nel progredire ansante e ponderato, la poesia prende quindi forma di una coscienza di sé mentre lo spazio si riduce fra la mia finestra – dice il poeta – e l_affanno / mentale gli scompone la realtà[23]. Egli osserva e nel frattempo quel che accade rinasce per non irrompere nel vuoto[24].
Senza raggiungere alcun epilogo, dunque, la funzione semiotica della poesia liuzziana staglia un territorio che non si riduce a rappresentare i fatti mondani: se a questo la poesia si fermasse, sarebbe cruciale ritenerne il fallimento, oppure il labirintico asservimento a un’illusoria dimensione; sarebbe l’incorrere incrinato a una speranza aleatoria, quanto retorica. Non v’è dubbio, al contrario, che l’ergonomia semantica rimandi alla sommessa preghiera di una coscienza persistente nelle corrispondenze tra le sensazioni colte dalle vicende mondane e non solo: la coscienza con la quale il poeta mantiene il fitto dialogo si alimenta di corrispondenze viventi nell’articolazione di tutte le facoltà del vedere, camminare, toccare, ascoltare, dire, mondare, fino al ritenere e spingere nella verticalità di una meditazione che riunisce tutte le arti disponibili e che quindi – nel privilegio di un’espressione di tipo baudelairiano – declina le movenze, i picchi, le cromie, le intemperanze, gli intervalli, i pieni e le anti-cromie in un sussulto che si distanzia dalle artificiali grazie sclerotizzate in un labirinto difforme. D’altronde, in una maniera attesa nuovamente al senso-verso del pensiero baudelairiano, il panorama poetico di Oronzo Liuzzi declina la spiritualità in un crescendo verticale che, nel trasformarsi, non esula dal rapportarsi a una materia depurata da qualsiasi appesantimento liturgico e della quale ravvisa l’incauto e l’effimero. Qui pure avviene il rinnovamento estetico; qui, ancora, la cosciente compresenza di un territorio individuale di sensazioni e idee, senza alcuna stanca esitazione, si scopre quale poetica di ritorno e nella scrittura forgia una spiritualità tutt’altro che foriera di dispersivo incanto.
Bibliografia
O. Liuzzi, Io e Caravaggio, SECOP Edizioni, Corato (Ba), 2010
O. Liuzzi, In Odissea visione, puntoacapo Editrice, Novi Ligure (Al), 2012
O. Liuzzi, E mentre l’arte …, CFR Edizioni, Piateda (SO), 2014
O. Liuzzi, Condivido, puntoacapo Editrice, Novi Ligure (Al), 2014
O. Liuzzi e R. Bucci, DNA, Eureka Edizioni, Corato (Ba), 2015
O. Liuzzi, Lettera dal mare, Oèdipus, Solofra (Av), 2018
O. Liuzzi, Mutomutas, Musicaos Editore, Neviano (Le), 2020
O. Liuzzi, Non Stop (Poesie 1970 – 2020), Musicaos Editore, Neviano (Le), 2021
O. Liuzzi, da Un giorno adesso, Transeuropa, Massa, 2023
A. Branca (a cura di), H. Bergson – Il possibile e il reale, AlboVersorio, Milano, 2014
[1] O. Liuzzi, 12, «E mentre l’arte …», CFR Edizioni, Piateda (So), 2014, p. 32
[2] O. Liuzzi, XV, «Un giorno adesso», Transeuropa, Massa, 2023, p. 19
[3] O. Liuzzi, 12, «E mentre l’arte …», op. cit., p. 32
[4] O. Liuzzi, La vita si incontra (per Diego De Silva), «Condivido», puntoacapo Editrice, Novi Ligure (Al), 2014, p. 50
[5] Ibi, «E mentre l’arte …», op. cit., p. 46
[6] O. Liuzzi, La vita si incontra (per Diego De Silva), «Condivido», op. cit., p. 47
[7] Ibi, p. 51
[8] Ibi, p. 57
[9] O. Liuzzi, L «Un giorno adesso», op. cit., p. 54
[10] O. Liuzzi, 5., «In Odissea visione», puntoacapo Editrice, Novi Ligure (Al), 2012, p. 11
[11] Ibi
[12] H. Bergson, Il possibile e il reale – Saggio pubblicato nella rivista svedese «Nordisk Tidskrift» nel novembre 1930, a cura di A. Branca, AlboVersorio, Milano, 2014, p. 12
[13] O. Liuzzi, LIV, «Un giorno adesso», op. cit., p. 58
[14] O. Liuzzi, LI, ibi, p. 55
[15] Ibi
[16] O. Liuzzi, 24, «Mutomutas», Musicaos Editore, Neviano (Le), 2020, p. 91
[17] Ibi, p. 92
[18] O. Liuzzi, III, «Un giorno adesso», op. cit., P. 7
[19] O. Liuzzi, XI, IBI, p. 15
[20] O. Liuzzi, 6., «E mentre l’arte …», op. cit., p. 18
[21] Ibi, p. 19
[22] O. Liuzzi, 3., «Mutomutas», op. cit., p. 16
[23] O. Liuzzi, PENSIERI IN_TRANSITO_9, «PENSIERI IN_TRANSITO» (2006) in Raccolta «Non Stop», cit., p. 70
[24] O. Liuzzi, 7., «In Odissea visione», op. cit., p. 13
Questo testo viene pubblicato nella sezione “Rivista Nuova Euterpe” del sito “Blog Letteratura e Cultura” perché selezionato dalla Redazione della Rivista “Nuova Euterpe”, n°02/2024. L’autrice ha autorizzato alla pubblicazione senza nulla avere a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro.