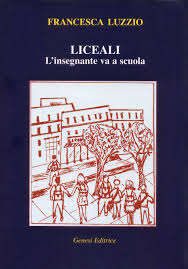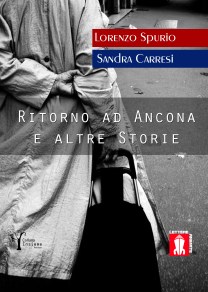L’OPOSSUM NELL’ARMADIO
PoetiKanten Edizioni (2015)
di Lorenzo Spurio

“Tutti abbiamo una vita interiore. Tutti sentiamo di far parte del mondo e nello stesso tempo di esserne esiliati. Bruciamo tutti nel fuoco delle nostre esistenze. Abbiamo bisogno di parole per esprimere ció che abbiamo dentro.” (P. Auster) e Spurio riesce a fissare ogni parola dei suoi racconti sulla pagina, in un miraggio, in un dubbio, in un grano di luce, nei cuori appassiti, nei silenzi del tempo, tra le spume del mare e negli sbuffi di vento per comunicare ciò che hanno dentro i personaggi delle sue scritture che altro non sono che lo specchio letterario di quelle persone in cui incontriamo noi stessi. Se ne “La cucina arancione” la dominante cromatica erano i due colori primari, il giallo e il rosso, mescolati insieme a formare l’arancione, in questa nuova fatica letteraria, “L’opossum nell’armadio”, la dominante cromatica è il bianco. Il bianco è dato dalla somma convenzionale di tutti i colori dell’iride, ma in esso tutti i colori scompaiono perché tale colore è un muro di silenzio, un non-suono, è la pausa tra una battuta e l’altra di un’esecuzione musicale che preclude ad altri suoni. Il bianco è uniforme e immobile, ma sa addolcire i dissidi di una vita difficile; resta pur sempre un topos pauroso, incognito, vuoto, indefinito, ambiguo, rifugio anche del proprio doppio mostruoso. Colore che spaventa gli artisti perché crea l’angoscia della pagina e della tela vuota, una superficie in attesa di un segno, di una parola, di un colore. I poeti futuristi usarono gli spazi bianchi in maniera forte e visiva per dare maggior rilievo alle analogie mentre per i poeti ermetici gli spazi bianchi rappresentavano pause lunghe, attesa, silenzio. Nelle arti visive il rapporto tra vuoti e pieni crea tensione e immaginazione, infatti l’uso del chiaroscuro é finalizzato ad inserire le figure nello spazio; in letteratura il vuoto coinvolge chi legge nella narrazione. L’ambiguità del colore bianco è annullamento, quiete, riposo dall’infelicitá e precorre le maggiori opere della letteratura fantastica per cui il contrasto che si nota in una certa letteratura “perturbante” non è il bianco opposto al nero, che è un non-colore, ma che fa risaltare qualsiasi colore, ma è il bianco opposto al rosso che è il colore del sangue, figure al contempo di contenuto e di significato, rintracciabili nelle opere di M. Shelley, B. Stoker, J. Verne, E. Melville. Nell’antichità classica la bellezza era Leukos e Omero ci dice che bianche erano le braccia di Nausicaa; ma candido è anche l’abito delle spose e quello dei comunicandi; di un bianco mortale sono gli spettri, il viso e la camicia dei condannati, le solitudini glaciali e il freddo, i denti del vampiro, la pelle della balena bianca, ed anche la dentatura dell’opossum che ha denti acuminati e taglienti. Chi ama il bianco tende al fatalismo, ma non per questo è privo di idee creative e sa andare oltre il visibile. Come ho già detto, a dominare il testo di Spurio è proprio il colore bianco, dalla copertina a quelle pagine interne che fanno da spartiacque tra un racconto e l’altro , fogli bianchi a creare suspance, pausa, attesa e dove la definizione scientifica del piccolo marsupiale, l’opossum, fa da contraltare e da nota introduttiva al titolo di ogni singolo racconto. Nella narrazione il bianco è per lo più alluso, evocato e soltanto poche volte nominato come nel caso della rosa bianca, delle particole dell’ostia, della velina dei confetti, delle foto in bianco e nero… La stessa copertina è uno spazio bianco, una distesa di ghiacciai millenari, le cime innevate, una maschera veneziana, il vestito di Pulcinella e il viso di Pierrot. È anche una pagina bianca, una tela bianca su cui sono caduti i segni grafici del titolo a significare una specie di archetipo dell’assoluto, lo spazio labile ed evanescente della mente su cui si è posato il tratto grafico di un armadio in stile antico, stilizzato nelle linee, ma angosciante per i rimandi di senso; un disegno preparatorio di un quadro più ampio, allusivo, ad indicare un ingresso verso l’ignoto, il vuoto, il niente, l’illusione e l’oblio che è la mente umana. Ma è anche un richiamo ineludibile alla lettura che essa offre e riesce a mediare. Il significato intrinseco delle diverse definizioni scientifiche dell’opossum si palesa solo a posteriori con epifanie intuitive, manifeste ad una seconda lettura veramente analitica, successiva ad un primo approccio che si appoggia alla globalità della narrazione. Ogni citazione trova posto in cima alla pagina un maniera da lasciare vuoto lo spazio bianco per creare attesa e dare modo al lettore di annotare le proprie impressioni e creare un sunto introduttivo delle caratteristiche di ciascun personaggio coinvolto nella storia e completamento del titolo stesso. Quelle che Spurio enuncia sono come proporzioni matematiche del tipo 36:9 = 24:x e in cui esiste sempre un’incognita da risolvere e ciascuna caratteristica del marsupiale si rivela non solo in linea col titolo del racconto, ma ambedue si annullano e si completano a vicenda in una circolarità temporale. Ed ecco allora che la coda prensile rimanda alla corda con cui il povero Saverio pone fine alla propria vita, è un animale che patisce la luce sta a comportamenti e fatti che non avvengono alla luce del sole e sono attuati da animi scuri, è un animale opportunista rimanda al cinismo del protagonista che da bravo giovane qual era, divine un approfittatore senza scrupoli. Ancor prima dei racconti Spurio colloca citazioni letterarie a lasciar presagire le tematiche del testo: “… non avrei potuto chiederlo a qualcun altro perché dopo tutto era sangue mio” e “Il manicomio è pieno di fiori, ma nessuno riesce a vederli” sono i periodi estrapolati dalle opere di J Laughlin e M. Tobino. Quindi sangue e mente, le due essenzialità dell’essere umano , quali argomenti introduttivi e “nervatura psicologica dei personaggi”; quindi il colore del sangue, il rosso, e quello della mente, il bianco, a delineare i contenuti di un testo che si configura come una sorta di diario, scritto non dall’autore, ma dagli stessi protagonisti-persone “apparentemente slegati fra loro, ma uniti da un senso esistenziale” all’interno di quel manicomio chiamato vita. “A volte cade un nome in questo spaventoso deserto, e ogni granello di sabbia fiorisce” (E, Canetti). “Recuperare le strutture di significato, il segno cifrato dell’angoscia e dell’invisibile e dell’oltre realtà che ci circonda”(E. Borgna) richiede di attenzionare gli orizzonti tematici di ombre, contraddizioni, antinomie, speranza, disperazione, possibilià, impossibilità, angosce. deliri, naufragi, trionfi.
L’uomo inserito nei rapporti con la comunità diviene consapevole della sua persona, della propria coscienza e della propria intimità per cui la solitudine come scelta personale e come libertà di scelta nei confronti di certe situazioni, smorza il sopraggiungere del disagio e favorisce la riflessione. L’angoscia è corrosiva e spesso è la solitudine che innesca comportamenti devianti ed è sempre la solitudine come lontananza e separazione dagli altri a portare solitudine interiore in cui tutto si riflette in modi ambigui e abbaglianti da cui si liberano sofferenze acute e dolorose. Ma anche”solitudine di nascondimento e come difesa dalle angosce e dalle aggressività spietate e opache”(E.Borgna). “… fuggi nella tua solitudine! Io ti vedo assordato dalla fracasso dei grandi uomini e punzecchiato dal fracasso degli uomini piccoli” sono le parole di F. Nietzsche a dire la propria condizione. Nell’isolamento l’individuo fa esperienza di vuoto che tende a riempire con forme esistenziali effimere e prive di senso. “La solitudine e l’isolamento come metafore dell’ansia. Nella solitudine il tempo interiore scorre nella sua tensione di passato, presente e futuro, nell’isolamento si frantuma e passato, presente e futuro si rincorrono inutilmente”.(E.Borgna). “Sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: il presente del passato che è memoria, il presente del presente che è visione e il presente del futuro che è attesa” dice S. Agostino. Ma nel nelle vicende dell’esistenza e nel linguaggio delle cose, l’ansia, che fa parte della vita, può far emergere possibilità nascoste e nuove negli individui che presentano sintomi di tal genere anche perchè “la sensibilità e l’intelligenza sono molto più alte e questo accresce la sofferenza”(E.Borgna) e conducono ad uno Stimmung (stato d’animo) in cui “Quando tu fissi Medusa, è lei che fa di te quello specchio dove,trasformandoti in pietra, ella guarda la sua orribile faccia e riconosce se stessa nel doppio, nel fantasma che tu sei diventato dopo aver affrontato il tuo occhio”. (J.P. Vernaut). Nel testo di Spurio ci sono le tante persone “lontane dal rumore della terra e dal silenzio del cielo”(F. Pessoa), ci sono i vagabondi dell’anima, i reitti, i derelitti, ci sono quelle fasce sociali emarginate a cui non si dà spazio in un programma di aiuto e reinserimento nel tessuto etico-sociale. Si potrebbe anche eccepire, dicendo cosa ha che vedere il discorso sull’ansia, se quella che si nota nei racconti è una gamma di comportamenti per lo più dettata da veri e propri istinti. Però c’è da dire che l’istinto, che deriva dal verbo “eccitare”, è la spinta ad agire in un determinato modo, è un impulso, un’esigenza naturale senza l’intervento del ragionamento e che determina le conseguenti reazioni. “La contemplazione del tempo è la chiave della vita umana. È il mistero irriducibile sul quale nessuna scienza fa presa”(S.Weil) e sono “Le esperienze letterarie come quelle artistiche (che) ci fanno cogliere immagini diverse e radicali dell’ansia e dei modi di viverla… e le esperienze poetiche e narrative ci consentono di viverle come condivise e come vissute da altri in una circolarità che oltrepassa la distanza del tempo e dello spazio”(E.Borgna). “Nella casa tutto rimaneva fermo ai tempi andati (e) l’olio si guastò dentro quei silos di acciaio” (da racconto Livello –1). L’immobilità del tempo che si protrae nel piano sotterraneo, ovvero nel livello –1, in cui la famiglia aveva riposto sempre cianfrusaglie; la fissità del tempo del vecchio pentolame di rame che contrasta con oggetti della modernità; lo stereotipo del tempo che rende indifferenti al dramma interiore, vissuto da Saverio allorché è costretto a licenziare del personale; l’inesorabilità del tempo che esplode nella violenza delle immagini che Manolo è costretto a vedere; la crudeltà del tempo che innesca una certa insensibilità nell’animo di Mariuccia che “pianse qualche giorno, ma poi tutto tornò come prima; le fauci spalancate del tempo “in (quella) cantina (dove) i vetri infranti non vennero rimossi e nessuno vi si recò più”. “Quando la cattiveria trova validi alleati, allora si è spacciati” e Valentina si ritrova a dove subire tormenti e offese con momenti di esclusione e profonda solitudine perché “era bastato un attimo per catapultarla nel mondo infelice delle donne, manipolate dai vigliacchi inganni degli uomini”. Lei che mai aveva incespicato a causa di quella incoerenza emotiva che contraddistingue gli adolescenti; lei che si era persa a fare una cosa senza pensare e non aveva fatto molta resistenza a Renato, suo coetaneo, che altri non era,se non un “ingannatore seriale; lei che “era stata una conquista maledettamente facile” e adesso vedeva le sue foto sui cellulari degli altri compagni; lei che aveva provato grande vergogna, ma che poi era tornata a rinascere proprio come l’Araba Fenice. (dal racconto Un paio di scatti). ”… e col ricavato me ne andai con i miei amici a Forte dei Marmi. Non riuscii a bagnarmi in quell’acqua, sapendo che la diffusione della nonna ormai era completa e che abitava ogni parte dle pianeta”. In questo racconto, Dal fiume al mare, Spurio più che trattare il tema della morte, tratta quello della sepoltura; ne “La cucina arancione” lo fa con ironia e una punta di scetticismo, parlando dell’ibernazione, ma qui affronta quello della cremazione ed il protagonista pur non avendo verso di lei un affetto profondo per “una questione di intenti taciuti, di messaggi empatici, (per) un sapersi guardare negli occhi e accettarsi per come siamo” si costruisce come persona che dimostra pietà e compassione per la nonna defunta e si distingue per “un qualcosa di indignato” verso le cugine che per mancata accortezza fanno scivolare l’urna e spargere la cenere sui tappetini dell’auto. (dal racconto Dal fiume al mare).
La definizione dello yapok acquatico richiama l’acqua, sia essa di fiume che di mare; l’uno come metafora della vita che scorre e l’altro come simbolo della vita nel suo ritmo immutabile, ma anche di nutrimento, di maternità, di misteriosità dell’animo e desiderio di entrare in contatto con le proprie emozioni. “ Di là del finestrino sfilava un mare scuro e fisso, difficile da comprendere del tutto. Alla mente non affioravano ricordi e quell’acqua oleosa sembrava pretendere alla mia coscienza una condanna spaventosa: l’annegamento”. Studente in medicina, il protagonista del racconto Due o nessuna, si impegna in ogni modo a trovare un rimedio efficace per il “riavvio del sistema cognitivo” della propria madre che ha perso la memoria, “nostra coscienza e nostra ragione”, e poi, preso dallo sconforto, la asfissia col gas, tenta egli stesso il suicidio e alla fine, pur non ricordando più nulla, cerca di “far capire al mondo che (mia) sua madre era già morta da tempo e che (io) lui non (sono) è un assassino” “ Mi ero ribellato. Qualcosa dentro di me aveva deciso di mettere fine alle caricature del mio compleanno.” E il ragazzo di buona famiglia, dalla reputazione immacolata, si defila, cerca degli escamotage per negarsi ai parenti, diviene insofferente, se ne va a vivere per conto suo e proprio mentre girovaga alla ricerca della “calma interiore” si scopre “quale animale opportunista” verso le “seducenti professioniste del lavoro più antico del mondo” mentre egli stesso le ricompensava adeguatamente. Così, per propria convenienza, convince la ragazza a “continuare il suo lavoro” cosa che a lei “sembrò una buona idea” senza minimamente pensare che “aveva solo cambiato città e padrone” mentre lui, l’uomo dabbene, lascia gli studi universitari, si trova un lavoretto e passa le ore a casa a sorseggiare birra, “visto che il buon stipendio di Klara consente (loro) di vivere agiatamente”. (da L’ultimo compleanno). “A sedici anni aveva già letto più di quaranta romanzi e non sapeva chi fosse sua madre”. La sua era una vita monotona, triste, solitaria, talmente immutabile e vuota che un giorno che arrivò persino ad immaginare che dietro al bancone del bar a servire la Coca Cola non ci fosse una vecchia arcigna, ma Luana, la bella ragazza, con la quale poteva parlare e confidarsi. Certo quella era soltanto una visione “smelancolata” come le circonferenze che cercava di tracciare a mano libera e “Le due valigie”, lasciate in eredità dalla nonna in cui si aspettava di trovare una cospicuo vitalizio che permettesse a lui e al padre di condurre una vita più rilassata. Continuò comunque gli studi e all’università non scoprì “una legge sulle circonferenze smelangolate”, ma dalla letteratura imparò molto di più. “La vita è ciò che immaginiamo in essa”, dice F. Pessoa, e Spurio non dimentica di trattare l’inquietudine e il disagio in modo partecipe e accessibile per veicolare temi e contenuti quantomai attuali e lo fa con grande maestria senza mai perdere di vista il piglio felice della propria scrittura. All’interno dei dialoghi narrativi di questa silloge, “dal taglio leggermente più intimista”, non ci sono i vari Franknstein, i Dracula, le Moby Dick, le ballate dei vecchi marinai, gli spettri luminosi e neppure il gusto per l’orrido, ma tali stralci di contenuto appaiono sotto forma di ansia, solitudine, abbandono, pazzia, indifferenza, distanza, cattiveria, cinismo, violenza di genere, erotismo, sfruttamento, atti di carattere che sfociano in equilibri fugaci, tradimenti, pedofilia, suicidio, disagio giovanile, vulnerabilità, isolamento e conflitto interiore. Attraverso la connaturata sensibilità e l’attenzione alle problematiche sociali, l’autore delinea un quadro autentico del dinamismo sociale, vero nella stesura dei contenuti che talvolta possono fornire motivo di sconcerto, ma che alla fine si rivelano sempre discreti nella forma didascalica per profonda riflessione in un progetto che non è soltanto narrativo, ma anche scientifico. E non manca nelle parole di Spurio l’attenzione all’ambiente, alle città, ai luoghi, all’ecologia, ai danni ambientali, ai disastri, alle marginalità ed egli ne scrive in maniera sobria, discreta, velata, quasi accennata. Nel racconto “L’ultimo compleanno”, fa muovere i suoi personaggi in una città, associata all’immaginario collettivo per il sisma avvenuto nel corso dell’anno 2009: L’Aquila. L’autore vi richiama l’attenzione per dire che, sì, gli eventi che l’anno investita, sono stati assai disastrosi, ma che ancor più disastroso è stato il terremoto burocratico che non ne ha permesso una vera e propria ricostruzione in un “paese di pozzi, dove sempre si beve l’acqua con la paura che sia avvelenata”(da F.G. Lorca a pag. 93 del testo), “Eppure (ognuno come) l’erica resiste, rimane attaccato alla (propria) terra, sempre e comunque) (dal film Cime tempestose a pag. 45 del testo).
Onorata di questa ulteriore lettura, per richiamare ancora una volta il bianco nella simbologia della neve e in quella del mare e rendere omaggio all’autore per questo nuovo lavoro, “L’oppossum nell’armadio”, testo di grande valore scientifico, letterario e umano, termino con i versi di due poeti del ‘900, suoi conterranei: Paolo Volponi e Franco Scataglini:
“Sono scesi i passeri a branchi/dai calanchi di neve;/si sono posati tutti insieme/sulle peste davanti a casa/come se la tua veste/tenessero per gli orli,/sfrenati nel volo/quasi per una pena nel cuore”.
“Le case sopra un lembo/de scoio, i pini a vento;/ansava il mare,/ el grembo de l’aria in movimento”.
Ad maiora
LUCIA BONANNI
San Piero a Sieve 3 febbraio 2015