A continuazione, dietro proposta e col consenso dell’autore del dramma epico Ingólf Arnarson (Le Mezzelane, 2018), il poeta Emanuele Marcuccio, si dà pubblicazione ad alcuni interventi critici sulla sua opera, rispettivamente i testi presenti nel volume a corredo e ampliamento circa lo studio dell’opera: la prefazione del sottoscritto e la postfazione a cura di Lucia Bonanni. A chiusura si pubblica anche una breve nota d’apprezzamento da parte del poeta e critico letterario prof. Nazario Pardini.

PREFAZIONE – a cura di Lorenzo Spurio
Conosco Emanuele Marcuccio da almeno quattro o cinque anni e nel tempo abbiamo organizzato o collaborato a una serie di attività letterarie. Ho avuto il piacere e l’onore di leggere le sue opere e di dedicarmi alla scrittura critica di recensioni e saggi sulla sua produzione.[1] Il più recente in ordine di tempo è uno studio sui tre volumi di un progetto antologico innovativo di dittici poetici che ha calamitato l’attenzione di un gran numero di intellettuali e la partecipazione di poeti da ogni parte d’Italia.[2]
Tempo fa – per l’esattezza nel 2011 – Marcuccio mi inviò la prima parte di un dramma epico ambientato in Islanda. Conoscendo la sua propensione per una poetica di impronta prettamente classica (con vivi richiami a Leopardi, Pascoli e Carducci) che poi negli anni avrebbe evoluto in un minimalismo asciutto (si veda la silloge Anima di Poesia del 2014), mi stupii non poco dell’opera che aveva prodotto. Andai a casa sua nel 2013, a Palermo, e non mancò di farmi leggere altri pezzi che nel frattempo aveva scritto portando avanti il suo lavoro. Un’opera maestosa, di tutto riguardo.
Già nel 2011, sebbene l’opera non fosse ancora completa, Emanuele Marcuccio mi aveva chiesto di dedicarmi a una nota critica che servisse come prefazione alla sua opera e, data l’amicizia e la stima che nutro per lui, non potei di certo rifiutare. Lessi così con grande attenzione la sua opera. Subito mi tornò in mente il poema epico anglosassone Beowulf (per altro oggetto della mia prima tesi di laurea) ma anche le saghe nordiche, i carmi norreni e, comunque, tutte quelle narrazioni o gesta di matrice epico-cavalleresca tipiche della tradizione germanica pagana.
Già allora scrissi qualcosa sulla sua opera, perché mi sentii particolarmente attratto da quel tipo di versi, sulle reminiscenze di conoscenze maturate nel campo, appunto, della tradizione germanica in letteratura.
Oggi mi sono ritrovato a rileggere l’opera con vivo entusiasmo e curiosità.
Non solo ho potuto completare la lettura delle vicende che hanno tanto impegnato Emanuele, ma ho ritrovato una serie di dettagli fondamentali ai quali precedentemente non avevo dato gran peso. Questo per sottolineare quanto la cesellatura dei versi liberi operata dall’autore, lo studio attento dei caratteri, la descrizione circostanziata e puntuale delle scene, l’esatta orchestrazione degli avvenimenti siano ingredienti tutti concatenati tra loro che dimostrano in maniera assai stupefacente il grande lavoro prodotto da Emanuele. Non solo fine poeta, ma anche studioso della forma, ricercatore del bello, costruttore di una trama frastagliata e avvincente, creatore di un’epopea cavalleresca anacronistica alla nostra letteratura kitsch e improntata al consumo. Marcuccio, sulla spinta di una suggestione profonda verso l’Islanda – terra mai visitata, ma a dir suo vissuta emotivamente tramite apparati storici e documentari – è riuscito a entrare nell’anima di un popolo, a fornircene la trama, a vivificare un periodo storico molto distante dalla nostra contemporaneità. Lo ha fatto senza alcun intento prettamente storico-educativo. Marcuccio si è semplicemente servito di alcuni elementi codificati dalla storia (l’esistenza dell’eroe epico e la sua tradizione, l’avvenimento della cristianizzazione dell’Islanda) per creare una cornice plausibile e congrua nella quale dar compimento alle gesta dei propri personaggi.
Nell’autore c’era anche la volontà di poter ascrivere il suo lavoro a un dato filone o categoria letteraria a partire dalle forme e dalle strutture che lo caratterizzassero. Se inizialmente l’autore definì l’opera poema drammatico, con una maggiore riflessione, e portando esempi concreti di questo genere di opera con le necessarie divergenze dal suo manoscritto, ha pensato che forse la definizione più consona e pregnante – sebbene abbastanza verbosa – fosse quella di dramma epico in versi liberi. L’intenzione era stata quella di privilegiare nella catalogazione in un genere non solo il contenuto (l’epica) ma anche la forma (quella teatrale, appunto, di un dramma). Il problema della definizione in un genere, comunque, è ben poca cosa, dato che sappiamo quanto sia difficile e spesso limitativo ingabbiare un’opera in un’unica categoria. Procedimento che poteva essere fatto nel passato dove l’intelligentia si contraddistingueva per scuole, tendenze, periodi letterari etc., che oggi non risponde più alla consuetudine soprattutto per il fatto che il testo non è quello che l’autore vuole esprimere con esso, ma rappresenta la polifonia di interpretazioni e letture che può ricevere. In questa camaleontica realtà dove è il lettore attento e arguto a “costruire” assieme all’autore, l’artefice della storia, il significato del libro, va da sé che più letture e analisi esso potrà fornire, più sarà valido, universale e ben recepito. Per questo non è errato dire che l’opera di Marcuccio sia anche l’epopea romanzata dell’Islanda o un carme epico, nonché un dramma sociale, un racconto cavalleresco, un romance, una saga e, ancora, una cronaca.
La materia utilizzata da Marcuccio è in parte storica e in parte fantastica, tanto che potremmo dire leggendaria. Sono presenti riferimenti diretti alla cultura popolare norrena come il personaggio del dramma, Ingólf Arnarson[3], condottiero norvegese che appartiene alla leggenda; descrizioni meticolose dell’ecosistema dell’Islanda, il racconto di scene di guerra. Lo scenario di tutto il dramma è l’Islanda della fine del IX sec. d.C. abitata da popolazioni indigene di stirpe germanica, di credenza pagana e prossime alla conversione al cristianesimo, alle quali Marcuccio contrappone i normanni (o vichinghi) ossia gli uomini del nord, i norvegesi che furono grandi colonizzatori del nord Europa, di fede pagana. L’autore inserisce nell’opera anche importanti riferimenti alla colonizzazione e alla conversione dell’Islanda. La studiosa Maria Vittoria Molinari, per spiegare l’affluenza delle rotte dei vichinghi verso l’Islanda, ha osservato: “Quando il re norvegese Haraldr Hárfágr (875 – 945 ca.) cercò di unificare sotto la sua sovranità tutta la Norvegia e di organizzare uno stato autoritario di tipo feudale, sul modello dei regni dell’Europa centro-meridionale, molti norvegesi non accettarono questo sovvertimento e preferirono emigrare in Islanda dove trasferirono le antiche istituzioni e abitudini di vita”[4]. Così, numerose navi presero la rotta dell’Islanda e colonizzarono l’isola. Importante anche l’opera di conversione degli islandesi, popolazione di stirpe germanica da sempre legata a culti di tipo pagano, alla religione cristiana e ai modelli di società di tipo medievale sino ad allora estranei all’area scandinava. La conversione in Islanda si ebbe attorno all’anno 1000 grazie alla decisione dell’assemblea generale, l’Althing. Con la conversione, s’introdusse la lingua latina che, oltre a essere impiegata nei testi liturgici, divenne lingua letteraria. L’opera di Marcuccio non ha nessuna pretesa di carattere storico, archeologico né documentaristico, ma si serve della storia in maniera personale per creare una trama che è e resta fantastica.
La storia che Marcuccio narra è una storia di combattimenti, vendette, condanne a morte. Le spade vengono sguainate molte volte: sia per giurare che per incitare alla lotta. E cosi Sigurdh (che non ha niente a che vedere con Sigurdhr o Sigfrido, eroe della Saga dei Nibelunghi e della Saga dei Volsunghi) anima i vari servitori di Ingólf e riesce a coalizzarli. Assieme sono motivati dalla volontà di privare Ingólf, loro signore, del suo ingente tesoro. Assistiamo cosi a un clamoroso ammutinamento contro il padrone, singolare in un’opera di questo tipo, ma quanto mai avvincente per lo svolgimento della storia.
Il tema del tesoro, si sa, e un topos molto presente nella letteratura epica: si pensi al tesoro sorvegliato dal drago sputa-fiamme nella seconda parte del Beowulf, o al tesoro dei Nibelunghi o, ancora, al tesoro che nell’epica tedesca e custodito da Fáfnir[5]. Nel corso della storia, però, si presentano alcuni imprevisti: Hákon, servitore di Ingólf, consapevole della gravita delle idee di Sigurdh, non tarda a informare il suo padrone. Assistiamo a una prima lotta tra i seguaci di Sigurdh e quelli di Ingólf. Tutto avviene su quella che l’anonimo compositore del Beowulf avrebbe definito “il legno del mare”, ossia su una barca, diretta verso l’Islanda. Raggiunta l’isola di Thule, però, le cose non vanno come Ingólf aveva previsto e seguiranno una serie di peripezie: Sigurdh si innamorerà di una donna indigena promessa però in sposa a uno del posto e Ingólf farà di tutto per ostacolarlo. La vicenda si chiude con un ultimo duello e, come nella migliore tradizione della chanson de geste, il lieto fine è garantito.
Il dramma di Marcuccio tratta con originalità e chiarezza di linguaggio molti topos dell’epica germanica: i riferimenti ai combattimenti, al cozzar di spade, all’importanza della fama e della gloria[6]; l’impiego di prove per testare la valorosità dell’eroe[7]; la credenza e l’invocazione del fato, spesso personificato, il tema del tesoro e il motivo del viaggio in terra straniera. Essendomi occupato di fatalismo germanico[8], devo riconoscere che nell’opera di Marcuccio il destino non è un semplice concetto, un’idea, ma viene caricato di un significato proprio facendo di esso quasi un personaggio. Fato, destino, sorte, fortuna sono concetti che derivano dall’antico inglese wyrd, spesso personificato dalle Norne, che si riferisce a una cultura precristiana, pagana. A tutto ciò Marcuccio aggiunge elementi che rimandano alla conversione dell’Islanda al cristianesimo: la presenza di un monastero e di monaci, l’influenza celtica, la presenza di croci che viene, quindi, a rappresentare una fase successiva di sviluppo politico-sociale-economico della vita dell’Islanda di epoca norrena.
Tuttavia ciò che Marcuccio narra non è solo un racconto epico, è molto di più. È evidente, infatti, la potenza del lirismo, soprattutto in alcuni momenti, come nella scena d’amore tra Sigurdh e Halldóra e, allo stesso tempo, di una certa vicinanza alla cultura popolare con riscontrabili cadenze e dialettismi che rendono particolarmente significativo e vivo il testo, sottolineando quanto sia importante la componente orale nella trasmissione della cultura. L’opera va anche letta, però, come una probabile e ben elaborata cronaca di conversione dal paganesimo al cristianesimo, non forzata, ma fondata, invece, sul libero arbitrio e sulla consapevolezza della validità del nuovo credo.
NOTE
[1] Lorenzo Spurio, Un infaticabile poeta palermitano d’oggi: Emanuele Marcuccio, Photocity, Pozzuoli, 2013.
[2] Lorenzo Spurio, Risonanze empatiche: l’esperienza del “dittico poetico” di Emanuele Marcuccio in AA.VV., Dipthycha 3. Affinità elettive in poesia, su quel foglio di vetro impazzito…, a cura di Emanuele Marcuccio, PoetiKanten, Sesto Fiorentino, 2016, pp. 137-146.
[3] Ingólf Arnarson (moderno “Ingólfur”) è considerato il primo colonizzatore a stabilirsi in Islanda secondo quanto riporta il Landnámabók.
[4] Maria Vittoria Molinari, La filologia germanica, Zanichelli, Bologna, 1987, p. 154.
[5] Fáfnir è un personaggio importante della mitologia norrena, solitamente raffigurato come drago, ma a volte come un serpente. Le sue vicende sono narrate nella Saga dei Volsunghi dove il drago è custode di un vasto tesoro e viene sconfitto da Sigfrido per mezzo della gloriosa spada Gram. L’eroe mangia il cuore del drago ottenendo la sapienza delle lingue degli animali e poi s’immerge nel suo sangue ottenendo l’invulnerabilità su tutto il corpo tranne in un punto della spalla dove, durante l’immersione, gli si è posata una foglia.
[6] Nel Beowulf e negli altri poemi epici citati la fama dell’eroe è un aspetto estremamente importante che viene richiamato molto spesso. L’idea è che il coraggio, la fama e il valore sono ancor più importanti della morte e, a differenza del corpo dell’eroe, la fama non muore quando lui perisce. Nella Hávamal, composizione di carmi eddici in poesia, a un certo punto viene infatti detto: «Muoiono le mandrie, muoiono i parenti, morirai tu stesso allo stesso modo. Ma la fama non muore per chi se ne è fatta una buona» (in Hávamál, in L’Edda-Carmi Norreni, Introduzione, Traduzione e Commento di Carlo Alberto Mastrelli, Prefazione di Raffaele Pettazzoni, Sansoni, Firenze, 1951, vv. 305-08, pag. 21). Nei primi versi del dramma di Marcuccio, Sigurdh incita Ari a unirsi a lui nell’impresa di sottrarre il tesoro a Ingólf e dice: «Pensa alla gloria, alla fama/ che avremo, partecipa con noi» (vv. 161-162, atto I, sc. I).
[7] Nella Saga dei Nibelunghi viene raccontato che Gunther, fratello di Crimilde, s’innamora di Brunilde, regina d’Islanda e che per poterla sposare deve superare tre prove alle quali viene sottoposto. Per mezzo del cappuccio magico Sigfrido aiuta l’amico a superare le prove con l’inganno e cosi Gunther riesce a sposare Brunilde. Le prove, le gare, intese come prova di coraggio e di resistenza, sono spesso impiegate nell’epica come attestazione del valore dell’eroe.
[8] Lorenzo Spurio, Il concetto di “wyrd” nel poema Beowulf, Universita di Urbino “Carlo Bo”, Facolta di Lingue e Letterature Straniere, Tesi di Laurea, Relatore: Alessandra Molinari, Correlatore: Michael Dallapiazza, a.a. 2007/2008.

POSTFAZIONE – a cura di Lucia Bonanni
Un’introduzione[1] alla drammaturgia dell’Ingólf Arnarson
La linea metodologica, seguita da Fancesco De Sanctis (1817 – 1883) nella propria attività critica, è il concetto di “forma”.
Essa non è intesa come idea astratta, bensì come identità ed essenza dell’opera d’arte. Nel momento in cui l’intuizione lirica investe il poeta, egli ha dinanzi a sé il gene della fantasia creatrice, che in poesia diviene epifania di vita immortale. È in questa fase che nella mente del poeta “nasce un mondo ideale, riconciliato e concorde, ove si acquietano le dissonanze del reale e i dolori della terra”[2].
Ma cosa si deve intendere per espressione drammatica? Con tale accezione lessicale si esprime la passionale attitudine a vedere lo sviluppo delle vicende nei loro urti, nei loro dissidi “e la poesia non è poesia di quelle dissonanze, ma poesia del dolore che quelle dissonanze seminano intorno a sé”[3] mentre l’ispirazione si genera nella pietà per la sfinitezza di chi è vittima delle passioni. Come ben sappiamo, la natura umana è soggetta alla crescita e al cambiamento e nel proprio sviluppo attraversa fasi e conflitti, e i suoi cambiamenti seguono le medesime leggi che regolano l’intero universo. Secondo Lajos Egri (1888 – 1967), scrittore, regista teatrale e didatta di grande fama, in letteratura è il conflitto a rivelare la natura interiore del personaggio, trovando inizio in una decisione che si mostra come logica conseguenza della premessa. La decisione presa dal personaggio principale porta alla decisione del suo antagonista e tali decisioni conducono verso la dimostrazione della premessa.
“Nell’intera drammaturgia moderna forse non esiste un personaggio che “si evolva” in modo più sorprendente della Nora di Ibsen”[4].
Nell’opera letteraria ogni personaggio oscilla tra diversi stati d’animo ed è costretto a modificare il proprio modo di vivere, ad evolversi, a catapultarsi nella maturità e nella ribellione; questo perché i veri personaggi sono delegati a dimostrare la premessa del drammaturgo. Nessun tipo d’azione è il risultato del binomio causa ed effetto in quanto nell’azione in circolarità temporale sono racchiusi movimento ed energia.
Sempre secondo Egri il conflitto può essere suddiviso in quattro categorie: “statico”, “discontinuo”, “crescente”, “adombrato” e si può far risalire sia all’ambiente che alle reali condizioni socio-culturali del soggetto. Allorché l’individuo ha forza interiore per passare all’azione, allora è anche in grado di prendere una decisione. La conseguenza che ne deriva è la pratica del contrattacco che darà il via ad una lunga teoria di eventi. Attraverso le transizioni, o conflitti minori, il personaggio costruisce la propria emancipazione in modo lento, ma sempre costante. E dato che il conflitto diviene inevitabile, quando due opposti si incontrano e si fronteggiano, le caratteristiche principali che costituiscono l’humus comportamentale sono da ricercarsi in: affetto, rozzezza, arroganza, avarizia, precisione, astuzia, abilità, destrezza, onestà, lealtà, misticismo, calma, moralismo, sottomissione, sarcasmo, ferocia, riservatezza, tradimento, vendetta, sensibilità.
Con la locuzione “personaggio cardine” Egri intende il protagonista che è “la persona alla guida di un movimento o di una causa”[5] per cui l’antagonista o avversario è chi si oppone al protagonista. Il personaggio cardine, però, non è soltanto il protagonista, ma è anche il soggetto che dà origine al conflitto e favorisce lo sviluppo del dramma. “Un personaggio cardine è una forza-guida, ma non perché abbia deciso di esserlo. Egli diventa ciò che è per il semplice motivo che qualche forza interiore o esteriore lo costringe ad agire”[6]. Il motore di tale agire è sempre l’onore, il denaro, la vendetta, la salute, la protezione, la passione per cui sia i personaggi “positivi” che quelli “negativi” provocano un tipo di reazione che determina la responsabilità del conflitto e la conseguente necessità della transizione. Come già enunciato, l’antagonista è colui che si oppone al protagonista, lo frena, lo ostacola e cerca di esercitare dominio e razionalità contro la forza e l’astuzia usate dal protagonista. Di primaria importanza nella stesura di un dramma è la corretta orchestrazione dei personaggi in quanto essa è uno dei fattori che genera il conflitto crescente. Pertanto è necessario che i personaggi non siano dello stesso tipo altrimenti “sarà come avere un’orchestra composta solo di tamburi”[7]. Quindi è necessario che l’orchestrazione sia determinata da personaggi opposti e ben delineati, in grado di passare da un estremo all’altro mediante il conflitto e non scendere a compromessi. Le forze che il drammaturgo schiera in campo, possono essere individuali o di gruppo, ma il movimento deve sempre creare dei contrasti nella dinamica del dramma. Inoltre dalla vera unità degli opposti non scaturisce la possibilità di un compromesso in quanto gli opposti sono legati in maniera da annullarsi a vicenda per poter sopravvivere. Infatti “[l]’unità tra gli opposti dev’essere così forte da far sì che si possa arrivare a una risoluzione solo se uno o entrambi gli avversari sono esausti, sconfitti o completamente annientati”[8].
Ritornando alla premessa, parte che racchiude personaggio, conflitto e risoluzione, bisogna dire che per scrivere un’opera letteraria è sempre necessario un “obiettivo” a cui attenersi e che può essere anche detto: tema, idea centrale, tesi, soggetto, piano, intreccio mentre la premessa si configura come “un’affermazione postulata o provata precedentemente; la base di una discussione. Un’affermazione enunciata o assunta, in quanto in grado di condurre a una conclusione”[9]. In un dramma dalla struttura ben organizzata occorre che il limite tra la fine della premessa e l’inizio della storia debba essere sottile e mai svelato in modo da catturare la curiosità e l’attenzione dei lettori/spettatori. “«[N]essuna parte è più importante del tutto!»”[10] gridò Rodin agli studenti atterriti, quando con un netto e preciso colpo di scure tagliò le mani della statua di Balzac che aveva appena terminato. Da questo aneddoto si evince che nessuna parte di un’opera d’arte vive di vita propria, ma tutto vive in costruzione armonica. C’è da aggiungere che per uno sviluppo corretto del dramma è necessario avere ben chiaro in cosa consiste la tridimensionalità di ciascun personaggio: fisiologia, sociologia, psicologia e cioè aspetto fisico, ambiente, ereditarietà e persona. Quindi per meglio comprendere le leggi che governano le manifestazioni comportamentali di ciascun individuo, si rende necessario porre la giusta attenzione alle motivazioni profonde che lo inducono ad agire e che il drammaturgo deve saper prendere in esame per poter comporre quella che è la struttura di base di ciascun personaggio tridimensionale.
Secondo gli antichi Greci la dialettica, conversazione o dialogo, era scandita in tre passaggi principali: tesi, antitesi, sintesi, che ancora determinano la universalità delle leggi su cui si basa la dialettica. Come scrive Hegel, “[u]na cosa si muove, acquista impulso e attività solo perché contiene in sé una contraddizione. È questo il processo del movimento e dello sviluppo”[11].
Ma in un’opera teatrale quando è il momento giusto per alzare il sipario? A quale scena affidare il punto d’attacco?
«[I]n ogni opera che si possa definire dramma, il sipario si alza quando almeno uno dei personaggi ha raggiunto un punto di svolta nella propria vita»[12].
Quello che delinea Marcuccio nel suo dramma in versi, è un valido e imponente punto d’attacco che fin dall’inizio lascia intendere che la tensione sviluppata dai personaggi è in grado di adombrare il conflitto, dato che la posta in gioco che si annuncia è un qualcosa di non confutabile, vero e vitale. Egri afferma che “[i]l dialogo deve far luce sui personaggi. Ogni discorso dovrebbe essere il prodotto delle tre dimensioni di chi lo pronuncia e dovrebbe rivelarci chi è, suggerendo come diventerà”[13].
I personaggi scelti e descritti da Marcuccio, sono orchestrati nel loro profilo tridimensionale, commisurati al movimento e forti nell’agire, calati nella categoria di appartenenza e capaci di evolversi fino alla giusta conclusione; il protagonista possiede la medesima forza dell’antagonista e le varie personalità in conflitto giungono sempre allo scontro. Nel dramma del Nostro è Sigurdh il personaggio cardine da cui dipende tutta la vicenda, è lui che si oppone a Ingólf e, se non ci sarebbe stata la figura del nostromo, non sarebbe neppure esistito lo sviluppo del dramma. Come scrive nell’indice dei nomi, l’autore immagina Ingólf come “un uomo maturo, sulla quarantina, [v]ersato nelle lettere, sa leggere e scrivere”, descrive Sigurdh come un “giovane guerriero normanno e marinaio, di appena trent’anni”. Ed è sempre il dialogo ad incidere sulla dimostrazione della premessa perché, nascendo dalle parole dei personaggi, ne mostra il sentire, l’estrazione sociale, la religiosità e i cambiamenti necessari anche in funzione del conflitto. Pertanto i dialoghi stilati dal Nostro sono sempre “di buona qualità, perché [essi sono] la parte del dramma più accessibile al pubblico”[14]. Nella genesi del dramma l’esposizione, anche con l’uso della voce fuori scena, non è elemento avulso dall’intera impalcatura drammatica, ma è parte del tutto, una progressione costante, ininterrotta e continua fino alla conclusione del dramma.
“Veleggia sul vasto mare/ il gran drakàr,/ frange i flutti,/ a prua si apre una via;/ tranquillo avanza verso Thule” (vv. 1-5, prologo).
È il monologo della voce fuori scena ad introdurre il lettore/spettatore verso l’inizio dell’azione scenica e, volendo risalire ai classici greci e latini, si può affermare che la voce fuori scena, presente in più scene del dramma, possa essere identificata con l’autore. Nel Prologo, rivolgendosi ai lettori/spettatori esordisce per svelare l’antefatto, o prequel, ed anticipare il seguito, o sequel, corrispondente all’ordine logico e cronologico del contenuto dell’opera letteraria. Giusto come succedeva nelle arti visive in cui l’artista amava celarsi in uno dei personaggi da lui creati.
“Per il ponte passeggia un uomo/ […]/ un turbamento strano lo assale” (vv. 12, 15).
Bastano già i primi cinque versi e questi ultimi due a far vibrare le corde dell’interiorità per quel contrapporsi tra la quieta armonia regnante nell’ambiente naturale e le collisioni che amareggiano l’uomo dalla “attempata e giovanile età”. Ma il caso, come ben si sa, è sempre in agguato, sparge intorno “aria maligna”, porta tormento e “repentina agitazione”, perseguita e non fa andare avanti.
“Verrà un giorno, sì verrà:/ alla gran materia preziosa/ mi avvicinerò” (vv. 36-38, I, sc. I), “[r]insavisci, disperdi/ l’impresa funesta” (vv. 152-153).
Già si delinea il conflitto, il contrasto, l’alterco, la lotta che il nostromo è pronto ad ingaggiare col colonizzatore per il possesso di un forziere traboccante d’oro e gemme preziose, “un groviglio rovinoso e inestricabile” che tormenta e percuote la mente per brama di potere.
“Pazzo! cosa pensavi di fare?/ Impadronirti del mio oro, /tu, nel tuo agire/ sempre dubbioso e incerto,/ gettarti in un’impresa!” (vv. 513-517, I, sc. IV)
Come appare evidente, le pupille annebbiate dall’ira portano Ingólf a sottovalutare la destrezza di Sigurdh, a non presagire cosa potrà scaturire dalla sua ribellione. Il nostromo, incatenato e controllato a vista dalle guardie, siede al centro di una sala abbellita da un tappeto con figure della mitologia norrena ed un arazzo di pregevole fattura. Il colonizzatore, ormai padrone della scena, lo insulta, lo minaccia, gli prospetta strazio e torture, gli dice che lo impiccherà alla forca più alta non prima di avergli mozzato la testa di netto. A Sigurdh non è dato di reagire col vigore fisico, ma l’odio e la rabbia nel suo animo sono focolaio di rivolta, i suoi occhi simili a braci roventi, sembrano sprizzare scintille mentre le sue parole lanciano fiele al cospetto del suo antagonista.
“Bestia vile, cane maledetto!/ […]/ malnato empio assassino!” (vv. 557, 563)
Da questo momento non esisterà tregua tra i due uomini che saranno avvolti da luce e tenebre, libertà e morte. Incatenato e rinchiuso tra le botti della squallida stiva, nel ricordo pungente Sigurdh rammenta il gesto eroico del proprio padre che per salvarlo dal barbaro vichingo, quando era ancora bambino, gli fece scudo col proprio corpo. Fisiologia, sociologia, e psicologia denotano chi sono i due protagonisti e lasciano presagire cosa e come diventeranno.
Nella scena prima del secondo atto, che si apre dopo l’approdo alla terra del ghiaccio, il personaggio che attua la transizione, è Halldóra, la giovane figlia di Ragnar, capovillaggio di indigeni islandesi. La ragazza, nascosta tra i cespugli, è attratta dalla bellezza del volto di Sigurdh che è subito rapito dal suo candore e mentre “[…] si rincorrono con gli sguardi” (v. 114, II, sc. I), la vasta amenità del paesaggio fa da sfondo al nascente idillio amoroso. Halldóra, oltre che rappresentare annuncio di transizione evolutiva per Sigurdh, e, se vogliamo, anche per lo stesso Ingólf, è anche personaggio cardine nel momento in cui per amore del guerriero normanno si ribella al padre che la vuole sposa di Steinar, giovane guerriero del loro villaggio. E si rivela personaggio cardine anche quando si risolve ad appiccare il fuoco alla casa dove è stata rinchiusa da Björn, capovillaggio e nemico dichiarato di Ragnar, dopo averla rapita con l’aiuto del fedele Vigfús al comando di Ingólf e di un manipolo di uomini assai rozzi e scellerati. Riservatezza, sensibilità, affetto, onestà, e misticismo sono elementi fondanti del carattere della giovane, caratteristiche peculiari che le conferiscono fermezza nel perseguire i propri ideali di donna. È Halldóra ad innescare, se pure un conflitto minore, le ostilità tra sé stessa e il promesso sposo e di conseguenza tra Sigurdh e Steinar.
Però nel fitto della boscaglia, ben consapevole del pericolo, Sigurdh, animato da forte senso di lealtà, salva la vita al suo rivale in amore. L’uomo è stato attaccato da un orso rabbioso ed è ferito alla spalla sinistra e Sigurdh, sorreggendolo, lo conduce al villaggio. “Sei salvo…/ non si ha fortuna/ a insultar/ così la natura” (vv. 127-130, IV, sc. III), “[a]mico… ti ringrazio,/ hai salvato i miei giorni” (vv. 135-136), “[m]a sei ferito… vieni, appoggiati” (v. 142).
E sarà ancora il nostromo a non voler abbandonare Steinar una volta giunti in soccorso della giovane indigena. Quello che si genera tra i due contendenti, è un conflitto statico, mitigato da sentimenti positivi quali altruismo e lealtà che avvalorano e confermano la premessa, la quale possiamo affermare che sia sintetizzata dalla frase: “L’aspra lotta dell’amore per vincere l’odio”.
Aspro e impietoso è il duello a cui giungono Sigurdh e Ingólf, lotta presto interrotta dal colpo a tradimento assestato dal nocchiero, preoccupato per l’incolumità della sua amata. Per il colonizzatore è l’inizio di un lungo e tormentato, ma risolutivo, periodo di transizione; evento annunciato dal suono pacato di una Voce e da un prorompente fascio di luce che lo porteranno ad un radicale cambiamento interiore.
“Perdonami, se puoi…/ perdonatemi…/ mio Dio…” (vv 74-76, V, sc. unica)
Ingólf, ormai monaco, spira nel cortile del monastero, trafitto dalla furia di Sigurdh. L’acredine del conflitto, adombrato e crescente, non somma l’odio e muta la vendetta in profonda pietà. Determinante è il cambiamento interiore che sorprende anche Sigurdh, caduto in ginocchio davanti a quell’emblema di fede e redenzione che ancora non conosce. La calma, il moralismo e la paziente sottomissione del monaco si rivelano agenti sublimanti per l’ira incontrollata di Sigurdh; è la forza-guida del suo avversario ad attuare il dissolvimento delle negatività che incrostano l’animo del nocchiero. Il percorso evolutivo dei due antagonisti vira verso la maturità, passando da un estremo all’altro senza scendere a compromessi, se non con la loro interiorità e la forza necessaria per dare seguito a pensiero e azione. Il ragionare di Halldóra abbracciata a Sigurdh, annuncia la fine di Steinar e quella di Björn, e dichiara il consenso di Ragnar alle nozze.
I personaggi orchestrati dal Nostro, agiscono secondo la necessaria tridimensionalità, sono ben collegati all’ambiente naturale ed al contesto sociale e confluiscono in quella che è detta da Egri “scena obbligatoria”. Nel dramma di Marcuccio tale scena è da rintracciare nella voce fuori scena del quinto atto mentre la struttura drammatica si sviluppa in maniera costante fino a raggiungere il proprio culmine senza, però, togliere intensità alle altre scene dei precedenti atti, interessando al significato intrinseco del dramma.
“D’un tratto/ un varco di cielo/ scolora/ il giorno,/ e si colora di rosso,/ e scie di nuvole/ luminose/ scendono/ come sangue/ sulla terra…” (vv. 99-108)
Da notare che il nostro intento nel redigere questa introduzione alla drammaturgia dell’Ingólf Arnarson di Marcuccio, non è dimostrare l’applicazione delle tecniche che il Nostro ha letto nel citato libro di drammaturgia di Egri. Più che una applicazione, per l’autore è stata una conferma di quello che aveva già applicato, in quanto la sua lettura del testo di Egri risale all’anno 2012. A quell’epoca, come ha dichiarato l’autore, i giochi erano fatti, la trama c’era tutta, fino alla fine (mancava soltanto quel prodigio finale nel cielo, che farà cadere tutti in ginocchio) e c’era solo da aggiustare l’aspetto formale dei versi e completare il quinto atto. Possiamo immaginare invece che Marcuccio sia stato istruito alla drammaturgia attraverso la lettura dei classici del teatro, consacrandosi con la scrittura dell’Ingólf Arnarson anche abile drammaturgo.
NOTE:
[1] Il presente testo, inserito come postfazione al dramma epico di Emanuele Marcuccio, costituisce il penultimo capitolo del saggio monografico inedito di mia stesura sullo stesso dramma, che sarà pubblicato prossimamente.
[2] Mario Olivieri, La letteratura italiana nelle pagine della critica, cit. da Francesco De Sanctis, Saggi critici, Paravia, 1967, p. 642.
[3] Ivi, cit. da Mario Sansone, L’opera poetica di Alessandro Manzoni, p. 651.
[4] Lajos Egri, L’arte della scrittura drammaturgica, trad. Olimpia Medici e Roberto Gagnor, cit. da Archer, Dino Audino, 2010, p. 51.
[5] Lajos Egri, Op. cit., cit., p. 79.
[6] Ivi, p. 80.
[7] Ivi, p. 83.
[8] Ivi, p. 88.
[9] Ivi, cit., p. 14.
[10] Ivi, p. 31.
[11] Ivi, cit., p. 45.
[12] Ivi, p. 129.
[13] Ivi, p. 167.
[14] Lajos Egri, Op. cit., cit. p. 166.

Nota di lettura – a cura di Nazario Pardini
Già abbiamo letto, introdotto o commentato opere e sillogi di Emanuele Marcuccio, mettendone in evidenza la sana scrittura, la puntualità lessicale, la inventività creativa, e la documentazione culturale. In questa nuova avventura letteraria il Nostro si confronta con il genere drammatico: un dramma in poesia. Storia, epicità, fluidità del dettato lirico, habitus, confluenza del pathos dell’autore nella costruzione della psiche e dell’azione dei personaggi. Una vera metamorfosi cristallina che la dice lunga sulle capacità analitico-introspettive dello scrittore. Il panorama islandese, ambientazione della vicenda, ci mette del suo, tramite quadri misteriosi e sfumature di verdi brumosi, nel concretizzare l’azione e l’autonomia dei protagonisti in questione. Un’opera che invita a riflettere sull’uomo, sulle sue debolezze, la sua storia; un messaggio di vita e di libertà che scaturisce da una versificazione sciolta, suadente e convincente, dove la trama si dipana in un climax di forza e visività. Gli stessi cori del dramma, di ispirazione greca, rinunciano in gran parte alla loro storica aulicità per acquisire un linguaggio volutamente semplice, popolare, attuale a vantaggio dell’economia estetica ed etica dell’opera. Ingólf Arnarson. Dramma epico in versi liberi, il titolo della tragedia che si sviluppa su un tracciato di un Prologo e cinque atti.
 Matteo Piergigli (Chiaravalle, AN, 1973) vive a Monte San Vito (AN). Si è diplomato nel 1992, ha fatto quattro anni di vita militare come ufficiale dell’Esercito e dal 1999 è impiegato tecnico presso un’azienda che gestisce il S.S.I. nella provincia di Ancona. Per la poesia ha pubblicato Ritagli (Kimerik, 2015), la raccolta Notos (Aletti, 2016, in un volume contenente le opere di cinque autori), Ritagli 2 (Arduino Sacco, 2016), La densità del vuoto (Samuele, 2019). Nel 2016 e 2017 ha partecipato a due ritiri poetici della Samuele Editore e a vari Laboratori di poesia. Sue opere sono presenti nell’antologia Laboratori di poesia (Samuele, 2017) e sono apparse su vari numeri della rivista di poesia e critica letteraria Euterpe (usciti da luglio 2016 a novembre 2017). Dal 2015 ha ricevuto numerosi riconoscimenti e apprezzamenti in diversi premi letterari.
Matteo Piergigli (Chiaravalle, AN, 1973) vive a Monte San Vito (AN). Si è diplomato nel 1992, ha fatto quattro anni di vita militare come ufficiale dell’Esercito e dal 1999 è impiegato tecnico presso un’azienda che gestisce il S.S.I. nella provincia di Ancona. Per la poesia ha pubblicato Ritagli (Kimerik, 2015), la raccolta Notos (Aletti, 2016, in un volume contenente le opere di cinque autori), Ritagli 2 (Arduino Sacco, 2016), La densità del vuoto (Samuele, 2019). Nel 2016 e 2017 ha partecipato a due ritiri poetici della Samuele Editore e a vari Laboratori di poesia. Sue opere sono presenti nell’antologia Laboratori di poesia (Samuele, 2017) e sono apparse su vari numeri della rivista di poesia e critica letteraria Euterpe (usciti da luglio 2016 a novembre 2017). Dal 2015 ha ricevuto numerosi riconoscimenti e apprezzamenti in diversi premi letterari.


 Simone Magli è nato a Pistoia nel 1984, città nella quale vive. Poeta e aforista, è anche autore di haiku. Durante la sua formazione si è sentito particolarmente attratto dalla poetica di Giuseppe Ungaretti per sentirsi legato poi alla stagione ermetica. Tra i suoi autori prediletti figura anche l’umbro Sandro Penna mentre, tra gli aforisti, riconosce una certa influenza da autori quali Stanislaw Jerzy Lec, in primis e, tra gli italiani, Flaiano, Longanesi, Caramagna, Ansaldi e Castronuovo. Ha pubblicato la silloge La solitudine di certi voli (I.S.R.Pt, 2012). Ha ottenuto vari riconoscimenti in concorsi letterari, soprattutto per la poesia, ma anche per gli aforismi. Nella rubrica Per Competenza diretta dal poeta toscano Roberto Carifi è stato più volte recensito. Note critiche sulla sua produzione sono state stilate anche dai poeti Gilberto Sacerdoti e dalla poetessa fiorentina Mariella Bettarini, fondatrice della nota rivista L’area di Broca. Da novembre 2019 collabora con il blog letterario Lib(e)ro-libro, oltre le parole.
Simone Magli è nato a Pistoia nel 1984, città nella quale vive. Poeta e aforista, è anche autore di haiku. Durante la sua formazione si è sentito particolarmente attratto dalla poetica di Giuseppe Ungaretti per sentirsi legato poi alla stagione ermetica. Tra i suoi autori prediletti figura anche l’umbro Sandro Penna mentre, tra gli aforisti, riconosce una certa influenza da autori quali Stanislaw Jerzy Lec, in primis e, tra gli italiani, Flaiano, Longanesi, Caramagna, Ansaldi e Castronuovo. Ha pubblicato la silloge La solitudine di certi voli (I.S.R.Pt, 2012). Ha ottenuto vari riconoscimenti in concorsi letterari, soprattutto per la poesia, ma anche per gli aforismi. Nella rubrica Per Competenza diretta dal poeta toscano Roberto Carifi è stato più volte recensito. Note critiche sulla sua produzione sono state stilate anche dai poeti Gilberto Sacerdoti e dalla poetessa fiorentina Mariella Bettarini, fondatrice della nota rivista L’area di Broca. Da novembre 2019 collabora con il blog letterario Lib(e)ro-libro, oltre le parole. Non è facile né agevole scrivere qualcosa di perfettamente aderente e giustamente commensurata all’eccelsa qualità di quest’opera cercando di commentarla nella sua esatta dimensione. È chiaro, come ha scritto con competenza il professore Nazario Pardini nella sua dotta prefazione, che si tratta di una Elegia, un componimento letterario improntato a motivi di confessione autobiografica, di delicata mestizia e di forti sentimenti, indipendentemente dalla forma, la quale tuttavia si determina tradizionalmente nel così detto distico elegiaco.
Non è facile né agevole scrivere qualcosa di perfettamente aderente e giustamente commensurata all’eccelsa qualità di quest’opera cercando di commentarla nella sua esatta dimensione. È chiaro, come ha scritto con competenza il professore Nazario Pardini nella sua dotta prefazione, che si tratta di una Elegia, un componimento letterario improntato a motivi di confessione autobiografica, di delicata mestizia e di forti sentimenti, indipendentemente dalla forma, la quale tuttavia si determina tradizionalmente nel così detto distico elegiaco.
 Sabato 18 gennaio alle ore 16 presso Villa Mimbelli a Livorno, nel contesto della XX edizione del noto Premio “Ciampi” indetto dall’omonima Associazione Culturale “Premio Ciampi”, verrà premiato il poeta e artista romano (da decenni ad Amsterdam) Aldo Piromalli – autore dell’irriverente e sdegnata “Affanculo” interpretata al Festival di Castelporziano nel 1979, il Woodstock italiano – segnalato alla commissione dall’artista Dora García.
Sabato 18 gennaio alle ore 16 presso Villa Mimbelli a Livorno, nel contesto della XX edizione del noto Premio “Ciampi” indetto dall’omonima Associazione Culturale “Premio Ciampi”, verrà premiato il poeta e artista romano (da decenni ad Amsterdam) Aldo Piromalli – autore dell’irriverente e sdegnata “Affanculo” interpretata al Festival di Castelporziano nel 1979, il Woodstock italiano – segnalato alla commissione dall’artista Dora García.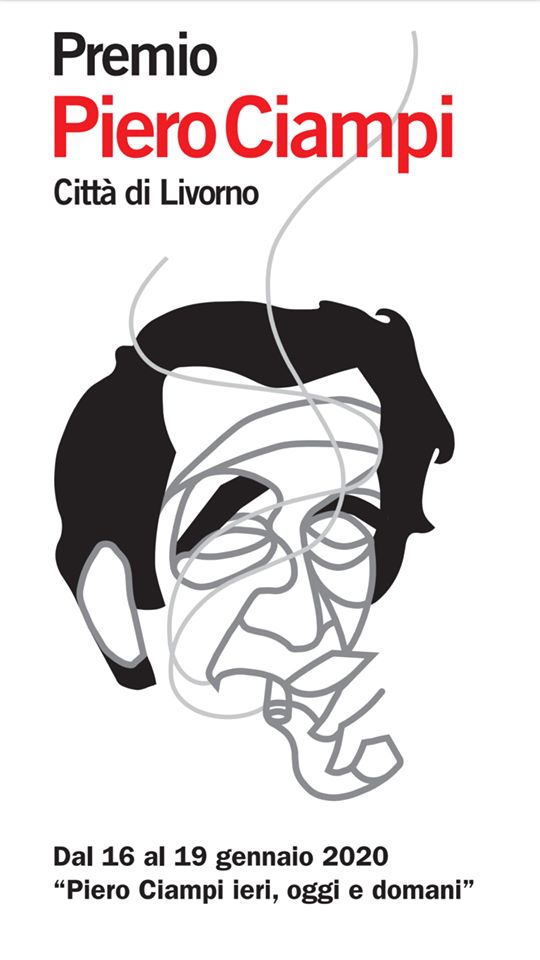


 L’antologia Quinta dimensione (Mondadori, 2018)
L’antologia Quinta dimensione (Mondadori, 2018)



 Particolarmente attento alle dinamiche socio-civiliche interessano il nostro oggi (ma non solo, come vedremo a seguire), Damiano nel corso degli ultimi anni si è imposto nello scenario ampio e variegato dell’universo delle competizioni letterarie quale anima sensibile verso ciò che accade non solo nella realtà di Provincia e nel Belpaese, ma nel mondo tutto, dimostrando capacità di analisi non indifferenti e un sentimento umanitario che lo rende vero cittadino di questo scapestrato mondo. I versi di Damiano non sono mai tesi a denunciare in maniera reproba i mandanti, gli esecutori diretti e chi ordisce il Male e alimenta le violenze, semmai a leggerle con occhio compassionevole e attento, a sottolinearne la gravità, a indagarne le ragioni e, ancora una volta, a solidarizzare con il represso, colui che viene battuto o cacciato. […] Per parlare di questo nuovo libro di Damiano non si può prescindere dai ricchi ed esaustivi apparati critici in apertura e chiusura di cui esso è dotato, brani esegetici che arricchiscono di per sé la caratura del volume e del Poeta di Latina permettendocene una lettura e un approfondimento radicali e persuasivi che ci consentono di avvicinarci all’opera e di gustarla in maniera ancor più saporosa. La poetessa Patrizia Stefanelli dedica pagine particolarmente apprezzabili sottolineando il forte realismo e pregnanza della lirica di Damiano parlando, al contempo, di una “odeporica essenza” (4) che si realizza in quell’intendimento spontaneo atto a esperire la poesia, e la scrittura tutta, come un viaggio. […] Il critico Cinzia Baldazzi, con una gamma variegata di riferimenti a intellettuali a lei amati nei quali ravvisa “consonanze” con alcuni versi di Damiano, si focalizza su un altro aspetto dominante del volume da lei definito nei termini di “cosalità dei significati quotidiani” (108) a intendere quel legame forte e spontaneo, sentito e immanente, che l’uomo ha con l’universo oggettuale che lo circonda, il contesto abitativo e sociale, finanche le pratiche rituali e celebrative che appartengono a quel dato “essere” nell’ hic et nunc.
Particolarmente attento alle dinamiche socio-civiliche interessano il nostro oggi (ma non solo, come vedremo a seguire), Damiano nel corso degli ultimi anni si è imposto nello scenario ampio e variegato dell’universo delle competizioni letterarie quale anima sensibile verso ciò che accade non solo nella realtà di Provincia e nel Belpaese, ma nel mondo tutto, dimostrando capacità di analisi non indifferenti e un sentimento umanitario che lo rende vero cittadino di questo scapestrato mondo. I versi di Damiano non sono mai tesi a denunciare in maniera reproba i mandanti, gli esecutori diretti e chi ordisce il Male e alimenta le violenze, semmai a leggerle con occhio compassionevole e attento, a sottolinearne la gravità, a indagarne le ragioni e, ancora una volta, a solidarizzare con il represso, colui che viene battuto o cacciato. […] Per parlare di questo nuovo libro di Damiano non si può prescindere dai ricchi ed esaustivi apparati critici in apertura e chiusura di cui esso è dotato, brani esegetici che arricchiscono di per sé la caratura del volume e del Poeta di Latina permettendocene una lettura e un approfondimento radicali e persuasivi che ci consentono di avvicinarci all’opera e di gustarla in maniera ancor più saporosa. La poetessa Patrizia Stefanelli dedica pagine particolarmente apprezzabili sottolineando il forte realismo e pregnanza della lirica di Damiano parlando, al contempo, di una “odeporica essenza” (4) che si realizza in quell’intendimento spontaneo atto a esperire la poesia, e la scrittura tutta, come un viaggio. […] Il critico Cinzia Baldazzi, con una gamma variegata di riferimenti a intellettuali a lei amati nei quali ravvisa “consonanze” con alcuni versi di Damiano, si focalizza su un altro aspetto dominante del volume da lei definito nei termini di “cosalità dei significati quotidiani” (108) a intendere quel legame forte e spontaneo, sentito e immanente, che l’uomo ha con l’universo oggettuale che lo circonda, il contesto abitativo e sociale, finanche le pratiche rituali e celebrative che appartengono a quel dato “essere” nell’ hic et nunc. 
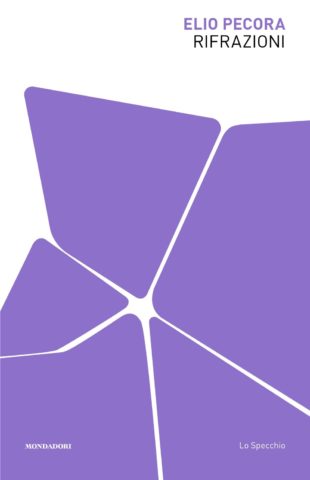 Alla dimensione di una contemporaneità che opprime ed assedia l’io lirico (mai l’autore ne rinnega la voce), funestata da ruberie e delitti, eccidi ed eccessi, guerre che servono a scherani del raggiro seduti a legiferare sulle immondizie
Alla dimensione di una contemporaneità che opprime ed assedia l’io lirico (mai l’autore ne rinnega la voce), funestata da ruberie e delitti, eccidi ed eccessi, guerre che servono a scherani del raggiro seduti a legiferare sulle immondizie



