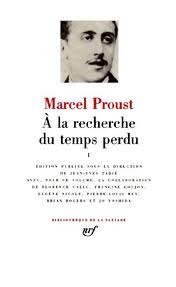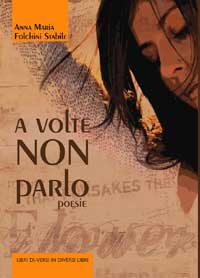Marcel Proust e la sua Recherche del tempo perduto: A’ l’ombre des jeunes filles en fleurs
a cura di Ninnj Di Stefano Busà
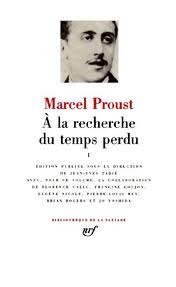 Diciamo subito, che nei primi decenni del Novecento la Francia continua ad avere grande seguito in quel ruolo di guida culturale dell’Europa, che ha già impersonato negli ultimi decenni del secolo precedente. L’autore che ha avuto un ruolo preminente per lo sviluppo delle letterature europeiste, per la validità significante dei suoi risultati, per l’influenza, infine, che avrebbe rappresentato per tutta la narrativa europea è Marcel Proust.
Diciamo subito, che nei primi decenni del Novecento la Francia continua ad avere grande seguito in quel ruolo di guida culturale dell’Europa, che ha già impersonato negli ultimi decenni del secolo precedente. L’autore che ha avuto un ruolo preminente per lo sviluppo delle letterature europeiste, per la validità significante dei suoi risultati, per l’influenza, infine, che avrebbe rappresentato per tutta la narrativa europea è Marcel Proust.
Nato a Parigi nel 1871 da famiglia agiata, ma non ricchissima borghesia. Dopo un’infanzia tormentata da un’asma che lo avrebbe condannato per l’intera esistenza, segue assai irregolarmente gli studi.
Più tardi nel 1880 inizia a frequentare i salotti mondani, ricercato per le sue qualità di fine parlatore, i suoi vezzi da dandy, coi quali contribuisce a creare una certa raffinatezza e attrattiva nei luoghi di frequentazione.
Alla morte della madre alla quale era legatissimo, Proust inizia il grande ciclo narrativo: Alla ricerca del tempo perduto a cui è legata la sua fama.
L’opera è composta da tre parti. La prima parte, rifiutata da Andre Gide, viene respinta dall’editore Gallimard, poi stampata in proprio dall’autore stesso, nel 1913. La seconda: All’ombra delle fanciulle in fiore, presa in esame in questa introduzione, ottiene il premio Goncourt nel 1919.
Successivamente le altre parti vengono pubblicate dopo la sua morte, avvenuta nel 1922. Tutta l’opera comprendente più di tremila pagine, si articola in sette parti e si conclude con una illuminazione che è anche una dichiarazione di poetica: fissare con la creazione artistica i momenti del passato equivale a recuperare il tempo perduto (Il tempo ritrovato).
Pur trattandosi di un’opera estremamente originale, la critica ha indicato per la Recherche alcuni fondamenti culturali della tradizione francese.
Per primo l’entroterra culturale, con una produzione memorialistica e diaristica di tanti autori tra il Seicento e il Settecento che hanno descritto il loro ambiente dal di dentro, con dovizia e ricchezza di dettagli. Proust infatti si mostra molto attento ai costumi del tempo che ne determinano il sapore, il clima, il soggettivismo, le ambientazioni del mondo reale e sociale. La sua attività di scrittore e frequentatore dei salotti-bene di Parigi si snoda nel periodo compreso tra la repressione della Comune di Parigi e gli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale; egli seppe cogliere in pieno, dunque, la trasformazione della società francese del suo tempo, con la crisi dell’aristocrazia e l’ascesa della borghesia durante la Terza Repubblica francese.
Proust ci dà un’approfondita rappresentazione del mondo di allora e della modificazione sociale del periodo storico cui appartengono le sue opere. L’importanza di questo scrittore è tuttavia legata alla capacità espressiva della sua scrittura che si autodetermina e si sviluppa nella sua potenza narrativo-introspettiva, nelle minuziose descrizioni dei processi interiori, attraverso i filamenti sottili di una psiche legata al ricordo e ai sentimenti; la Recherche infatti è un viaggio nel tempo e nella memoria che si snoda tra vizi e virtù, tra realtà e fantasia, tra aristocratiche dissolutezze e simbolismi filosoficamente compiaciuti di un più “nuovo” sentire.
L’indagine analitica sui suoi scritti ci mostra la sua abilità psicologica di meticoloso e vigile indagatore dell’animo umano. Più precisamente, Proust prende in rassegna i sentimenti, le suggestioni, le emozioni attraverso la lente dei moralisti del Seicento francese, fino a giungere al romanzo psicologico di fine Ottocento.
Inoltre nella sua scrittura si riscontra la filosofia di Bergson, con la teorizzazione del tempo interiore, del “tempus”-rivisitatio- visto e indagato nella sua essenza (o veste) di Comedia umana, come durata temporale, e infine, tutte le conquiste della poesia francese di fine ottocento, che avevano portato alla valorizzazione delle “corrispondenze” come egli le definisce, ovvero, dei reconditi rapporti tra gli stati d’animo e la natura, tra l’evocativa, analogica assemblee emotivo/psicologica e le connotazioni naturali del genere umano, che si differenziano in ognuno.
Già Bergson aveva parlato di coscienza interiore, cioè di una coesistenza tra il passato e il presente proprio in riferimento alla caratterizzazione dell’essere. Proust ritiene vi siano due stadi, due gradi di recupero possibile della coscienza e ne distingue soprattutto due: memoria volontaria e memoria spontanea.
La prima richiama tutti i dati del passato, pur se in termini logici, senza restituirci sensazioni, suggestioni, sentimenti che in una determinata circostanza vi appaiono irripetibili; la memoria spontanea (o sensoriale), riferita soltanto a un amarcord dei sensi, si caratterizza come un revival della felicità protetta nell’intimo della psiche: un profumo, un sapore, una musica, un suono, una nota, un tramonto che riportino l’occasionale analogico, ovvero la “casuale” sensazione di un momento cronologico, la qual cosa, sì, ci rituffa nel passato, ma senza riferimento logico: una sorta di <sentire> a distanza ravvicinata, (a pelle), un tentativo di far rivivere impressioni e atmosfere di un tempo andato, di un ricordo sopito o accantonato, (non del tutto rimosso).
È questa la famosa teoria dell’intermittenza del cuore per il recupero memoriale dei sensi, una vera e propria (re)incarnazione della propria identità passata, che diventa sollecitazione dei sensoriale somatico della psiche richiamando in superficie l’invito a ritornare al passato, (apparentemente) tempo perduto, (mai rimosso), che si presenta come un reverie un de ja vu momentaneo, che non ha nulla della cancellazione definitiva di memoria, perché permane dentro di noi, persiste nell’inconscio e, all’occorrenza, riaffiora in superficie, riappropriandosi delle sensazioni provate o delle suggestioni mai dismesse. Proust con le sue opere riprende in mano lo studio della psicologia e la fa rivivere nei suoi romanzi come la trama e l’ordito, che determinarono la vena letteraria del suo repertorio, ma successivamente ne caratterizzarono l’impianto logico, dopo di lui. Si tratta dunque di un recupero memoriale che interpreta la creazione artistica, come coscienza di sé, trattasi di una forma perfettibile (se non perfetta) di realtà che orienta a quel paradiso (perduto), cui fa riferimento il narratore.
Critici che dedicarono molta attenzione a Proust sono stati i nostri: Giacomo De Benedetti, Giovanni Macchia, Pietro Citati, Giovanni Raboni, Franco Fortini.
Quest’ultimo che fu uno dei critici più accreditati agli studi di Proust ritenne che egli proseguisse in un discorso tutt’altro che lineare, senza ordine cronologico normale, né logico, tra passato e presente, in un andirivieni movimentato, a rembour, e con una narrazione che non segue il ritmo usuale, perché questi passaggi o transizioni creano vere sospensioni, ritardi, intervalli, effetti d’eco e variano continuamente, senza assumere precise connotazioni, cronologie e forzature, tra i rapporti umani e gli eventi. Anche se questo suo stile basato sull’altalenante impiego del tempo/spazio, è spesso rivolto al caos di successioni mnemoniche o sensazioni improvvise, si delinea lucido e acuto, votato tuttavia ad evocare un “sentire”, che obbedisce al sapiente gioco delle “rispondenze”, quasi ad un reciproco integrarsi tra un evento e l’altro, tra un velocissimo sguardo e la parola.
In tutta la Recherche s’incrociano vari piani psicologici. In Proust l’interesse si sposta dal personaggio alla dinamica del gioco, dalla coscienza alla psicologia strategica di un processo retrospettivo memoriale quasi yunghiano, su cui si porranno altri analisti del pensiero: Joyce soprattutto e tanta parte della narrativa del Novecento, che si concluderà col famoso flusso di coscienza. Proust ha ricreato il mondo del romanzo dal lato della relatività immaginifica, dando per la prima volta una matrice connotativa alla letteratura di fine secolo; un equivalente teorico della fisica moderna (E. Wilson). In realtà la Recherche è un’opera assai complessa, una straordinaria e suggestiva discesa agli inferi della coscienza dell’essere, che nel riappropriarsi del meccanismo che introduce ai meandri della complessa macchina umana, ne fa una ricognizione dettagliata, una rivelazione in progress, ricreando il romanzo alla maniera di cui, infine, disporrà l’arte narrativa dell’intero Novecento.
Da più parti ci si è chiesto da dove è venuto questo fortunato titolo, molto azzeccato in verità, perchè è divenuto quasi una locuzione proverbiale della sua scrittura. Pare gli sia stato suggerito dall’amico Marcel Plantevignes.
Nella simbologia proustiana, le “fanciulle” costituiscono un perfetto ed esemplare connubio, tra il mondo turbativo degli elementi esterni e “la felicità sconosciuta e pur possibile nella vita”, attraverso di esse si dipana e acquista splendore e turgore quel mondo esemplarmente sognato, facendo scatenare tutto il virtuosismo dialettico e linguistico proustiano: certi luoghi, certi soggetti, certi paesaggi che sono la caratterizzazione delle Fanciulle fanno emergere nel lettore tutta la stupefazione per la Bellezza della natura.
Esse vengono designate di volta in volta come “uno stormo di gabbiani”, “una luminosa cometa”, “una bianca e vaga costellazione”, “un’indistinta e vaga nebulosa”,”una rosea infiorescenza” etc, insistendo sui dettagli, sulle sottili interconnessioni, sui dialoghi, sulle presenze fascinose e sublimi di Albertine, Andrée, Gisele e Rosemonde.
Balbec è il luogo-simbolo, il teatro (per così dire) delle scene che i protagonisti della storia si apprestano ad impersonare, ciascuno per proprio conto, attraverso le tendenze, le stravaganze, i vizi e i difetti delle variegate figure.
Lo stesso scenario “marino” ambienta una rappresentazione di quello che, secondo la tendenza artistica del secolo, costituisce la pittura impressionista.
Credo che queste siano alcune osservazioni che vanno proposte per l’approccio alla lettura de la Recherche.
Proust ha (ri)creato il mondo del romanzo dal lato della –temporalità relativa – , con una ricognizione libertaria e caotica del genere umano e dei suoi meccanismi di difesa (della psiche), entrando nei labirinti dell’animo come nessun’altro narratore, con le proprie frustrazioni, le proprie insicurezze, gli indugi, le complesse manifestazioni edonistiche dell’uomo,
le parvenze rarefatte e sottili della coscienza, soprattutto rivolte alla fisionomia dei personaggi, al loro labirintismo, la qual cosa li porta ad affinare immagini, a evidenziare e metabolizzare circostanze, episodi e avventure, tali da rievocare e portare alla luce ambienti, persone, stati d’animo, profumi, odori e sapori dell’infanzia: un tempo perduto viene così ritrovato; il resto: l’esteriorità minutamente descritta nei dettagli fornisce agganci per comprendere il difficile meccanismo che entra in gioco nella coscienza dell’essere, quando viene fagocitata dall’esterno.
Vi sono pagine mirabili e fondamentali nell’opera di Proust, in cui egli indaga con stile raffinato e insieme con la precisione di un bisturi la capacità di esprimere le più impalpabili, minute e segrete sfumature del genere umano.
Il suggestivo: All’ombra delle fanciulle in fiore è il terzo titolo della raccolta (1919) e ne rappresenta la tappa essenziale, una sorta di riferimento fondamentale di tutta l’opera. In questo volume sono tanti i risvolti psicologici, gli orli, i nodi, le pieghe, le dritte e i rovesci, gl’incantamenti che vi si riscontrano.
Ogni avvenimento è scandito secondo le luci, le ombre, i chiaroscuri, i colori, i ritmi delle ore, una sorta di reverie che sa scatenare, alla luce di una lettura accurata e attenta, tutti i sommovimenti della sapienziale e filosofica struttura linguistica.
In tutta l’opera lo scrittore ci dà mostra di sé, del suo approcciarsi ormai ai livelli di scrittura degli autori considerevoli e professionalmente più preparati, un mondo fin lì sognato, (poterli eguagliare!), quasi desiderio inaccessibile, per l’incrociarsi di eventi e accadimenti che segnano la scrittura dei grandi narratori e ne marcano profondamente la vena.
L’entroterra culturale dell’autore si rivelò in grado di sfondare la cortina di nebbia, tale da segnare la sua identità artistica di narratore come pochi altri. Nessun’altro infatti aveva mai scritto in prima persona quanto Proust. La sua vena risulta assolutamente sterminata nei dettagli, nelle piccole, inafferrabili arguzie dei retroscena umani. Le 4.870 pagine de la Recherche potrebbero bastare a far conoscere l’ampiezza della vasta gamma dei sentimenti che albergano nella psiche.
Proust si rivela immenso, penetrarlo è un’impresa non facile. L’astrattezza dei pensieri, delle immagini viene continuamente mossa da una sorta di circonvoluzione cerebrale, con una trama fitta, ma sottile, che dà ampio respiro alle sensazioni, anche meno significative, ve ne diamo es: “…le ragazzine che avevo scorto procedevano leste, con quella destrezza dei gesti che nasce da una perfetta scioltezza del corpo e da un disprezzo sincero per il resto dell’umanità, procedevano leste, senza esitazione né rigidità, compiendo esattamente i movimenti voluti, in una piena indipendenza reciproca di tutte le membra, mentre la maggior parte del corpo conservava quell’immobilità così notevole nelle buone ballerine di valzer”.
Se letto con calma, All’ombra delle fanciulle in fiore evidenzia tutta la potenza introspettiva e il glamour dell’intero repertorio proustiano, delineandosi come un classico dalle splendide e indimenticabili descrizioni, che il narratore investe di grande humor e più dettagliatamente delineandone le attese dell’alta società francese del suo tempo, avendone individuato spesso le vicissitudini amorose, i gesti, i dialoghi, e interpretandone vizi e virtù. Questo romanzo apre a sfondi metafisici e filosofici finora mai eguagliati. Ad es. la conclusiva descrizione dell’ultimo giorno vacanziero: “il giorno d’estate ch’ella [la domestica] scopriva sembrava altrettanto morto e immemorabile d’una sontuosa e millenaria mummia che la nostra vecchia domestica avesse liberata con cautela da tutte le sue fasce, prima di farla apparire, imbalsamata nella sua veste d’oro”).
Un’opera come poche, allora, che predilige il dipanarsi della narrazione in mille rivoli introspettivi, e appare (ir)rrisolta, per certi aspetti analogici che guardano ai dettagli, ma pur sempre, senza il frammentarismo in cui si può facilmente cadere. Tutto sembra avvenire come quando si osserva un panorama col binocolo, molto ravvicinato o molto distanziato dall’oggetto in esame, oppure, si capovolge l’immagine che diviene altro da sé: la visione allora prende la forma di un caleidoscopio che guarda al puzzle occasionale, alla realtà virtuale e chiude in un corteggiamento tutte le altre forme e, nello stesso tempo, scopre l’impossibilità di trovare la felicità che cerca nell’amore, poiché esso rimane compresso tra i propri limiti e la natura stessa dell’individuo che v’interagisce.
Tutta l’opera è un capolavoro della letteratura francese.
Per Marcel Proust il recupero del passato e la creazione artistica coincidono, si combaciano, fin quasi a colmare la brevità illusoria del tempo, forse anche a recuperarlo, a conservarne aromi e freschezza dentro l’anima che è tutta attraversata dal desiderio della giovinezza fuggitiva, ritenendola parabola stessa della vita, in un percorso di relatività spirituale, ancorché biologico e naturale della specie.
Milano, giugno 2013 Ninnj Di Stefano Busà