“Amore come peccato: la sublimazione dantesca”
saggio di FRANCESCA LUZZIO
L’amore è uno dei temi fondamentali della letteratura di tutti i tempi. Anche nel Medioevo, quando presso la maggior parte delle società del tempo, regna incontrastata una religiosità severa e la donna viene considerata quasi un’espressione demoniaca, non mancano i cantori dell’amore, anzi la civiltà cortese-cavalleresca trova in tale tema la sua essenza, definendo esso una weltanschauung, ossia un determinato modo di intendere e praticare la vita.
 Il teorico per eccellenza dell’amore cortese è Andrea Cappellano, autore del trattato De amore, in cui vengono fissati le norme e i canoni di tale concezione. Nonostante la condanna della chiesa che lo induce a ritrattare nel terzo libro il contenuto dei due precedenti, l’opera ha un enorme successo, permeando profondamente la cultura aristocratica del Medioevo. Se la caratteristica essenziale del cavaliere della chanson de geste è la prodezza, nota essenziale dell’ideale umanità dei cavalieri-poeti , detti trovatori (dal latino tropare: cercare e trovare versi e musica) è la giovinezza alacre e gioiosa, splendidamente liberale, elegante e raffinata, amante della donna, dell’arte, della cultura; poi nel romanzo cortese queste due umanità vengono sapientemente fuse da Chrétien de Troyes.
Il teorico per eccellenza dell’amore cortese è Andrea Cappellano, autore del trattato De amore, in cui vengono fissati le norme e i canoni di tale concezione. Nonostante la condanna della chiesa che lo induce a ritrattare nel terzo libro il contenuto dei due precedenti, l’opera ha un enorme successo, permeando profondamente la cultura aristocratica del Medioevo. Se la caratteristica essenziale del cavaliere della chanson de geste è la prodezza, nota essenziale dell’ideale umanità dei cavalieri-poeti , detti trovatori (dal latino tropare: cercare e trovare versi e musica) è la giovinezza alacre e gioiosa, splendidamente liberale, elegante e raffinata, amante della donna, dell’arte, della cultura; poi nel romanzo cortese queste due umanità vengono sapientemente fuse da Chrétien de Troyes.
La concezione dell’amore cortese si manifesta per la prima volta nel sud della Francia, in Provenza e la neonata lingua d’Oc è il suo strumento espressivo; da qui si diffonde nella tradizione lirica italiana ed europea. Secondo tale concezione, la donna è un essere sublime e irraggiungibile e l’amante si pone nei suoi confronti in una condizione di inferiorità: egli è un umile servitore “obediens”alsuo“midons” (obbediente al suo signore). Tali termini adoperati dall’iniziatore della lirica cortese, Guglielmo IX d’Aquitania, diverranno elementi fondamentali di un linguaggio che esprime una dottrina dell’amore intesa come vassallaggio alla donna, come servizio feudale, come omaggio.
Nella sua totale dedizione, l’amante non chiede nulla in cambio, il suo amore è destinato a restare perennemente inappagato (“desamantz”), ma tale insoddisfazione se da un lato genera sofferenza, dall’altro è anche gioia, una forma di pienezza vitale che ingentilisce l’animo, privandolo di ogni rozzezza e viltà. Amore si identifica con cortesia, e solo chi è cortese ama “finemente”, ma il “fin’amor” a sua volta rende ulteriormente cortesi e gentili (A. Cappellano, De Amore), sicché si viene a istituire una concatenazione di causa-effetto che esclude ogni possibilità di appagamento fisico, poiché quest’ultimo determinerebbe un’interruzione del processo di ingentilimento; tuttavia non bisogna pensare che si tratti di un amore del tutto platonico, infatti l’inappagabilità non esclude né la sensualità, considerato che l’ultimo momento della manifestazione dell’amore consente “l’esag”, ossia l’ammissione dell’amante nudo alla presenza della donna, ma senza congiungersi con lei, né un formale adulterio, visto che il rapporto si realizza rigorosamente al di fuori del vincolo coniugale, nel cui ambito, d’altra parte, si ritiene che non possa esistere “fin’amor”. La spiegazione di tale convinzione trova le sue radici nel carattere contrattuale del matrimonio di quell’epoca in cui ragioni dinastiche ed economiche prevalgono sui sentimenti.
L’amore adultero implica da un lato il segreto, per tutelare l’onore della donna ed evitare “i lauzengiers”, ossia i malparlieri (da qui l’uso del senhal,ossia di uno pseudonimo anziché del vero nome per rivolgersi all’amata), dall’altro un conflitto tra amore e religione, tra culto della donna e culto di Dio. L’amore cortese è quindi peccato per la chiesa e i trovatori vivono sinceramente il senso di colpa, al punto che molti di loro negli ultimi anni di vita si ritirano in convento per espiare le loro colpe, ma se prescindiamo da tale leggenda, è significativo che il senso di colpa affiora anche nella produzione lirica provenzale e soprattutto italiana.
Dopo la crociata contro gli Albigesi, infatti, molti trovatori trovano una nuova patria presso la corte di Federico II e la scuola poetica siciliana fa sua la concezione cortese dell’amore, per poi trasmetterla ai poeti di transizione, detti anche siculi-toscani e, attraverso essi, al Dolce stil novo, ma nell’ambito di quest’ultima scuola, grazie a Dante assistiamo alla sublimazione dell’amore e la donna diventerà tramite tra cielo e terra, angelo-guida verso la comprensione di valori metafisici ed eterni.
Adesso cercheremo di esemplificare, attraverso versi di autori particolarmente significativi, sia tale conflitto tra amore e religione, sia il conseguente senso di colpa che ne deriva. Guglielmo IX di Aquitania conclude il suo canzoniere proprio con una “canzone di pentimento” in cui dichiara che non sarà più “obbediente”, cioè servente d’amore, non più sarà fedele vassallo ligio alla donna: “No serai mais obediens/ En Peitau ni en Lemozi” e, colto da rimorso per le sue colpe, ormai stanco, si chiude nell’ansia del poi e invoca il perdono di Dio nella coscienza della fine imminente.
Spirito possente e tenebroso è Marcabruno; moralista feroce, egli giudica e condanna con parole tremende,come animato da spirito profetico, la società cortese e, in special modo, si erge a giudice del “fin’amors”. Marcabruno dice che “Amore è simile alla favilla che brucia sotto la cenere e brucia poi la trave e il tetto;….chi fa mercato con amore, fa patto con il diavolo….”. Parole altrettanto aspre dice contro le donne che “dolci in principio, poi diventano più amare e crudeli e cocenti dei serpi”; e altrove aggiunge “Dio non mai perdoni a coloro che servono queste puttane ardenti, brucianti, peggiori ch’io non possa dire… che non guardano a ragione o a torto”.
Adesso, se prendiamo in considerazione la produzione letteraria della Scuola poetica siciliana, constatiamo il persistere del senso del peccato e del conseguente rimorso, sì da indurre i poeti a giustificare le loro parole e i loro comportamenti. Jacopo da Lentini in un sonetto (forma metrica, molto probabilmente, da lui inventata) afferma: “Io m’ag[g]io posto in core a Dio servire/com’io potesse gire in paradiso/………Sanza mia donna non vorrai gire,/……ché sanza lei non poteria gaudere/ estando da la mia donna diviso./ Ma non lo dico a tale intendimento,/perch’io pec[c]ato ci volesse fare;/se non veder lo suo bel portamento/….chè lo mi terria in gran consolamento,/veg[g]endo la mia donna in ghioria stare”.
I versi evidenziano una forte ambiguità tra amore terreno e amore celeste, anzi un vero conflitto: se in conformità all’ideologia cortese è normale dire che senza la propria donna non c’è gioia, affermare che la beatitudine paradisiaca è menomata senza la sua presenza è addirittura blasfemo.
Ciò induce il poeta a giustificarsi, pertanto precisa che non vuole la donna con sé in paradiso per commettere peccato, ma per trarne consolazione guardandola, visto che lei, considerata la sua bellezza, è degna di stare in “gloria”.Tuttavia tali giustificazioni non rinnegano il suo atteggiamento di fondo e nei versi conclusivi la contemplazione ipotetica della donna gloriosa finisce con il sostituirsi a quella di Dio.
Questo conflitto investirà anche i poeti del Dolce stil novo e, a dimostrare tale asserzione, basta prendere in considerazione quella che viene considerata la canzone manifesto del Dolce stile: “Al cor gentil rempaira sempre amore” di Guido Guinizzelli. Nell’ultima stanza che funge da congedo, il padre degli Stilnovisti, rivolgendosi all’amata, immagina un dialogo diretto con Dio per mezzo del quale non solo ripropone il motivo capitale della donna-angelo, già presente nella tradizione provenzale e siciliana , ma attua un’autocritica che rivela il solito conflitto amore-religione: “Donna, Deo mi dirà:<<Che presomisti?>>,/siando l’alma mia a lui davanti./<<Lo ciel passasti e’nfin a Me venisti/e desti in vano amor Me per semblanti/………….Dir Li porò:<<Tenne d’angel sembianza/che fosse del tuo regno;/ non me fu fallo,s’in lei posi amanza”.
Dio, quindi, rimprovera il poeta per essersi presentato dinanzi a lui indegnamente, dopo avere attribuito sembianze e poteri divini a un peccaminoso amore terreno (è quanto il poeta fa nella strofe precedente). Guinizzelli si giustifica elegantemente con una nuova lode alla donna: aveva l’aspetto di un angelo, perciò non era una colpa amarla. Tale conclusione viene considerata dal critico Contini “uno spiritoso epigramma”; da Luperini “un’ironica autocritica che difende e riafferma il proprio errore”; da Baldi, “un’elusione del conflitto amore-religione attraverso un’iperbole squisitamente letteraria”, quale quella che identifica la donna con un angelo.
La metafora della donna-angelo è destinata a molta fortuna presso gli Stilnovisti, ma è solo con Dante che essa esce dalla categoria degli attributi esornativi per acquisire una connotazione morale e metafisica.
 La vicenda narrata nella Vita nova è possibile dividerla in tre parti: la prima tratta gli effetti che l’amore produce sull’amante, la seconda propone le lodi di Beatrice, la terza la morte della donna. La seconda parte è quella innovativa, perché il poeta, privato del saluto della gentilissima, comprende che la felicità deve nascere non da un appagamento esterno, ma dentro di lui, dalle parole dette in lode della sua donna, senza averne nulla in cambio, così l’amore diviene fine a se stesso e l’appagamento consiste nel contemplare e lodare la sua Beatrice “cosa venuta/ da cielo in terra a miracolo mostrare” (Vita nova, “Tanto gentile”), cioè angelo che manifesta in terra la potenza divina. Come afferma C. Singleton, questa concezione dell’amore ripropone quella dell’amore mistico elaborata dai teologi medioevali, infatti, alla visione cortese che considera l’amore una passione terrena che, pur raffinata e sublimata attraverso la sua funzione, non elude mai del tutto il senso di colpa, si sostituisce una considerazione di tale sentimento quale aspetto dell’amore mistico, forza che muove l’universo e che innalza le creature sino a ricongiungersi a Dio. Insomma l’amore con Dante, afferma il Singleton, diviene un “itinerarium mentis in deum”.
La vicenda narrata nella Vita nova è possibile dividerla in tre parti: la prima tratta gli effetti che l’amore produce sull’amante, la seconda propone le lodi di Beatrice, la terza la morte della donna. La seconda parte è quella innovativa, perché il poeta, privato del saluto della gentilissima, comprende che la felicità deve nascere non da un appagamento esterno, ma dentro di lui, dalle parole dette in lode della sua donna, senza averne nulla in cambio, così l’amore diviene fine a se stesso e l’appagamento consiste nel contemplare e lodare la sua Beatrice “cosa venuta/ da cielo in terra a miracolo mostrare” (Vita nova, “Tanto gentile”), cioè angelo che manifesta in terra la potenza divina. Come afferma C. Singleton, questa concezione dell’amore ripropone quella dell’amore mistico elaborata dai teologi medioevali, infatti, alla visione cortese che considera l’amore una passione terrena che, pur raffinata e sublimata attraverso la sua funzione, non elude mai del tutto il senso di colpa, si sostituisce una considerazione di tale sentimento quale aspetto dell’amore mistico, forza che muove l’universo e che innalza le creature sino a ricongiungersi a Dio. Insomma l’amore con Dante, afferma il Singleton, diviene un “itinerarium mentis in deum”.
FRANCESCA LUZZIO
L’autrice di questo saggio acconsente alla pubblicazione online su questo spazio senza nulla chiedere né all’atto della pubblicazione né in futuro e attesta, sotto la propria responsabilità, di essere un testo personale, frutto del suo ingegno.



 Ci troviamo dinanzi a poesie d’amore, pregne di sensualità e dove l’istintualità, ovvero il gesto spicciolo, autentico e non premeditato, domina sull’azione degli amanti. Le poesie si mostrano nella forma di attestazioni esplicite d’amore, invito ad abbattere le distanze e ad annullare i tempi, dichiarazioni di vivido trasporto, nonché esternazioni di sogni, incursioni nell’inconscio e addirittura nel proibito. La poetessa si svela verso dopo verso mettendosi in mostra come una donna profonda e romantica, che ha eretto l’Amore come legge morale, l’unica possibile al cuore.
Ci troviamo dinanzi a poesie d’amore, pregne di sensualità e dove l’istintualità, ovvero il gesto spicciolo, autentico e non premeditato, domina sull’azione degli amanti. Le poesie si mostrano nella forma di attestazioni esplicite d’amore, invito ad abbattere le distanze e ad annullare i tempi, dichiarazioni di vivido trasporto, nonché esternazioni di sogni, incursioni nell’inconscio e addirittura nel proibito. La poetessa si svela verso dopo verso mettendosi in mostra come una donna profonda e romantica, che ha eretto l’Amore come legge morale, l’unica possibile al cuore.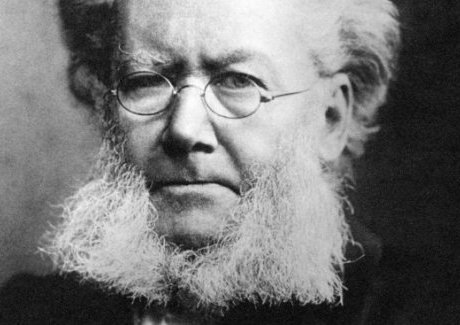
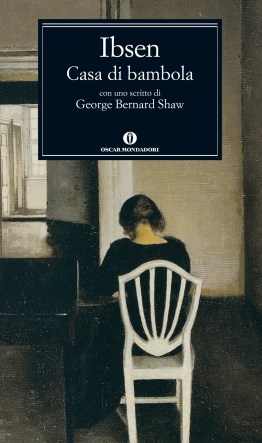 Adela, Yerma, Mariana Pineta nei drammi rurali di Federico García Lorca, Madame Bovary nel romanzo di Flaubert, Sibilla nel racconto autobiografico della Aleramo sono donne che vanno incontro al proprio destino dopo aver scardinato i codici vincolanti del potere, un tipo di autoritarismo esercitato da una madre dominante, un marito totalmente insensibile al desiderio di maternità della donna, un patriota interessato a salvare soltanto se stesso, un uomo che conduce la propria amante verso il suicidio e una madre che, dopo aver subito una violenza carnale, si ribella alle costrizioni della vita sociale. Nei momenti di crisi nessun essere umano è in grado di comportarsi normalmente per cui in un contesto drammatico il suicidio, l’omicidio, il tradimento e l’abbandono non sono veri e propri atti di debolezza ovvero di crudeltà, ma conseguenze di uno stato mentale di forte conflitto fuori e dentro di sé.
Adela, Yerma, Mariana Pineta nei drammi rurali di Federico García Lorca, Madame Bovary nel romanzo di Flaubert, Sibilla nel racconto autobiografico della Aleramo sono donne che vanno incontro al proprio destino dopo aver scardinato i codici vincolanti del potere, un tipo di autoritarismo esercitato da una madre dominante, un marito totalmente insensibile al desiderio di maternità della donna, un patriota interessato a salvare soltanto se stesso, un uomo che conduce la propria amante verso il suicidio e una madre che, dopo aver subito una violenza carnale, si ribella alle costrizioni della vita sociale. Nei momenti di crisi nessun essere umano è in grado di comportarsi normalmente per cui in un contesto drammatico il suicidio, l’omicidio, il tradimento e l’abbandono non sono veri e propri atti di debolezza ovvero di crudeltà, ma conseguenze di uno stato mentale di forte conflitto fuori e dentro di sé.
 Il vecchio Ekdal nel solaio della casa con abeti rinsecchiti, qualche coniglio, dei piccioni e alcune galline ha ricreato un “falso bosco” per poter ricreare di andare ancora a caccia nelle foreste del Nord insieme a suo figlio. Anche l’anitra selvatica vive nella soffitta e trova riparo in una cesta. Ferita dal vecchio Werle durante una battuta di caccia, l’anatra si era tuffata sott’acqua per aggrapparsi alle alghe e morire. Era stato il cane da caccia dell’industriale a trarla in slavo, era sopravvissuta per merito degli Ekdal che si erano presi cura dell’animale. «No , Signor Werle; non è un’anitra turca; ma un’anitra selvatica»,«Ma davvero? Un’anitra selvatica?», «La mia anitra selvatica. Perché è mia./È stata colpita sotto l’ala e così non poteva più volare»
Il vecchio Ekdal nel solaio della casa con abeti rinsecchiti, qualche coniglio, dei piccioni e alcune galline ha ricreato un “falso bosco” per poter ricreare di andare ancora a caccia nelle foreste del Nord insieme a suo figlio. Anche l’anitra selvatica vive nella soffitta e trova riparo in una cesta. Ferita dal vecchio Werle durante una battuta di caccia, l’anatra si era tuffata sott’acqua per aggrapparsi alle alghe e morire. Era stato il cane da caccia dell’industriale a trarla in slavo, era sopravvissuta per merito degli Ekdal che si erano presi cura dell’animale. «No , Signor Werle; non è un’anitra turca; ma un’anitra selvatica»,«Ma davvero? Un’anitra selvatica?», «La mia anitra selvatica. Perché è mia./È stata colpita sotto l’ala e così non poteva più volare»
 Uscirà nel mese di Febbraio il nuovo romanzo di Frank Iodice, Un perfetto idiota.
Uscirà nel mese di Febbraio il nuovo romanzo di Frank Iodice, Un perfetto idiota. 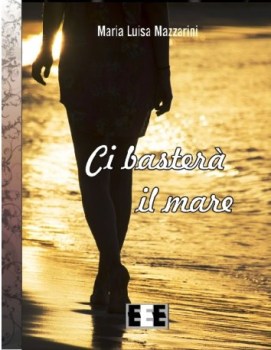
 Venerdì 11 novembre alle 19 presso la Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro (Viale Trieste n°20) si terrà un evento organizzato dalla Associazione Culturale Euterpe di Jesi, la presentazione al pubblico della antologia “L’amore al tempo dell’integrazione” a cura di L. Spurio, S. Vignaroli e A. Montali, volume di poesie e racconti a scopo benefico che beneficerà l’Istituto Oncologico Marchigiano (IOM). La presentazione sarà introdotta da Nani Marcucci Pinoli e sarà condotta da Lorenzo Spurio ed Alessandra Montali, curatori del volume. Interverranno alcuni poeti e scrittori inseriti nell’opera che daranno lettura ai propri componimenti. Tra di loro: Elvio Angeletti, Vincenzo Prediletto, Michela Tombi, Oscar Sartarelli, Marinella Cimarelli, Stefano Sorcinelli, Leonardo Longhi, Matteo Piergigli, Anna Maria Rita Daina, Stefano Vignaroli.
Venerdì 11 novembre alle 19 presso la Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro (Viale Trieste n°20) si terrà un evento organizzato dalla Associazione Culturale Euterpe di Jesi, la presentazione al pubblico della antologia “L’amore al tempo dell’integrazione” a cura di L. Spurio, S. Vignaroli e A. Montali, volume di poesie e racconti a scopo benefico che beneficerà l’Istituto Oncologico Marchigiano (IOM). La presentazione sarà introdotta da Nani Marcucci Pinoli e sarà condotta da Lorenzo Spurio ed Alessandra Montali, curatori del volume. Interverranno alcuni poeti e scrittori inseriti nell’opera che daranno lettura ai propri componimenti. Tra di loro: Elvio Angeletti, Vincenzo Prediletto, Michela Tombi, Oscar Sartarelli, Marinella Cimarelli, Stefano Sorcinelli, Leonardo Longhi, Matteo Piergigli, Anna Maria Rita Daina, Stefano Vignaroli.
 La nuova pubblicazione di Annalena Cimino è la naturale prosecuzione del suo primo libro, L’amante della luna, pubblicato nel 2015. Prosecuzione che non sottende a una vera e propria evoluzione tematica e stilistica e che, piuttosto, si attesta come felice continuazione dopo il breve intervallo nel quale la poetessa ci ha lasciati soli per un periodo di tempo abbastanza lungo. A renderci conto che Annalena prosegue nel suo modo di poetare chiaro ed avvolgente, carico di simbolismi e pregno di presenze naturali, è la lirica d’apertura intitolata “La passione della luna”. Si riallaccia, così, un profondo legame a quel lungo filo che la Nostra ha gettato con la prima pubblicazione dove la luna quale presenza, tema, ossessione, immagine, proiezione, entità e presenza animica e misterica, costituiva il collante principale.
La nuova pubblicazione di Annalena Cimino è la naturale prosecuzione del suo primo libro, L’amante della luna, pubblicato nel 2015. Prosecuzione che non sottende a una vera e propria evoluzione tematica e stilistica e che, piuttosto, si attesta come felice continuazione dopo il breve intervallo nel quale la poetessa ci ha lasciati soli per un periodo di tempo abbastanza lungo. A renderci conto che Annalena prosegue nel suo modo di poetare chiaro ed avvolgente, carico di simbolismi e pregno di presenze naturali, è la lirica d’apertura intitolata “La passione della luna”. Si riallaccia, così, un profondo legame a quel lungo filo che la Nostra ha gettato con la prima pubblicazione dove la luna quale presenza, tema, ossessione, immagine, proiezione, entità e presenza animica e misterica, costituiva il collante principale.


 Alessandro Moscè è uno scrittore che nel panorama di oggi, dove imperversano il giallo, il noir e il fantasy, si distingue nettamente. I suoi romanzi raccontano l’amore e la morte, dunque qualcosa di originale e soprattutto di inattuale. Non c’è nulla di più stupefacente di questi due poli all’apparenza opposti e inconciliabili. L’età bianca (Avagliano 2016) si alimenta nell’oscillazione tra la morte scampata e l’amore atteso. Ma lo scrittore nativo di Ancona e che vive e Fabriano, fa di più, perché ad un certo punto la morte e l’amore si danno la mano siglando una specie di accordo simbolico. Elena, la ragazza diventata donna, fa sorgere il dubbio che sia proprio la morte a visitare lo scrittore, nascosta dietro una normale signora dalle fattezze dolci, aggraziate, sposata e con due figli. Dicevamo della morte: torna spesso, specie nella parte iniziale del romanzo, nelle figure dei nonni, degli zii, dell’omino della casa di riposo e nel calciatore della Lazio che Alessandro Moscè immortala spesso: Giorgio Chinaglia, il numero nove della Lazio del primo scudetto, quello del 1974, passato alla storia per essere stato vinto da una banda di pazzi scatenati. L’età bianca è l’età dell’adolescenza, pura, incontaminata, che non ammette compromessi. Moscè vorrebbe riviverla con Elena, il suo amore mancato da diciottenne. Elena è una presenza seducente, un po’ misteriosa, alla quale l’autore, in chiave autobiografica, racconta se stesso confidandosi fino in fondo, specie sulla guarigione altamente improbabile, da un sarcoma di Ewing avvenuta nel 1983 (Moscè è stato in effetti un caso clinico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di cui si parlò anche nei convegni medici). Con Elena immagina di trascorrere le vacanze al mare di Senigallia dove incontra il grande poeta Mario Luzi, di recarsi ad Assisi per una visita alla basilica, fino a che l’amore si compie realmente in un albergo umbro e l’età bianca pone il sigillo sulla maturità dei due complici. Ma è un’età che non può durare, fuggevole come la giovinezza leopardiana, come tutto ciò che sigla una felicità improvvisa, un eden perduto. La morte e l’amore sono un nutrimento terrestre,
Alessandro Moscè è uno scrittore che nel panorama di oggi, dove imperversano il giallo, il noir e il fantasy, si distingue nettamente. I suoi romanzi raccontano l’amore e la morte, dunque qualcosa di originale e soprattutto di inattuale. Non c’è nulla di più stupefacente di questi due poli all’apparenza opposti e inconciliabili. L’età bianca (Avagliano 2016) si alimenta nell’oscillazione tra la morte scampata e l’amore atteso. Ma lo scrittore nativo di Ancona e che vive e Fabriano, fa di più, perché ad un certo punto la morte e l’amore si danno la mano siglando una specie di accordo simbolico. Elena, la ragazza diventata donna, fa sorgere il dubbio che sia proprio la morte a visitare lo scrittore, nascosta dietro una normale signora dalle fattezze dolci, aggraziate, sposata e con due figli. Dicevamo della morte: torna spesso, specie nella parte iniziale del romanzo, nelle figure dei nonni, degli zii, dell’omino della casa di riposo e nel calciatore della Lazio che Alessandro Moscè immortala spesso: Giorgio Chinaglia, il numero nove della Lazio del primo scudetto, quello del 1974, passato alla storia per essere stato vinto da una banda di pazzi scatenati. L’età bianca è l’età dell’adolescenza, pura, incontaminata, che non ammette compromessi. Moscè vorrebbe riviverla con Elena, il suo amore mancato da diciottenne. Elena è una presenza seducente, un po’ misteriosa, alla quale l’autore, in chiave autobiografica, racconta se stesso confidandosi fino in fondo, specie sulla guarigione altamente improbabile, da un sarcoma di Ewing avvenuta nel 1983 (Moscè è stato in effetti un caso clinico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di cui si parlò anche nei convegni medici). Con Elena immagina di trascorrere le vacanze al mare di Senigallia dove incontra il grande poeta Mario Luzi, di recarsi ad Assisi per una visita alla basilica, fino a che l’amore si compie realmente in un albergo umbro e l’età bianca pone il sigillo sulla maturità dei due complici. Ma è un’età che non può durare, fuggevole come la giovinezza leopardiana, come tutto ciò che sigla una felicità improvvisa, un eden perduto. La morte e l’amore sono un nutrimento terrestre,
 In questa silloge Katia Debora Melis sembra aver approfondito, e di molto, le tematiche che nel corso del tempo ha trattato nelle sue varie sillogi precedenti tanto da giungere a una poetica in cui l’evoluzione matura di scelte linguistiche, sistemi poetico-architettonici e resa di immagini con relative suggestioni conoscono una espressività più diretta che nel lettore produce soprattutto in relazione a certe liriche un’empatia della quale egli stesso può rimanere felicemente impressionato.
In questa silloge Katia Debora Melis sembra aver approfondito, e di molto, le tematiche che nel corso del tempo ha trattato nelle sue varie sillogi precedenti tanto da giungere a una poetica in cui l’evoluzione matura di scelte linguistiche, sistemi poetico-architettonici e resa di immagini con relative suggestioni conoscono una espressività più diretta che nel lettore produce soprattutto in relazione a certe liriche un’empatia della quale egli stesso può rimanere felicemente impressionato.

