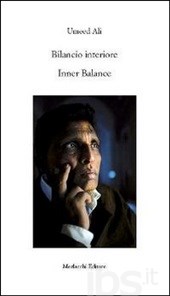Antonio Spagnuolo, Da mozzare, PoetiKanten, Sesto Fiorentino, 2016.
Prefazione di Lorenzo Spurio

Dopo Ultimo tocco nel quale Spagnuolo tesseva le fila attorno a un tema cardine ossia quello del lutto doloroso e della memoria claudicante ed assonnata della sua lunga esistenza con la moglie Elena, l’insigne poeta napoletano ritorna in Da mozzare ad ampliare il suo senso di tormento al mondo dovuto dall’inadeguatezza figlia della lancinante mancanza della sua dolce metà.
Le poesie che compongono il presente volume sono in qualche modo tutte profondamente legate tra loro perché è il destinatario, l’oggetto di interesse e il dedicatario, ad essere sempre il medesimo. Non c’è però in questo, in quella che potrebbe essere percepita come una ridondanza contenutistica, nulla di pleonastico o di eccessivo. Spagnuolo apre le porte del suo cuore rendendoci partecipi della sua vita di istanti fatta di riflessioni amare, incursioni nella memoria, pedisseque ricerche di elementi che permettano di rivitalizzare il vissuto. Come già osservato in una nota critica al suo precedente volume si staglia netta una linea invisibile che demarca l’irraggiungibile distanza tra il mondo concreto, fisico e tangibile ravvisabile nella materia e nella corporeità con l’universo mentale fatto di sogni e desideri, pensieri e divagazioni, assilli mentali, ricorrenze riflessive e quant’altro. L’uomo anela al recupero di un qualsivoglia contatto fisico con l’amata, una carezza, un bacio, un “tocco” anche fugace, mancanza che non solo lo indebolisce ma ne ossessiona le sue giornate. Di contro, da uomo illuminato, cultore della poesia e dell’arte creativa non fa altro che partire dalla sua condizione di isolamento e solitudine nella stesura di liriche dove è la pregnanza sensazionale e l’accecante sentimentalismo a primeggiare.
Alla sua veneranda età e con il carico della sofferenza per l’addio della donna con la quale ha condiviso l’intera esistenza, il Nostro non manca di appigliarsi con foga agli impulsi vivi ed edificanti di un passato di gioia, condivisione e unità proprio per non cadere nella costernazione più cupa che ne annienterebbe ogni speranza. La memorialistica del rapporto di coppia, nelle convenzionalità tipiche e nelle consuetudini di un rapporto pluridecennale fanno capolino con compostezza tra i vari componimenti dove la profonda carenza dell’uomo è sempre amplificata da una condizione di spossatezza, abbandono, spoliazione e addirittura annichilimento.
Se da una parte il lucido punto di vista dell’uomo non si sottrae alla registrazione puntuale della realtà (“Non c’è rimedio alcuno per averti”) dall’altra è proprio nella fugacità delle sfumature, nella percezione frugale ed estemporanea delle immagini vissute (“Ora nel buio ancora resta intatta la tua figura”) che permettono al Nostro di non cadere nel baratro dell’auto-annullamento e della depressione propriamente detta. Il poeta ricerca nei bagliori intensi del passato il sostentamento a un presente difficile e tormentato dove, se la luce non tornerà ad abbagliare come una volta, non sarà neppure così fioca da piombarlo nel buio pesto. Parole-chiave del volume diventano così la solitudine ed il silenzio a cui non di rado si associano anche gli epiteti di un vivere affaticato, nostalgico, che fa difficoltà a risalire la china, sprofondato in un cromatismo di grigi pesanti che si nutrono dell’angoscia e della desolazione.
Proprio il colloquio intimo con sé, la rievocazione del passato, il tentativo di rimestare nella mente per rompere la solidità granitica di un presente senza aspettative e gioie finisce per mostrarsi il salvacondotto per recuperare un senso all’esistenza: “Il silenzio rinnova le memorie”. Serve allora tacere, rifugiarsi nel suo antro di solitudine, specchiarsi e auto-interrogarsi con una dialettica che non è fatta dal verbo ma dalle immagini, nel loro impulsivo apparire e lento fruire. Vivere di ricordi è possibile perché significa aver condotto con se stessi un profondo interrogatorio della coscienza e dunque essersi messi alla prova: chi lo fa ha il coraggio del combattente e Spagnuolo mostra chiaramente di esserlo. Non si tratta di una vita illusoria che ricerca rabdomaticamente il passato per aggrapparsi strenuamente a qualcosa di già conosciuto ed esperito con il timore invece di aprirsi al futuro (il presente liquido dei giorni) che è inconoscibile e pressante. Il poeta mostra con vividezza quanto l’eredità del passato possa confluire nell’ampia risma dei nutrimenti fondamentali a dar sostegno ed energia non al corpo ma all’anima.
La donna allora, dacché non può essere carne ed ossa, si configura come immagine, una icona non idealizzata ma coerentemente sentita come presente e pulsante. Il compito del poeta sembra allora quello di adoperarsi con i suoi pochi e rudimentali mezzi per riuscire a percepire sempre meglio una visualizzazione della donna-icona e con essa colloquia, immagina di trovarsi, ma più spesso anela alla sua mancanza di corporeità vissuta come assillo insostenibile: “Vorrei toccare le curve come mite fughe/ e rintracciare la gioventù perduta”. Gli attributi dell’icona non sono solo visivi e dunque direttamente figurativi ma si legano anche alle altre sfere sensoriali come quando il Nostro non manca di percepire la dolorosa assenza del “fruscio della [s]ua gonna”.

Della prematura chiamata di sua moglie alla casa del Padre Spagnuolo parla nella lirica “Pianto” probabilmente, come lo stesso titolo non manca di ravvisare, la più dolorosa e toccante. In essa, rimembrando il giorno dell’addio il Nostro sostiene “Dio ha giocato/ uno sgambetto prima del tempo/ e mi ha raggirato nell’attimo dei frantumi”. La morte della moglie è descritta con una tecnica profondamente sintetica per mezzo di una sintassi semplice dove la vita non è altro che un gioco e la morte uno sgambetto, dunque uno scherzo amaro improvviso, un trucco grottesco. Della morte come appuntamento ultimo insondabile Spagnuolo si riferisce in varie liriche quando con un animo pacificato parla dell’attesa del “passo falso del destino”, lucidamente convinto che la morte, quale maggior imprevisto del genere umano, sia la peggiore delle viltà, per la quale non esistono mezzi efficaci di conforto (“preghiere che non hanno il senso”).
La casa si fa “nuda”, spoglia di presenze concrete e piena di emozioni sottaciute, pulsioni azzerate, ricordi antiquati ai quali si desidera essere calamitati con sprizzante carica, il Nostro nella desolazione e nell’appiattimento dei giorni affida alla poesia il suo tormento e l’angoscia di vivere nell’assenza “ingann[ando] il tempo nella melodia dell’aurora”.
Se la memoria diventa l’unico legame saldo a una vita vissuta, bagaglio di gioie e ricchezze che hanno permesso l’evoluzione e il soddisfacimento della persona, d’altra parte il suo recupero diventa spesso difficile, intiepidito dall’avanzata età, confusionario e poco nitido, privo di tutti quegli effluvi speziati che avevano contornato il momento nel suo sviluppo al presente. Il disagio di cercare di vivere puntando su nuove mete e interessi, cioè di sopravvivere a se stessi, potrebbe in tal senso incontrare la minaccia del lento obnubilamento che conduce alla letargia della coscienza. Ad esso il Nostro contrappone la saggezza di un intellettuale di elevata caratura e la comprensione attenta di un presente che cambia, con i suoi densi accumuli di passato.
Jesi, 5 Dicembre 2015


 Già nella prima silloge erano presenti i germi di tematiche (la solitudine, l’alienazione, l’alone di mistero sulla vita) che la poetessa affronta, amplifica e sviscera qui in Memorie intrusive. Il titolo, curioso e incisivo al tempo stesso, è l’eccelsa sintesi degli ambiti concettuali che il libro affronta con un linguaggio asettico, a tratti freddo e dal quale traspare la durezza (spietatezza) degli eventi descritti e rimembrati che hanno prodotto un doloroso trauma nella vita presente. Ma si analizzi il titolo con la debita attenzione che esso merita: le “memorie” di cui Ilaria parla non sono tanto da intendere come memorie di carattere collettivo, legate cioè al passato della sua regione o del suo paese né propriamente a quello della sua famiglia, ma sono frammenti
Già nella prima silloge erano presenti i germi di tematiche (la solitudine, l’alienazione, l’alone di mistero sulla vita) che la poetessa affronta, amplifica e sviscera qui in Memorie intrusive. Il titolo, curioso e incisivo al tempo stesso, è l’eccelsa sintesi degli ambiti concettuali che il libro affronta con un linguaggio asettico, a tratti freddo e dal quale traspare la durezza (spietatezza) degli eventi descritti e rimembrati che hanno prodotto un doloroso trauma nella vita presente. Ma si analizzi il titolo con la debita attenzione che esso merita: le “memorie” di cui Ilaria parla non sono tanto da intendere come memorie di carattere collettivo, legate cioè al passato della sua regione o del suo paese né propriamente a quello della sua famiglia, ma sono frammenti
 L’intera raccolta poetica del calabrese Gaetano Catalani diparte da un rapporto conflittuale e instancabile con la massa temporale, percepita il più delle volte come sadica e incontrollata ingannatrice dei destini umani. Il poeta sembra non riuscire a staccarsi dalle scaglie intime del passato che spesso ritornano talmente vivide in lui da anelare una sorta di scioglimento dell’esistenza in quel tempo che fu. Come il titolo del volume ben rimarca, il ricordo riaffiora sia in maniera voluta, dunque razionalmente, nei nostri tanti tentativi che facciamo per voler ricordare un momento o una persona con quella nitidezza ormai svanita, sia sulla base di un profumo percepito, una immagine vista, una fragranza percepita, un luogo vissuto e, comunque, tutti quegli elementi che nel presente permettono una riappropriazione della vita passata. Il ricordo allora è prevalentemente inaspettato e fugace, un lampo di barlume emotivo che riscalda il cuore e conforta ma che non è in grado di infrangere quella malinconia titanica, quel senso di desolazione che, al termine delle nostre giornate durante le quali abbiamo avuto la testa assai piena di incombenze, torna a visitarci tanto da renderci assai vulnerabili per la mancanza di un caro, l’errore di una scelta fatta, la decisione presa avventatamente o semplicemente la nostalgia del proprio borgo dove allegramente si giocava.
L’intera raccolta poetica del calabrese Gaetano Catalani diparte da un rapporto conflittuale e instancabile con la massa temporale, percepita il più delle volte come sadica e incontrollata ingannatrice dei destini umani. Il poeta sembra non riuscire a staccarsi dalle scaglie intime del passato che spesso ritornano talmente vivide in lui da anelare una sorta di scioglimento dell’esistenza in quel tempo che fu. Come il titolo del volume ben rimarca, il ricordo riaffiora sia in maniera voluta, dunque razionalmente, nei nostri tanti tentativi che facciamo per voler ricordare un momento o una persona con quella nitidezza ormai svanita, sia sulla base di un profumo percepito, una immagine vista, una fragranza percepita, un luogo vissuto e, comunque, tutti quegli elementi che nel presente permettono una riappropriazione della vita passata. Il ricordo allora è prevalentemente inaspettato e fugace, un lampo di barlume emotivo che riscalda il cuore e conforta ma che non è in grado di infrangere quella malinconia titanica, quel senso di desolazione che, al termine delle nostre giornate durante le quali abbiamo avuto la testa assai piena di incombenze, torna a visitarci tanto da renderci assai vulnerabili per la mancanza di un caro, l’errore di una scelta fatta, la decisione presa avventatamente o semplicemente la nostalgia del proprio borgo dove allegramente si giocava.