 La nuova edizione di A sud delle cose (Lebeg, Roma, 2017) del calabrese Pasqualino Bongiovanni (la prima edizione risale al 2006), s’inserisce in quell’ampio filone della letteratura nostrana (ancor più vivido negli anni ’70 e ’80) teso a indagare con costanza, rispetto e profonda serietà, la situazione socio-economica e identitaria di una terra definita come meridionale, posta a Sud del Belpaese. Molta letteratura, più o meno colta, più o meno ricordata e studiata nelle scuole oggigiorno (mi riferisco al vero caso nato in seguito alla decisione del Ministro Maria Stella Gelmini nel 2010 di cancellare dai programmi scolastici lo studio di alcuni significativi e imprescindibili intellettuali meridionali quali Alfonso Gatto, Leonardo Sciascia, Rocco Scotellaro, Francesco Jovine, Leonardo Sinisgalli, solo per fare degli esempi)[1] fece suoi i motivi d’indagine della comunità di provincia, di ambienti lontani dai centri propulsivi mettendo nero su bianco le potenzialità e gli orgogli dell’animo contadino e, dall’altro, le idiosincrasie diffuse nell’affare pubblico, le forme degenerate nell’esercitazione del potere, la corruzione e tutti quei sistemi deviati che portano il cittadino sano a sentirsi, nel suo ambiente, a sentirsi inascoltato, prevaricato e offeso dalle bieche logiche personalistiche o di gruppi più ampi.
La nuova edizione di A sud delle cose (Lebeg, Roma, 2017) del calabrese Pasqualino Bongiovanni (la prima edizione risale al 2006), s’inserisce in quell’ampio filone della letteratura nostrana (ancor più vivido negli anni ’70 e ’80) teso a indagare con costanza, rispetto e profonda serietà, la situazione socio-economica e identitaria di una terra definita come meridionale, posta a Sud del Belpaese. Molta letteratura, più o meno colta, più o meno ricordata e studiata nelle scuole oggigiorno (mi riferisco al vero caso nato in seguito alla decisione del Ministro Maria Stella Gelmini nel 2010 di cancellare dai programmi scolastici lo studio di alcuni significativi e imprescindibili intellettuali meridionali quali Alfonso Gatto, Leonardo Sciascia, Rocco Scotellaro, Francesco Jovine, Leonardo Sinisgalli, solo per fare degli esempi)[1] fece suoi i motivi d’indagine della comunità di provincia, di ambienti lontani dai centri propulsivi mettendo nero su bianco le potenzialità e gli orgogli dell’animo contadino e, dall’altro, le idiosincrasie diffuse nell’affare pubblico, le forme degenerate nell’esercitazione del potere, la corruzione e tutti quei sistemi deviati che portano il cittadino sano a sentirsi, nel suo ambiente, a sentirsi inascoltato, prevaricato e offeso dalle bieche logiche personalistiche o di gruppi più ampi.
Si sono lette pagine di un’invereconda potenza lirica se si pensa a Vittorio Bodini, Bruno Epifani nonché Jovine, Rocco Scotellaro, Ignazio Buttitta[2], solo per fare alcuni dei nomi che, d’istinto, mi balzano alla mente. Ma se ne potrebbero fare moltissimi altri, è ovvio: ciascuno, a suo modo, ha descritto con caparbietà ed empatico afflato amoroso i propri ambienti, radicati nella propria intimità, scenari della propria infanzia incorrotta, non mancando, però, di far emergere tra le righe pensieri di dissenso verso uno strano modo di pensare le cose e di attuarle, denunce più o meno aspre, ma comunque valide come sistemi d’allontanamento da quel sistema diffuso di malaffare, omertà, ingiustizia sociale, in-ascolto da parte delle sfere di potere.

Spesso l’uomo è stato costretto ad allontanarsi dal suo luogo natale per raggiungere mete sperate, intuite come più facili, per l’attuazione di un benessere, la costituzione di una famiglia e lo sviluppo di una nuova fase della propria esistenza. Il fenomeno migratorio inteso come lucido spostamento nei luoghi più promettenti del Settentrione d’Italia nelle decadi passate ha senz’altro interessato anche vari intellettuali che, dalle loro piccole cittadine assolate e polverose, si sono visti attori di una de-territorializzazione spontanea dettata, appunto, da motivazioni essenzialmente economiche, se non di fortuna. La letteratura, da entrambe le direzioni, si è sempre mostrata attenta nell’indagare il sentimento di mancato agio del meridionale al Nord o, al contrario, del settentrionale a Sud (salvo pochi felici casi di facile ricontestualizzazione) com’è per il capitano Bellodi, uomo del Nord e simbolo della legge, che viene mandato a indagare su ambigui omicidi in un recondito paese della Sicilia come Sciascia, romanziere e mafiologo, descrisse in quella che è senz’altro considerata la sua opera maggiore, Il giorno della civetta. Precedentemente Tomasi di Lampedusa, nel suo romanzo storico Il Gattopardo, ben aveva evidenziato come il principe Salina, ultimo fedele e convinto custode di un’aristocrazia baronale e feudale, era mal disposto ad accettare i discorsi del cavaliere Chevalley, uomo del Nord, di quella che sarebbe stata la schiera nobiliare in sostegno a casa Savoia. Questo per una ragione molto semplice: le condizioni e le esigenze di un Sud che viene di colpo tirato per la giacchetta per un rinnovamento visto nel nuovo stato, vengono poste in un humus arcaico fatto di cultura campestre e autentica, di sodali connivenze tra poteri della terra, in un modo di fare, cioè, che con difficoltà sarà capace di sradicare i suoi arcaici e fondanti paradigmi, i pilastri organizzativi. Chevalley, dunque, che rappresenta la novità e quel cambiamento che sembra arrivare di colpo, senza aver la possibilità di essere compreso prima di essere accettato, ha la forma di un’ingerenza bella e buona, di una richiesta di sottomissione che le fiere genti del Sud vivono come intromissione e ostilità, dalle quali nascono malcontento e insicurezza. Se Bellodi in Sicilia non riuscirà a risolvere l’intricata questione dei delitti concludendo con il vigliacco annuncio “Mi ci romperò la testa”, Bongiovanni nella lirica “Più morti che vivi”, dedicata al sindaco di Lamezia Terme Gianni Speranza, deplora il sistema nefando delle uccisioni senza responsabili né mandanti: “Il vetro si spacca, e il negozio va in fumo,/ lo stesso succede alla porta del Comune/ […]/ Soprusi di ieri e ingiustizie di oggi:/ millenni diversi, le stesse angherie” (64). La pessimistica conclusione del Nostro dinanzi all’evidenza di un “paese morto” (64) viene posta nei termini di esacerbato rifiuto delle logiche di potere e delle sue degenerazioni in atti omicidiari, minatori, di rivalsa, intimidatori e terroristici. Le citazioni e i rimandi letterari che si potrebbero avanzare in merito a quella che poi venne definita “questione meridionale” sono numerosissime e vaste tanto che ci limiteremo a queste, per introdurci nell’opera di Pasqualino Bongiovanni, il cui titolo è di per sé semplificativo dell’intero ragionamento che qui si sta cercando di fare. A sud delle cose, infatti, fornisce l’immagine di una Calabria vetusta e radicata a vecchie forme di sistema sociale dove connivenze diffuse, forme di disattenzione generalizzata per il popolo e gestione spavalda dei pochi vengono a dominare. Bongiovanni non parla nel titolo in maniera specifica della Calabria (che sarà poi svelata man mano dalle varie poesie della silloge) ma di un imprecisato e generalizzato “Sud” nel quale, appunto, dobbiamo includere le tante micro-realtà di provincia della parte meridionale del Belpaese: dal partenopeo, alle zone gallurese, dagli altipiani della Sila agli arroccati paesi siciliani, dal potentino alla Locride, ma anche il Sud di ogni parte del mondo. Bongiovanni, che ha vissuto vari anni nel non-Sud, compie un percorso di recupero di quegli oggetti, ricordi, momenti di un’età vissuta nell’ambiente calabrese rimembrando tanto i piacevoli scenari naturalistici (“pendii/ brulli e desolati/ della mia terra”, 66), atti a donare pace e creare sodalizio con l’anima, quanto le ambiguità costitutive della gente del luogo e l’incredulità verso il possibile raggiungimento di un bene comune. La prefazione di Anna Stella Scerbo dice che “i topoi della letteratura del Sud sono evidenti e non lascia dubbi la matrice culturale di essi, un’analisi del negativo che accomuna la migliore produzione della poesia e della narrativa meridionale, da Levi a Iovine, da Scotellaro a Santamaria. […] A volte si affaccia un non so che di consolatorio, funzionale non tanto alla poesia quanto alla lacrimevole retorica che ha voce di pianto e di rassegnata sottomissione”.

Bongiovanni, con virulento realismo, parla di lavoro e fatica nei campi (“Morte di un contadino”); la filigrana sulla quale le liriche si dispongono è di desolazione interiore, sorta di lotta alle ipocrisie (“si saluta con la sinistra/ e s’intasca con la destra”, 61), denuncia convinta eppure ritirata, rimasta in qualche modo sottaciuta che risale come motivo recriminatorio e dolente verso la terra che gli ha dato i natali. Talvolta la sfiducia è disarmante tanto che il poeta s’incanala in formule espressive fortemente cupe e prive di remissione: “Contemplo l’amara tristezza/ del fondo di un bicchiere” (8). Le forze del Nostro atte a contestualizzare il problema e a identificarlo tale sono per lo più atti propositivi che nella complessità del reale finiscono per affievolirsi: “Grido controvento/ il mio disappunto/ di parole,/ le controversie/ dei pensieri/ che mai/ avranno rifugio/ o padrone” (15). Tali considerazioni sembrano farsi ben più croniche nella poesia ossessiva e lacerante “Domanda consueta” in cui l’autore annota: “Per chi cantare/ se le nostre mani/ non hanno strumento, né suono,/ e la nostra voce… non ha voce,/ e non ha grido,/ e nemmeno pensiero ha più?” (20). Sono poesie di un uomo fatto di terra e acqua, di montagna e mare, di un abitante del territorio che soffre con consapevolezza i drammi di un contesto regionale nel quale sembra impossibile rivoltare tutto per metterlo a posto. La poesia “Spleen” è senz’altro un identikit così scrupoloso e chiaro tendente a tracciare quell’emarginazione nella propria terra e conflitto nell’anima: “La mia anima guarda con occhi/ gravidi di lacrime/ i fogli rigati, macchiati/ da grumi di polvere nera e sangue,/ sudore e rabbia tra le mie dita” (9). La poesia “A sud delle cose” immancabilmente fa echeggiare il ritorno alle origini descritto In Conversazione in Sicilia (1941) di Vittorini: Bongiovanni narra in versi di un ritorno verso il Sud, “torniamo/ dove il mare,/in inverno,/ ha colori sporchi” (12), in quel paese addormentato “dove le preghiere/ sono lunghi mormorii/ avvolti in scialli neri” (12). Figurativamente vediamo quelle signore anziane coperte di nero, sprofondate in un lutto che non è tanto di un proprio caro, quanto una lacrimazione continua, una forma di stringato onore, di conformazione a un dolore dilagante e impalpabile. La chiusa della lirica, nella quale si ricalca la grande devozione a Dio, è di forte impatto: “Così/ torniamo a Sud/ a sud delle cose,/ dove l’amore è muto/ e si dà solo ai Santi” (13). L’amore non ha forma e non ha voce, c’è riserbo e vergogna, esso è celato o diminuito tanto che il solo sentimento concesso è un atto votivo, un appello al santo che possa serbare conflitti interiori, dilemmi sulla fuga, intenzioni e proponimenti che a nessuno è dato rivelare. Sud di “Cristi senza croci” (14) dove il Calvario del Signore è continuo, in un percorso non visto che non ha requie e che lo pone lontano e irraggiungibile al suo atto sacrificale ultimo, ambiente indistinto e fisso come una cappa dove “è solo vita che scorre…/ …grigia e stanca” (16), di ricordi che annegano “nelle sere ingiallite e fioche” (24), nelle conversazioni sterili e incapaci nella realizzazione (“in discorsi/ di secche speranze”, 60). Il sentimento di vile omertà è ben delineato nella “Litania meridionale” dove i “tre colpi/ di arma da fuoco…” (26) che lasciano a terra persone, lasciano osservare all’autore che “anche stavolta/ non è stato/ nessuno” (27); questa è quella che Pasqualino Bongiovanni definisce la “morte meridionale” (28) nella forma di un ammazzamento che avviene inconsulto, con un format ben conosciuto, dove non vi sono responsabili né testimoni né un concreto bisogno d’investigazione sull’accaduto: “Il pastore,/ che è lì steso,/ sdraiato,/ morto ammazzato,/ morto di morte/ meridionale” (28).

- Franco Costabile
Varie poesie qui contenute affrontano il tema dell’emigrazione, una fra tutti è il “Canto dei nuovi emigranti” dedicata al poeta calabrese Franco Costabile (1924-1965) che fu costretto ad abbandonare la sua Sambiase per emigrare nel Settentrione, giungendo nel capoluogo laziale dove nel 1965 decise di porre fine alla sua esistenza. L’autore meridionale, al quale pure Ungaretti e Caproni dedicarono versi, durante la sua esistenza aveva dato alle stampe due opere poetiche: Via dagli ulivi (1950) e La rosa nel bicchiere (1961). A lui Bongiovanni scrive: “Abbiamo imparato/ a ripiegare/ in una valigia/ la vita,/ a riporre/ ordinatamente/ l’anima/ in una scatola./ Abbiamo/ titoli di speranza/ chiusi nella cartella” (37). Con un intento ideale teso ad abbracciare i dolori intimi e strazianti dell’esule, dell’emigrante, di colui che per varie ragioni deve lasciare contro se stesso la sua terra, l’autore scrive: “Conosco/ le ansie dello studente/ le speranze dell’emigrante/ di colore diverso/ e tutte uguali/ che si affrettano/ su binari e rotaie” (42). L’immagine del treno, della partenza e dei binari (“l’amore che parte/ su nuove rotaie”, 44) ritorna spesso nei componimenti; in questa maniera Bongiovanni traccia la forma tipo di viaggio dell’emigrante, abbandonato al freddo delle carrozze nell’attesa di lunghe ore per raggiungere il luogo della speranza, all’esatto opposto dalla sua anima e patria nativa: “Siamo vagoni abbandonati/ adibiti a case” (73), chiosa nella lunga lirica “Le gemme da innesto”. La conclusione a tale universo di nebbie, dolori ricorrenti, pensieri sfiduciati e una società gretta che cambia lentamente, pur continuando a nutrire al suo interno i suoi cancri, è che una conclusione non c’è: “Così/ non rimane/ che una discreta solitudine,/ un malessere muto/ che andrà scemando/ con l’arrivo della primavera” (22). Malessere che l’autore dice che scemerà, ovvero si attenuerà, verrà mitigato dai nuovi colori, dal sole e da una rinata speranza (“la nostra vita/ è questo sciogliere in mezzo,/ questo continuo sperare”, 91) ma che, in fondo, non sarà mai vanificato in forma completa. Neppure la fede, caposaldo della cultura patriarcale del Meridione (si sottolinea qui anche la bipolare manifestazione del malavitoso molto credente e al contempo assassino e torturatore di suoi simili), è in grado di far luce o per lo meno d’indicare una via di speranza numinosa, di confessione delle pene e di pulizia d’anima: “Immaginette/ di santi/ appese con semenza/ a pareti imbiancate a calce/ rinnovano/ non so come,/ la fede” (32). Eppure l’ultima volontà del Nostro è tesa a sottolineare con convinzione la decenza e il rispetto delle sue genti e di quelle di ogni Sud, lontane da forme di clamore o di urlante declamazione: “Abbiamo vite silenti/ cariche di dignità/ che nessuno ha mai ascoltato” (71). Un testamento da conservare, dunque, ma anche una realtà da rivelare.
Jesi, 01-03-2018
NOTE:
[1] Di questo caso si è occupata ampiamente la stampa, difatti si trovano numerosi articoli in rete. Per approfondire meglio la questione in oggetto, consiglio la lettura dell’articolo “Poeti e scrittori meridionali del ‘900 cancellati dai programmi per i licei” a firma di Roberto Russo apparso sul Corriere della Sera il 19-03-2012. Lo scrittore Pino Aprile, con il suo libro Giù al Sud (2011), ha dedicato ampio spazio all’argomento come pure il critico letterario e docente Paolo Saggese mediante un incontro d’approfondimento e divulgativo in seno al Centro di documentazione della poesia del Sud di Nusco (AV). Lo stesso Saggese, assieme ad altri docenti e studiosi (Alessandro Di Napoli, Giuseppe Iuliano, Alfonso Nannariello e Raffaele Stella) ha prodotto un volume molto importante di contributi critici, con nota di prefazione di Paolo Di Stefano, intitolato Faremo un giorno una Carta poetica del sud (2012). Al suo interno sono contenuti questi interventi, illuminanti e ben posti a indagare l’importanza di autori meridionali e la loro indiscussa incidenza e preminenza nel vasto compendio della letteratura nazionale: “La ‘damnatio memoriae’ della letteratura del Sud (e della letteratura scritta da donne)” di Paolo Saggese; “Quei (bi)sogni di identità e unità nazionale. Scrivere la storia di una letteratura comune significa conoscere il mondo e aiutarlo a vivere” di Giuseppe Iuliano; “I poeti del sud del Novecento nelle antologie e nelle Storie della letteratura italiana adottate dalle scuole” di Alessandro Di Napoli”; “Razza impoetica. Gli esclusi e gli espulsi. I poeti del Sud nella storia della letteratura, nelle antologie poetiche e nelle Indicazioni nazionali” di Alfonso Nannariello; “Maria Luisa Spaziani, Grazia Deledda, Salvatore Quasimodo e le “Indicazioni nazionali” per i licei” di Raffaele Stella.
[2] Tra gli altri autori meridionali molto meno noti e la cui attività e memoria è ricordata (in taluni casi) nei dati contesti locali da iniziative e premi letterari in loro memoria possiamo citare Maria Costa (Messina), Giusi Verbaro Cipollina (Soverato), Ciro Vitiello (San Sebastiano al Vesuvio), Francesco Graziano (Cosenza),…
La riproduzione del presente testo, in forma di stralcio o integrale, non è consentita in qualsiasi forma senza il consenso scritto da parte dell’autore.



 Il Breve inventario di un’assenza (Samuele Editore, 2018) che poi così breve non è (sessantasei pagine di lunghezza che, per una silloge poetica, sono senz’altro buone e rispettabilissime!) è breve nella forma (sono liriche che, tranne pochissimi casi, non superano i dodici versi) e in quel dire doloroso che ha la forma di un commiato che si è compiuto nell’intensità di un istante breve. L’autore ha scritto queste liriche in memoria della figura paterna recentemente scomparsa che, oltre a lasciare una debordante assenza, ha reso edotto il figlio del carico emotivo degli oggetti. Così la camicia lasciata appesa, le scarpe, la manica scucita di una giacca, sono i segni evidenti di una vita che s’è compiuta e che, pur circondata dall’opprimente aria che non ha forma, è ancora lì presente, circolante negli angoli della casa, così come è onnipresente nella mente e nel cuore di chi la porta con sé. L’assenza, dunque, è catalogata (inventariata, per l’appunto) mediante i tratti del mondo fisico, gli utensili, gli oggetti d’accompagnamento che definivano l’attore dell’assenza che, fuggendo per sempre, li ha però lasciati lì nel suo luogo ancestrale. La prefatrice Gabriela Fantato, in riferimento a questa operazione di raccolta e repertazione degli oggetti operata da Paoletti, parla di “alfabeto della perdita”. In effetti pare di comprendere che l’amplificazione dolorosa si crea nell’io lirico dinanzi all’evidenza di quel mondo fisso e ormai insignificante, dominato da quegli emblemi, simboli e feticci che ormai hanno perso rapporti di appartenenza e usi pratici per divenire mere entità residuali.
Il Breve inventario di un’assenza (Samuele Editore, 2018) che poi così breve non è (sessantasei pagine di lunghezza che, per una silloge poetica, sono senz’altro buone e rispettabilissime!) è breve nella forma (sono liriche che, tranne pochissimi casi, non superano i dodici versi) e in quel dire doloroso che ha la forma di un commiato che si è compiuto nell’intensità di un istante breve. L’autore ha scritto queste liriche in memoria della figura paterna recentemente scomparsa che, oltre a lasciare una debordante assenza, ha reso edotto il figlio del carico emotivo degli oggetti. Così la camicia lasciata appesa, le scarpe, la manica scucita di una giacca, sono i segni evidenti di una vita che s’è compiuta e che, pur circondata dall’opprimente aria che non ha forma, è ancora lì presente, circolante negli angoli della casa, così come è onnipresente nella mente e nel cuore di chi la porta con sé. L’assenza, dunque, è catalogata (inventariata, per l’appunto) mediante i tratti del mondo fisico, gli utensili, gli oggetti d’accompagnamento che definivano l’attore dell’assenza che, fuggendo per sempre, li ha però lasciati lì nel suo luogo ancestrale. La prefatrice Gabriela Fantato, in riferimento a questa operazione di raccolta e repertazione degli oggetti operata da Paoletti, parla di “alfabeto della perdita”. In effetti pare di comprendere che l’amplificazione dolorosa si crea nell’io lirico dinanzi all’evidenza di quel mondo fisso e ormai insignificante, dominato da quegli emblemi, simboli e feticci che ormai hanno perso rapporti di appartenenza e usi pratici per divenire mere entità residuali.
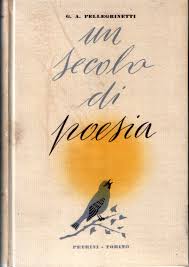




 È così che il poeta fermano – anticipato dalla ponderata prefazione di uno valido studioso e storico qual è Marco Rotunno – con quest’opera è come se compiesse una casta operazione di svestimento o denudamento, affidandoci pensieri personali, ragionamenti maturati nell’intimità, appelli d’amore e inviti all’accoglimento del proprio sentimento e, ancora, rivelazioni che hanno un senso epifanico – e dunque travolgente in senso illuminante – per il solo io lirico che ne traccia le vicende di un amore forte, intristito solo da alcuni capovolgimenti che tendono più a un’ombrosità del pensiero data dall’elucubrazione su realtà insondabili eppure oggetto d’interesse dell’uomo. Vengono a mente allora le voci e le considerazioni apparentemente astruse ma assai rivelatrici di studiosi quali Roland Barthes e del filosofo austriaco Wittgenstein; entrambi, pur con inclinazioni e intendimenti diversi, hanno dissodato la parola come realtà, sviscerandola e destrutturandola per meglio misurarla, odorarla, farne uso.
È così che il poeta fermano – anticipato dalla ponderata prefazione di uno valido studioso e storico qual è Marco Rotunno – con quest’opera è come se compiesse una casta operazione di svestimento o denudamento, affidandoci pensieri personali, ragionamenti maturati nell’intimità, appelli d’amore e inviti all’accoglimento del proprio sentimento e, ancora, rivelazioni che hanno un senso epifanico – e dunque travolgente in senso illuminante – per il solo io lirico che ne traccia le vicende di un amore forte, intristito solo da alcuni capovolgimenti che tendono più a un’ombrosità del pensiero data dall’elucubrazione su realtà insondabili eppure oggetto d’interesse dell’uomo. Vengono a mente allora le voci e le considerazioni apparentemente astruse ma assai rivelatrici di studiosi quali Roland Barthes e del filosofo austriaco Wittgenstein; entrambi, pur con inclinazioni e intendimenti diversi, hanno dissodato la parola come realtà, sviscerandola e destrutturandola per meglio misurarla, odorarla, farne uso.


 L’autrice presenterà il suo libro Interferenze alla luce di poesie domenica 17 dicembre alle 17:30 a Macerata presso la Locanda del Belli (Via Mazzini 29) durante la quale si terrà un aperitivo letterario con la presenza del poeta e critico letterario prof. Guido Garufi (di recente uscito con la silloge Fratelli con prefazione di Giovanni Tesio) e gli intermezzi musicali al pianoforte di Halyna Zamyatina. Per chi gradirà fermarsi per l’apericena, essa ha un prezzo di 13€ e sarà possibile effettuare la prenotazione ai riferimenti in calce.
L’autrice presenterà il suo libro Interferenze alla luce di poesie domenica 17 dicembre alle 17:30 a Macerata presso la Locanda del Belli (Via Mazzini 29) durante la quale si terrà un aperitivo letterario con la presenza del poeta e critico letterario prof. Guido Garufi (di recente uscito con la silloge Fratelli con prefazione di Giovanni Tesio) e gli intermezzi musicali al pianoforte di Halyna Zamyatina. Per chi gradirà fermarsi per l’apericena, essa ha un prezzo di 13€ e sarà possibile effettuare la prenotazione ai riferimenti in calce.

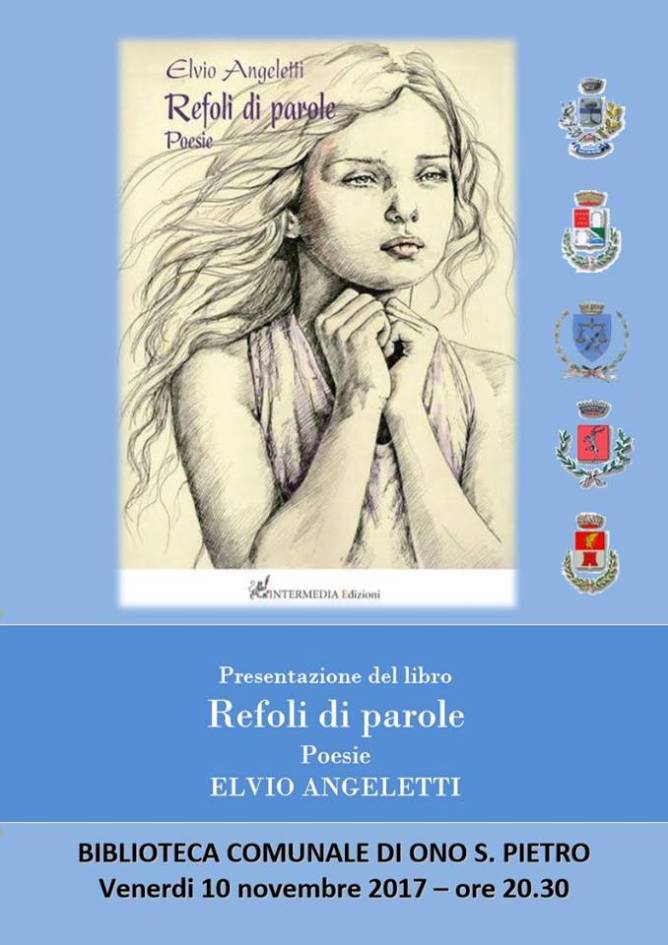





 Alessandra Gabbanelli (Loreto, 1976) vive e lavora a Porto Recanati (MC) presso un negozio di famiglia di pelletteria, accessori e valigeria. È laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Macerata in letteratura russa con la tesi “La narrativa di Fazil’ Iskander”.
Alessandra Gabbanelli (Loreto, 1976) vive e lavora a Porto Recanati (MC) presso un negozio di famiglia di pelletteria, accessori e valigeria. È laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Macerata in letteratura russa con la tesi “La narrativa di Fazil’ Iskander”. Nella seconda sezione, intitolata La paura della vita, sono due i temi sviluppati dalle ulteriori sottosezioni Le familiari e Discorsi d’amore. Nella prima sottosezione l’autore ci porta dentro un mondo intimo e autobiografico, avvolgendoci così con il calore e l’affetto della sua famiglia trasformandoci di conseguenza in suoi fratelli e sorelle. Accanto al tema del calore intimo c’è anche quello della dipartita, vista come paura, ma anche come nostra sorella. Nella seconda sottosezione l’Ausili tratta il tema dell’amore, da lui visto e concepito come qualcosa di divino. Un sentimento in cui la donna amata dal poeta anconetano si trasforma in una creatura ancestrale, dallo spirito oscuro e stregante, dallo sguardo purificatorio. Anche in questa seconda sottosezione c’è l’immagine della dipartita con la sua falce mietitrice, che adombra intensamente e pesantemente l’amore. Una dipartita dallo sguardo demoniaco, dalle carni scheletriche, ma allo stesso tempo dal cuore colmo di luminosità, che lascia nello spirito del poeta, solo e unicamente dolci reminiscenze e luminosi fantasmi, riguardanti la donna da lui amata.
Nella seconda sezione, intitolata La paura della vita, sono due i temi sviluppati dalle ulteriori sottosezioni Le familiari e Discorsi d’amore. Nella prima sottosezione l’autore ci porta dentro un mondo intimo e autobiografico, avvolgendoci così con il calore e l’affetto della sua famiglia trasformandoci di conseguenza in suoi fratelli e sorelle. Accanto al tema del calore intimo c’è anche quello della dipartita, vista come paura, ma anche come nostra sorella. Nella seconda sottosezione l’Ausili tratta il tema dell’amore, da lui visto e concepito come qualcosa di divino. Un sentimento in cui la donna amata dal poeta anconetano si trasforma in una creatura ancestrale, dallo spirito oscuro e stregante, dallo sguardo purificatorio. Anche in questa seconda sottosezione c’è l’immagine della dipartita con la sua falce mietitrice, che adombra intensamente e pesantemente l’amore. Una dipartita dallo sguardo demoniaco, dalle carni scheletriche, ma allo stesso tempo dal cuore colmo di luminosità, che lascia nello spirito del poeta, solo e unicamente dolci reminiscenze e luminosi fantasmi, riguardanti la donna da lui amata.