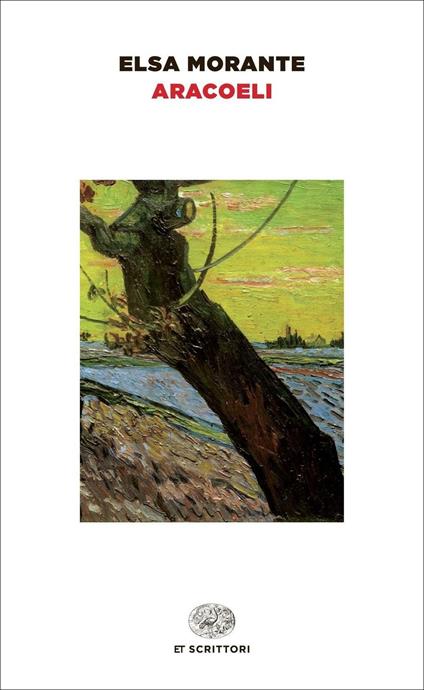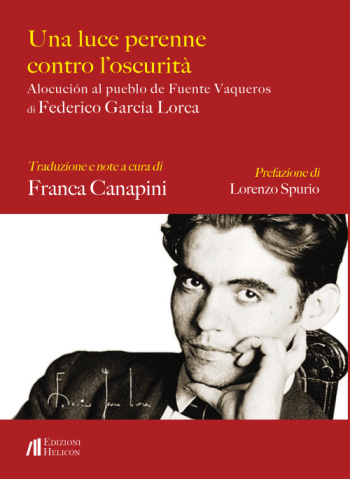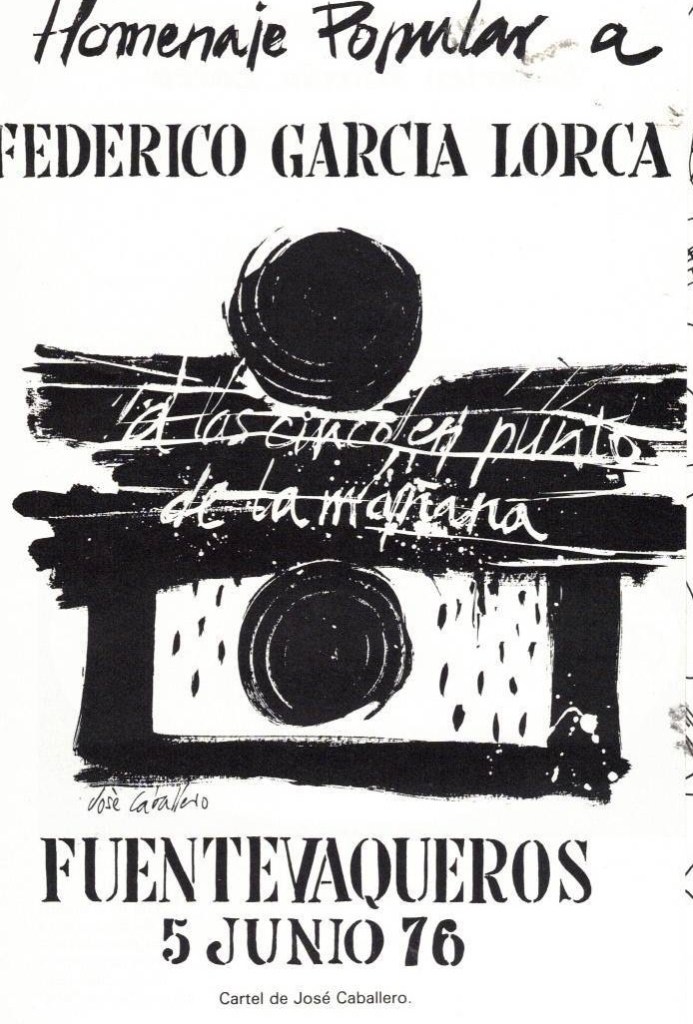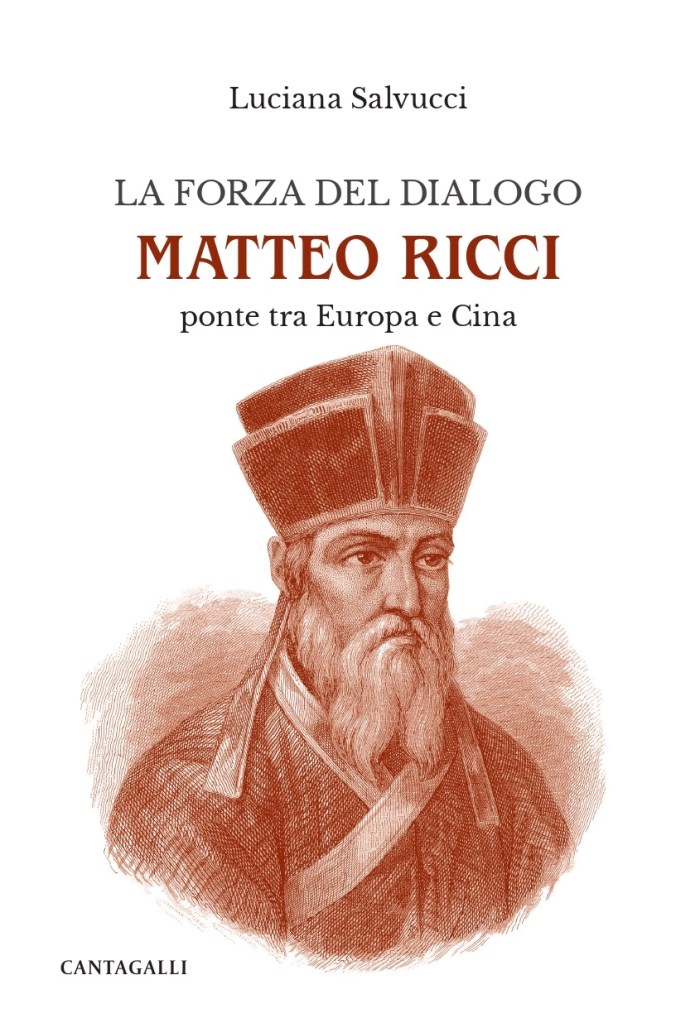XIV PREMIO NAZIONALE DI POESIA “L’ARTE IN VERSI”
Ideato, fondato e presieduto da Lorenzo Spurio
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Articolo 1
Il Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”, ideato, fondato e presieduto da Lorenzo Spurio e organizzato dall’Associazione Culturale Euterpe APS di Jesi (AN) è giunto alla sua quattordicesima edizione.
Il Premio è patrocinato moralmente dalla Regione Marche, dall’Assemblea Legislativa della Regione Marche, dalla Provincia di Ancona, dai Comuni di Jesi e Senigallia, dall’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino e dal Movimento Internazionale “Donne e Poesia” di Bari.
Articolo 2
Il Premio è articolato in sei macrosezioni al cui interno vi sono sottosezioni specifiche alle quali è possibile partecipare. Ciascuna macro-sezione è dedicata al ricordo di insigni poeti ed esponenti della cultura italiana contemporanea, alcuni dei quali già premiati – con premi speciali o d’altro tipo – in seno a questo premio letterario.
L’autore può prendere parte a una o più sottosezioni del Premio, anche afferenti a diverse macro-sezioni.
Articolo 3
L’organizzazione delle varie macro-sezioni e delle relative sotto-sezioni di cui all’art. 2 è così strutturata:
MACROSEZIONE A – “POESIA A TEMA LIBERO”
Dedicata al ricordo di Giusi Verbaro Cipollina (1938-2015)
A1 – Poesia singola [opere inedite]
A2 – Silloge di poesia [opere inedite]
A3 – Libro edito di poesia [opera edita]
A4 – Prosa poetica [opere inedite]
MACROSEZIONE B – “POESIA A TEMA”
Dedicata al ricordo di Amerigo Iannacone (1950-2017)
B1 – Poesia naturalistica [opere inedite]
B2 – Poesia d’amore [opere inedite]
B3 – Poesia religiosa [opere inedite]
B4 – Poesia civile [opere inedite]
MACROSEZIONE C – “LINGUA E POESIA”
Dedicata al ricordo di Alfredo Bartolomei Cartocci (1945-2022)
C1 – Poesia in dialetto [opere inedite]
C2 – Poesia in lingua straniera [opere inedite]
MACROSEZIONE D – “ARTE E POESIA”
Dedicata al ricordo di Aldo Piromalli (1946-2024)
D1 – Poesia visiva [opere inedite]
D2 – Foto poesia [opere inedite]
D3 – Video poesia [opere edite e inedite]
MACROSEZIONE E – “POESIA DI ORIGINE GIAPPONESE IN LINGUA ITALIANA”
Dedicata al ricordo di Pietro Tartamella (1948-2022)
E1 – Haiku [opere inedite]
E2 – Haibun [opere inedite]
E3 – Haiga [opere inedite]
MACROSEZIONE F – “POESIA E CRITICA LETTERARIA”
Dedicata al ricordo di Lucia Bonanni (1951-2024)
F1 – Recensione [opere edite e inedite]
F2 – Prefazione / postfazione [opere edite]
F3 – Saggio letterario [opere edite e inedite]
F4 – Libro edito di saggistica [opera edita]
Articolo 4
I minorenni partecipano a titolo gratuito. Per loro si richiede l’autorizzazione (scheda di partecipazione) compilata da almeno uno dei due genitori o da chi ne fa le veci e ne detiene la responsabilità genitoriale.
Articolo 5
Le modalità di partecipazione per ciascuna sottosezione ovvero la tipologia, il numero, la lunghezza dei testi, etc. sono specificate, per ciascuna sottosezione, nelle note a continuazione.
MACROSEZIONE A “POESIA A TEMA LIBERO”
Sezione A1 – Poesia singola: massimo nr. 3 opere in lingua italiana a tema libero inedite e prive di dati personali. Ciascuna opera non dovrà superare la lunghezza di 30 versi senza conteggiare il titolo ed eventuali dediche e dovrà comparire su un file Word singolo.
Sezione A2 – Silloge di poesia: massimo nr. 1 silloge composta da un numero di poesie in italiano a tema libero comprese tra 20 e 30 inedite e di dati personali. La silloge dovrà essere dotata di titolo e dovrà comparire in un unico file Word.
Sezione A3 – Libro edito di poesia: massimo nr. 1 opera edita di poesia in lingua italiana a tema libero pubblicata in un periodo non precedente al 2019 da una casa editrice o un self-publishing e dotata di codice identificativo ISBN. L’opera va inviata in due file: l’interno del libro in formato PDF e la copertina (stesa o frontale) in formato PDF o immagine (JPG) e NON dovrà essere inviata in cartaceo.
Sezione A4 – Prosa poetica: massimo nr. 3 opere in lingua italiana a tema libero inedite e prive di dati personali. Si rappresenta che l’opera dovrà configurarsi come un testo in prosa (no versi) di lunghezza non superiore a 1.800 battute spazi inclusi nella quale l’elemento narrativo rappresenti un aspetto marginale e secondario a beneficio degli elementi più marcatamente riflessivi e descrittivi che possano far risaltare gli aspetti emozionali e sensoriali, dando sfogo alla propria interiorità prediligendo composizioni costruite su un piano lirico di chiaro impatto. Non saranno conformi a tale sezione racconti canonicamente intesi, fondati prevalentemente sulla costruzione del personaggio (fiction) o la narrazione di episodi (storytelling).
MACROSEZIONE B – “POESIA A TEMA”
Sezione B1 – Poesia naturalistica: massimo nr. 3 opere in lingua italiana a tema “la natura” (liberamente intesa) inedite e prive di dati personali. Ciascuna opera non dovrà superare la lunghezza di 30 versi senza conteggiare il titolo ed eventuali dediche e dovrà comparire su un file Word singolo.
Sezione B2 – Poesiad’amore: massimo nr. 3 opere in lingua italiana a tema “l’amore” (liberamente intesa) inedite e prive di dati personali. Ciascuna opera non dovrà superare la lunghezza di 30 versi senza conteggiare il titolo ed eventuali dediche e dovrà comparire su un file Word singolo.
Sezione B3 – Poesia religiosa: massimo nr. 3 opere in lingua italiana a tema religioso (liberamente inteso) inedite e prive di dati personali. Ciascuna opera non dovrà superare la lunghezza di 30 versi senza conteggiare il titolo ed eventuali dediche e dovrà comparire su un file Word singolo.
Sezione B4 – Poesia civile: massimo nr. 3 opere in lingua italiana a tema civile (liberamente inteso) inedite e prive di dati personali. Ciascuna opera non dovrà superare la lunghezza di 30 versi senza conteggiare il titolo ed eventuali dediche e dovrà comparire su un file Word singolo.
MACROSEZIONE C – “LINGUA E POESIA”
Sezione C1 – Poesia in dialetto: massimo nr. 3 opere in dialetto (specificare il tipo di dialetto e la zona geografica dove viene parlato) inedite e prive di dati personali. Ciascuna opera non dovrà superare la lunghezza di 30 versi senza conteggiare il titolo ed eventuali dediche e dovrà comparire su un file Word singolo. È requisito fondamentale allegare, in altrettanti file Word singoli ciascuno per ogni opera, la traduzione in italiano di ciascuna poesia in dialetto presentata.
Sezione C2 – Poesia in lingua straniera: massimo nr. 3 opere in lingua straniera (specificare la lingua) inedite e prive di dati personali. Ciascuna opera non dovrà superare la lunghezza di 30 versi senza conteggiare il titolo ed eventuali dediche e dovrà comparire su un file Word singolo. È requisito fondamentale allegare, in altrettanti file Word singoli ciascuno per ogni opera, la traduzione in italiano di ciascuna poesia in lingua straniera presentata.
MACROSEZIONE D – “ARTE E POESIA”
Sezione D1 – Poesia visiva: massimo nr. 3 opere in italiano inedite e prive di dati personali. Ciascuna opera non dovrà superare la lunghezza di 30 versi senza conteggiare il titolo ed eventuali dediche e dovrà comparire su un file Word singolo. Si rappresenta che, sulla scia dei noti “Calligrammi” di Apollinaire, l’opera dovrà avere una disposizione particolare sul fondo bianco, con particolare attenzione all’aspetto estetico atto a rivelare forme, immagini, possibili simboli, in una combinazione di linguaggi tra poesia e grafia, contenuto e gesto.
Sezione D2 – Foto poesia: massimo nr. 3 opere in italiano inedite e prive di dati personali. Ciascuna opera non dovrà superare la lunghezza di 30 versi senza conteggiare il titolo ed eventuali dediche e dovrà comparire su un file Word singolo. La poesia deve essere abbinata a una foto di propria produzione (affiancata, sovrapposta, in filigrana, o altra posizione): è fondamentale che vi siano i due elementi: testuale e fotografico e che vi sia una correlazione o un contrasto volti al messaggio da comunicare e a difendere l’intenzione espressiva dell’autore.
Sezione D3 – Video poesia:massimo nr. 1 opera in italiano a tema libero edita o inedita della lunghezza massima di 4 minuti. L’opera dovrà essere inviata con una di queste due modalità: 1) inviare il link (URL) di YouTube dove figura il video; 2) allegare l’opera nei soli formati AVI, MP4, WMV mediante WeTransfer. Nel caso della modalità di invio nr. 1 si rappresenta che il link non dovrà essere modificato né rimosso per tutta la durata di svolgimento del Premio, pena la squalifica.
MACROSEZIONE E – “POESIA DI ORIGINE GIAPPONESE IN LINGUA ITALIANA”
Sezione E1 – Haiku: massimo nr. 3 opere in lingua italiana inedite a tema libero, prive di dati personali, con la canonica struttura di tre versi di 5/7/5 sillabe. Il computo sillabico che può essere adottato è o il conteggio ortografico o quello metrico. I componimenti devono essere provvisti del termine stagionale (kigo) o del tema stagionale (kidai). Ciascuna opera dovrà comparire su un file Word singolo.
Sezione E2 – Haibun: massimo nr. 3 opere in lingua italiana inedite, prive di dati personali, redatte o nella forma classica (kiko haibun), ovvero sotto forma di diario di viaggio, o nella forma del bozzetto, in grado di presentare in modo succinto luoghi, ambientazioni o persone familiari. La lunghezza massima di ciascun componimento non dovrà eccedere le 3.600 battute spazi inclusi. Ciascuna opera dovrà comparire su un file Word singolo.
Sezione E3 – Haiga: massimo nr. 3 opere in lingua italiana inedite a tema libero, prive di dati personali, in cui sia previsto l’accostamento di uno haiku a un’immagine, sia essa un dipinto, un disegno o una foto. Lo haiku dovrà rispettare la canonica struttura di tre versi di 5/7/5 sillabe. Nello haiga non deve esserci un’eccessiva ridondanza tra l’immagine scelta e lo haiku, piuttosto le due espressioni devono creare un insieme integrato in modo che l’una sarebbe incompleta senza l’altra e viceversa. Ciascuna opera dovrà comparire su un file Word singolo.
MACROSEZIONE F – “POESIA E CRITICA LETTERARIA”
Sezione F1 – Recensione: massimo nr. 2 opere in lingua italiana a tema libero, edite o inedite e prive di dati personali, ciascuna della lunghezza massima di 5.400 battute spazi inclusi. Si potrà inviare unicamente recensioni a libri di poesia (di autori locali, nazionali o stranieri; classici, contemporanei o esordienti) e all’inizio dell’opera debbono necessariamente essere indicati in maniera precisa e completa i dati del libro (titolo, nome e cognome autore, editore, anno di pubblicazione). Ciascuna opera va inserita in un file WORD singolo.
Sezione F2 – Prefazione / Postfazione: massimo nr. 2 opere in lingua italiana a tema libero edite (perché pubblicate nel volume di poesia) ciascuna della lunghezza massima di 5.400 battute spazi inclusi. Si potrà inviare unicamente prefazioni e postfazioni a libri di poesia (di autori locali, nazionali o stranieri; classici, contemporanei o esordienti) e all’inizio dell’opera debbono necessariamente essere indicati in maniera precisa e completa i dati del libro (titolo, nome e cognome dell’autore, editore, anno di pubblicazione) e dell’autore che ha stilato la prefazione/postfazione. Ciascuna opera va inserita in un file WORD singolo.
Sezione F3 – Saggio letterario: massimo nr. 2 opere in lingua italiana a tema libero inedite e prive di dati personali, ciascuna della lunghezza massima di 9.000 battute spazi inclusi. Si potrà inviare un saggio di critica letteraria su autori e opere della poesia locale, nazionale e internazionale, di autori classici, contemporanei o esordienti. Ciascuna opera va inserita in un file WORD singolo.
Sezione F4 – Libro edito di saggistica: massimo nr. 1 opera in lingua italiana vertente su autori e opere della poesia locale, nazionale, internazionale, di autori classici, contemporanei o esordienti. L’opera dovrà essere stata pubblicata in un periodo non precedente al 2019 da una casa editrice o un self-publishing e dotata di codice identificativo ISBN. L’opera va inviata in due file: l’interno del libro in formato PDF e la copertina (stesa o frontale) in formato PDF o immagine (JPG) e NON dovrà essere inviata in cartaceo.
Articolo 6
È fatto divieto di partecipare, pena l’esclusione, ai soci fondatori, ai soci onorari, ai Consiglieri (in carica o passati) dell’Associazione Culturale Euterpe APS e ai Presidenti di Giuria attivi o passati del presente premio.
Saranno, altresì, escluse tutte le opere che presentino elementi razzisti, xenofobi, denigratori, pornografici, blasfemi, di offesa alla morale e al senso civico, d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo o che fungano da proclami ideologici, partitici e politici.
Articolo 7
Per prendere parte al Premio è richiesto un contributo di € 20,00 (VENTI//00) che è comprensivo della quota sociale annualità 2026 a Euterpe Aps di Jesi (AN) e del contributo di adesione per la prima sottosezione alla quale si partecipa. Per ogni sottosezione aggiuntiva alla quale si decide di aderire andrà corrisposto un ulteriore contributo pari a € 5,00 (CINQUE//00). È possibile partecipare a più sottosezioni corrispondendo il relativo contributo in un unico pagamento.
L’inoltro del contributo potrà avvenire mediante:
Bollettino postale – CC n°1032645697
Intestazione: Euterpe APS
Causale: Quota sociale e contributo XIV Premio “L’arte in versi” – nome e cognome del partecipante (se diverso dall’ordinante del pagamento)
Bonifico – IBAN: IT31H0760102600001032645697
BIC / SWIFT: BPPIITRRXXX (per bonifici dall’estero)
Intestazione: Euterpe APS
Causale: Quota sociale e contributo XIV Premio “L’arte in versi” – nome e cognome del partecipante (se diverso dall’ordinante del pagamento)
Articolo 8
I materiali per partecipare al Premio sono:
- la scheda di partecipazione adeguatamente compilata in ogni parte e sottoscritta in originale;
- la copia del pagamento effettuato;
- i file delle opere in linea con i requisiti indicati in tabella.
Essi dovranno pervenire unicamente a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica premiodipoesialarteinversi@gmail.com entro il 31 maggio 2026, indicando quale oggetto della comunicazione “Partecipazione al XIV Premio di Poesia L’arte in versi”.
Articolo 9
Le commissioni di Giuria, diversificate per le varie sottosezioni, sono presiedute da Michela Zanarella e sono costituite da poeti, scrittori, critici, giornalisti e promotori culturali a livello nazionale: Stefano Baldinu, Cristina Banella, Fabia Binci, don Luca Buzziol, Valtero Curzi, Mario De Rosa, Graziella Enna, Zairo Ferrante, Filomena Gagliardi, Rosa Elisa Giangoia, Fabio Grimaldi, Giuseppe Guidolin, Francesca Innocenzi, Antonio Maddamma, Simone Magli, Emanuele Marcuccio, Francesco Martillotto, Antonio Sacco, Rita Stanzione e Laura Vargiu.
Articolo 10
Per ciascuna sottosezione saranno assegnati premi da podio (1°, 2° e 3° premio) rappresentati da targa personalizzata, diploma e motivazione della Giuria e alcune menzioni d’onore rappresentate da medaglia e diploma.
Verranno altresì assegnati alcuni Premi Speciali: il Premio del Presidente di Giuria, il Premio della Critica, il “Trofeo Euterpe”, il Premio “Picus Poeticum” (assegnato alla migliore opera di un autore marchigiano) e il Premio “Donne e Poesia” (donato dal Movimento Internazionale “Donne e Poesia” di Bari presieduto dalla poetessa e scrittrice prof.ssa Anna Santoliquido).
Il poeta/la poetessa a cui verrà attribuito il Premio Speciale “Alla Carriera” verrà invitato nel corso del 2027 a presentare la sua opera in un evento dedicato organizzato dal Movimento Internazionale “Donne e Poesia” che si terrà a Bari o provincia e del quale si forniranno maggiori informazioni in seguito.
Nel caso in cui non sarà pervenuta una quantità di testi numericamente congrua o qualitativamente significativa per una sottosezione, la Giuria, a sua unica discrezione, si riserva di stabilire un’unica graduatoria per macrosezione o di non attribuire determinati premi.
Tutte le opere premiate verranno pubblicate nell’antologia del Premio, volume disponibile gratuitamente il giorno della premiazione.
Fuori concorso verranno assegnati i Premi Speciali “Alla Memoria”, “Alla Cultura” e “Alla Carriera” a insigni poeti del nostro Paese, su unica proposta del Presidente del Premio. Non si accetteranno candidature in tal senso.
Articolo 11
Per gli obblighi di pubblicità e trasparenza il presente bando di partecipazione, così come il verbale di Giuria, vengono pubblicati e diffusi su questi spazi online:
Sito del Premio – www.premiodipoesialarteinversi.blogspot.com
Sito dell’Associazione Culturale Euterpe APS – www.associazioneeuterpe.com
Blog Letteratura e Cultura – www.blogletteratura.com
Pro Letteratura e Cultura – www.proletteraturacultura.com
Concorsiletterari.it – www.concorsiletterari.it
Concorsiletterari.net – www.concorsiletterari.net
e sulle relative pagine Social ad essi collegate.
Qualsivoglia richiesta inerente al Premio dovrà essere presentata unicamente in forma scritta adoperando la mail premiodipoesialarteinversi@gmail.com
Articolo 12
La cerimonia di premiazione si terrà nelle Marche in un fine settimana di novembre 2026.
I vincitori e i premiati a vario titolo sono tenuti a presenziare alla cerimonia per ritirare il premio. Qualora non possano intervenire hanno facoltà d’inviare un delegato. Non sarà possibile delegare membri della Giuria e familiari diretti degli stessi. Un delegato non potrà avere più di due deleghe da altrettanti autori vincitori assenti. Non verranno considerate le deleghe annunciate in via informale ma unicamente a mezzo mail.
I premi non ritirati personalmente né per delega potranno essere spediti a domicilio (sul solo territorio nazionale) mediante Corriere Fedex, previo pagamento delle relative spese di spedizione a carico dell’interessato. In nessuna maniera si spedirà in contrassegno.
Alla scadenza naturale dei termini entro i quali l’Associazione si è impegnata a inviare i premi, qualora questi non siano stati richiesti, gli stessi entreranno nelle disponibilità dell’ente organizzatore che potrà disporne come meglio crede nel corso della sua attività.
Articolo 13
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n°2016/679 (GDPR) il partecipante acconsente al trattamento, diffusione e utilizzazione dei dati personali da parte della Segreteria del Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” che li utilizzerà per i fini inerenti al concorso in oggetto e per iniziative culturali e letterarie analoghe organizzate dall’Associazione Culturale Euterpe APS di Jesi.
Dott. Lorenzo Spurio – Ideatore e Presidente del Premio
Dott.ssa Michela Zanarella – Presidente di Giuria
Dott. Stefano Vignaroli – Presidente Associazione Culturale Euterpe APS di Jesi
Prof.ssa Anna Santoliquido – Presidente Movimento “Donne e Poesia” di Bari
Info: premiodipoesialarteinversi@gmail.com
Sito internet: https://premiodipoesialarteinversi.blogspot.com/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/arteinversi
Scheda di partecipazione
XIV PREMIO NAZIONALE DI POESIA “L’ARTE IN VERSI” Edizione 2026
Nome/Cognome _________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il__________________________
Residente in via _________________________________________________________________
Città _____________________________ Cap ___________________Provincia______________
Tel. ______________________________________ E-mail _______________________________
Partecipo alla/e macrosezione/i – sottosezione/i:
MACROSEZIONE A – “POESIA A TEMA LIBERO”
□ A1 – POESIA SINGOLA _________________________________________________________
□ A2 – SILLOGE DI POESIA ________________________________________________________
□ A3 – LIBRO EDITO DI POESIA ____________________________________________________
□ A4 – PROSA POETICA __________________________________________________________
MACROSEZIONE B – “POESIA A TEMA”
□ B1 – POESIA NATURALISTICA ___________________________________________________
□ B2 – POESIA D’AMORE _________________________________________________________
□ B3 – POESIA RELIGIOSA ________________________________________________________
□ B4 – POESIA CIVILE ____________________________________________________________
MACROSEZIONE C – “LINGUA E POESIA”
□ C1 – POESIA IN DIALETTO ______________________________________________________
□ C2 – POESIA IN LINGUA STRANIERA ______________________________________________
MACROSEZIONE D – “ARTE E POESIA”
□ D1 – POESIA VISIVA ____________________________________________________________
□ D2 – FOTOPOESIA _____________________________________________________________
□ D3 – VIDEOPOESIA ____________________________________________________________
MACROSEZIONE E – “POESIA DI ORIGINE GIAPPONESE IN LINGUA ITALIANA”
□ E1 – HAIKU
□ E2 – HAIBUN
□ E3 – HAIGA
MACROSEZIONE F – “POESIA E CRITICA LETTERARIA”
□ F1 – RECENSIONE _____________________________________________________________
□ F2 – PREFAZIONE / POSTFAZIONE _______________________________________________
□ F3 – SAGGIO LETTERARIO ______________________________________________________
□ F4 – LIBRO EDITO DI SAGGISTICA ________________________________________________
Data_________________________________ Firma ___________________________________
L’autore è iscritto/ tutelato dalla SIAE? □ Sì □ No
I testi presentati al concorso sono depositati alla SIAE? □ Sì □ No
Se Sì indicare quali testi: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE (PER I PARTECIPANTI DI TUTTE LE SEZIONI)
□ Esprimo la mia volontà di partecipare al Premio in oggetto e, in linea con quanto predisposto dal bando, manifesto la mia intenzione di aderire all’Associazione Culturale Euterpe APS di Jesi divenendone socio per l’annualità 2026 mediante il contributo che mi autorizza a prendere parte al Premio.
□ Dichiaro che le opere NON presentano in nessuna forma elementi che possano rimandare a una lettura, interpretazione e/o richiamo a impostazioni ideologiche di tipo razziste, xenofobe, denigratorie, pornografiche, blasfeme, di offesa alla morale e al senso civico, d’incitamento all’odio o alla differenza e all’emarginazione, nonché di tipo politico, partitico o di ogni altra impostazione e fazione che possa richiamare un clima di violenza, lotta, incomprensione, intolleranza e insubordinazione.
□ Dichiaro che i testi presentati sono frutto del mio unico ingegno e che ne detengo a ogni titolo i diritti.
□ Autorizzo la Segreteria del Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” a pubblicare in cartaceo i miei testi all’interno dell’opera antologica del Premio, qualora risultassi premiato, senza nulla avere a pretendere né ora né in futuro.
□ Autorizzo l’Associazione Culturale Euterpe APS di Jesi (AN) al trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della privacy (D.Lgs n. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR) allo scopo del concorso in oggetto e per future iniziative culturali indette dalla medesima.
Data_________________________________ Firma ___________________________________
XIV PREMIO NAZIONALE DI POESIA “L’ARTE IN VERSI”
EDIZIONE 2026
ULTERIORE DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE
PER I SOLI PARTECIPANTI DELLE SEZIONI D1, D2 E D3
[POESIA VISIVA FOTO POESIA E VIDEO POESIA]
Nome/Cognome _________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il__________________________
Residente in via _________________________________________________________________
Città _____________________________ Cap ___________________Provincia______________
Tel. ______________________________________ E-mail _______________________________
□ Dichiaro, sotto la mia unica responsabilità, di aver fatto uso, nell’elaborazione della poesia visiva / foto poesia / video poesia di immagini/video/suoni e altri materiali di mia esclusiva proprietà o di dominio pubblico o, laddove abbia usufruito di materiali di terzi, di aver provveduto a richiedere e aver ottenuto la relativa liberatoria dagli autori per l’autorizzazione a usarli nell’elaborazione della mia opera presentata a questo concorso, sollevando in toto l’Organizzazione da qualsiasi attribuzione di paternità e disputa possa nascere.
Per i partecipanti della sezione D3 (video poesia):
□ Dichiaro, sotto la mia unica responsabilità, di NON aver fatto uso di brani, musiche, canzoni, melodie iscritte/tutelate dalla SIAE nella mia video poesia.
Altre notizie e informazioni che si ritiene di appuntare in merito alla propria opera:
Data_________________________________ Firma ___________________________________
ALBO D’ORO DEI PREMI SPECIALI DEL PREMIO
III edizione (2014)[1]
Premio alla Cultura – non assegnato
Premio alla Carriera – Sandra Carresi – Bagno a Ripoli (FI)
Premio alla Memoria – non assegnato
IV edizione (2015)
Premio alla Cultura – non assegnato
Premio alla Carriera – Marisa Provenzano (1950-2020) – Catanzaro
Premio alla Memoria – Novella Torregiani Grilli (1935-2015) – Porto Recanati (MC)
Premio alla Memoria – Bruno Epifani (1935-1984) – Novoli (LE)
V edizione (2016)
Premio alla Cultura – non assegnato
Premio alla Carriera – Donatella Bisutti – Milano
Premio alla Memoria – Pasquale Scarpitti (1923-1973) – Castel di Sangro (AQ)
Premio alla Memoria – Giusi Verbaro Cipollina (1938-2015 – Catanzaro
VI edizione (2017)
Premio alla Cultura – non assegnato
Premio alla Carriera – Dante Maffia – Roma
Premio alla Memoria – Alessandro Miano (1920-1994) – Milano
Premio alla Memoria – Maria Costa (1926-2016) – Messina
VII edizione (2018)
Premio alla Cultura – non assegnato
Premio alla Carriera – Anna Santoliquido – Forenza (PZ)
Premio alla Memoria – Gian Mario Maulo (1943-2014) – Macerata
Premio alla Memoria – Amerigo Iannacone (1950-2017) – Venafro (IS)
VIII edizione (2019)
Premio alla Cultura – Rosanna Di Iorio – Chieti
Premio alla Carriera – Márcia Theóphilo – San Paolo del Brasile / Roma
Premio alla Memoria – Maria Ermegilda Fuxa (1913-2004) – Alia (PA)
Premio alla Memoria – Silvio Bellezza (1941-2000) – Lanzo Torinese (TO)
Premio alla Memoria – Salvatore Toma (1951-1987) – Maglie (LE)
IX edizione (2020)
Premio alla Cultura – Francesca Luzzio – Palermo
Premio alla Carriera – Matteo Bonsante – Polignano a Mare (BA)
Premio alla Memoria – Biagia Marniti (1921-2006) – Ruvo di Puglia (BA)
Premio alla Memoria – Simone Cattaneo (1974-2009) – Saronno (VA)
X edizione (2021/2022)
Premio alla Cultura – Anna Manna Clementi – Roma
Premio alla Carriera – Guido Oldani – Melegnano (MI)
Premio alla Memoria – Veniero Scarselli (1931-2015) – Firenze
Premio alla Memoria – Domenico Carrara (1987-2021) – Atripalda (AV)
XI edizione (2022/2023)
Premio alla Cultura – non assegnato
Premio alla Carriera – Nadia Cavalera – Galatone (LE)
Premio alla Memoria – Giovanni Giuseppe Battaglia (1951-1995) – Aliminusa (PA)
Premio alla Memoria – Arnaldo Ederle (1936-2019) – Padova
XII edizione (2023/2024)
Premio alla Cultura – Elvio Grilli – Fano (PU)
Premio alla Carriera – Elio Pecora – Roma
Premio alla Memoria – Alfredo Bartolomei Cartocci (1945-2022) – Ancona
XIII edizione (2024/2025)
Premio alla Cultura – Maria Benedetta Cerro – Pontecorvo (FR)
Premio alla Carriera – Giuliano Ladolfi – Novara
Premio alla Memoria – Anna Maria Fabbroni (1939-2023) – Grosseto / Gorizia
Info: premiodipoesialarteinversi@gmail.com
Sito internet: https://premiodipoesialarteinversi.blogspot.com/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/arteinversi
[1] Nella prima e nella seconda edizione del Premio non sono stati attribuiti Premi Speciali.