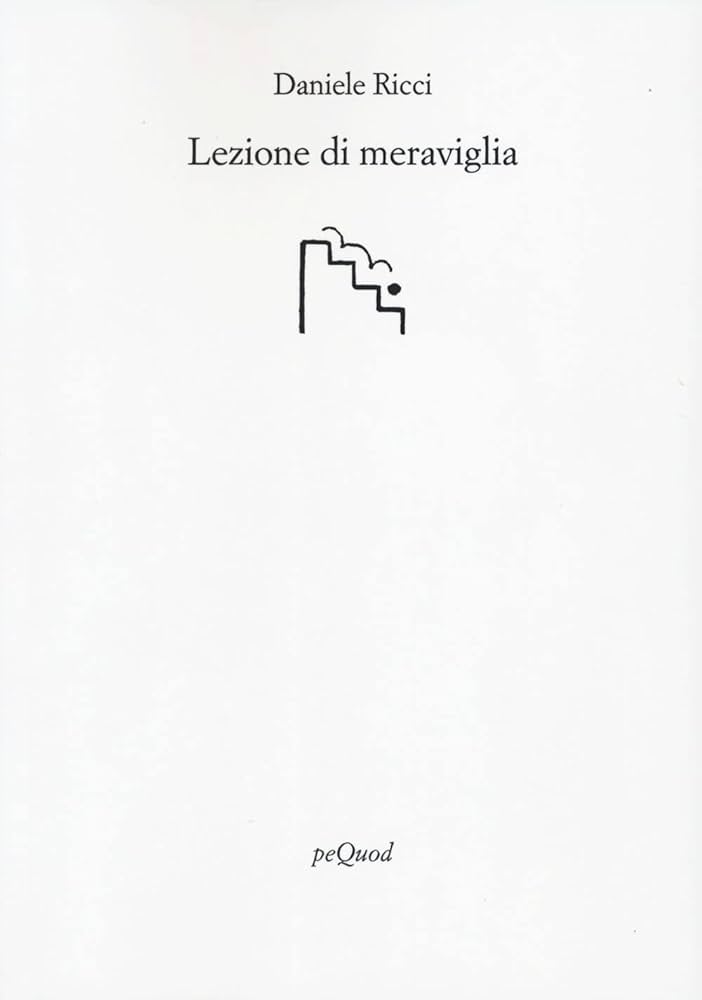
I cinque versi iniziali di Lezione di meraviglia di Daniele Ricci ne preannunciano subito tutta la vastità d’orizzonti: «Finalmente questa notte esco dal romitorio. / Faccio ricorso al tuo φάρμακον / per varcare le porte. // Vado al mare / del mio dolore amaranto».
Ci torna subito in mente l’ultima scena dei Malavoglia, in cui il giovane ’Ntoni misura la sua esclusione dall’ambiente d’origine gettando un’occhiata sul mare «che s’era fatto amaranto». Mare amaranto verghiano che era ancora quello omerico color del vino, il mare ancestrale e sacro di una tradizione millenaria, che il poeta simbolicamente riattraversa nelle prime due sezioni di questa raccolta (Lezione di meraviglia e La strada del ritorno) raccontandoci un viaggio in Grecia – ma del viaggio ciò che qui si vede è in realtà solo la bianca nave, il viaggio in sé, mentre i «bianchi palazzi di Atene / le strade trafficate del Pireo» restano piuttosto sullo sfondo, come tracce marginali e fugaci di un incontro che si direbbe fisicamente mancato, nella Grecia odierna, con la classicità. Il phàrmakon menzionato al secondo verso è invece la poesia, veleno e rimedio al tempo stesso (nell’ambiguità del termine greco), mentre la meraviglia del titolo è il thaumàzein da cui secondo Aristotele nasce ogni interrogazione sul mondo.
Sono in tutto sette, le sezioni di questa raccolta, e ciascuna ha un suo cuore di sperimentazione discreta, i cui estremi opposti sono l’autobiografismo diretto della IV sezione, Semi non custoditi («Poi / cos’è successo in quinta elementare? / Che cosa m’ha fatto cambiare? // Sono diventato triste e taciturno… // Qualcosa m’ha fermato»), e la poesia senza io di Poemetto (V sezione, Approdi e amore), le cui terzine hanno invece quasi voce d’aforismi(«Il non senso contamina il senso. / L’amore appartiene all’enigma, / l’enigma alla follia»).
Le altre sezioni dosano in vario modo questi estremi, anche in una serie di preziosi richiami a distanza che danno compattezza all’opera. Si veda il caso seguente: «Ieri in cielo ho visto l’Aquilone… // Te ne sei andata nel buio nulla / senza lasciare traccia, / senza briscola né punti» (dalla III sezione, Il tuffatore di Paestum); «Hai spento la luce della tua stanza / e le stelle dell’Aquilone» (dalla VI sezione, Ho imparato a piangere).
In una delle versioni del mito, che si fa risalire a Eratostene, l’Aquilone è Arcas, che accompagna in cielo la madre Callisto trasformata in orsa – ma qui è anche l’oggetto evocato dalla costellazione (lo è senz’altro in Come un aquilone, da Semi non custoditi: «Non potrò mai unirmi / al cielo / alle traiettorie del tuo volo»). In ogni caso il tema della perdita, della scomparsa della madre, dell’elaborazione del lutto proiettato in una dimensione celeste pagano-cristiana, è uno dei motivi-chiave della raccolta, l’urgenza che si avverte più immediata per un ritorno alla scrittura poetica e all’uscita dal romitorio. Pressanti domande di senso, sull’«ἀρχή della vita» (Nella camera del mattino, II sezione), in un costante «dialogo con la notte» (Bagno fuori stagione, VII sezione, Fuori stagione), attraversano l’intera raccolta, allargando progressivamente il campo dal dolore privato a quello collettivo, dal gesto disperato delle donne afghane che lanciano i loro bambini ai soldati inglesi all’aeroporto di Kabul già occupato dai talebani (La fuga tentata, II sezione, e I giorni, VII) alla guerra in Ucraina (Boristene, VII, dal nome greco del Dnepr).
Daniele Ricci è poeta colto, come d’altra parte lo sono tutti i grandi della nostra tradizione, perché il sentire verrà pure dall’enigmatico io latore d’ogni verità e d’ogni inganno, ma le parole per esprimerlo vanno munte a quella tradizione millenaria con cui è sempre doveroso fare i conti. C’è un fondo costante, nelle sue poesie, un sapore di lirica eterna che viene dagli antichi Greci, in particolare da Omero e dai poeti arcaici (l’incontro con la classicità che riesce su un altro piano rispetto a quello del viaggio fisico), su cui si innesta il presente drammatico (la madre e il lutto, le donne di Kabul, la guerra in Ucraina) che rimescola invece voci più moderne, il Montale da Satura in poi, i poeti italiani contemporanei («la voltura delle utenze di mia madre / per la mia crescita interiore»; i «cedolini del silenzio»). Mentre l’analogismo della lirica pura novecentesca viene praticato con grande parsimonia, restando per lo più confinato a campi inediti. Il principale è il gioco del calcio, che suggerisce immagini inesauribili e mai banali («Aspetto di battere / l’ultimo calcio di rigore, / sarà concesso all’alba / di questa notte senza camomilla»; «un ultimo verso / per cercare / la rete della salvezza»), nonché liriche memorabili come La partita eterna (IV).
Daniele Ricci, insomma, coniuga al presente una voce che sembra d’ogni tempo, costruendo una miscela linguistica originale e avvolgente. La poesia resiste al «canto del nulla» che «scappa via / tra le repliche e gli ingorghi / di una lingua agonizzante» (Il dolore sul cuscino, IV). Lui ci dice: «Voglio tessere un abito nuovo / sulla pelle del mondo» (Mi sono perduto, V).
E questo è anche quello che effettivamente fa.
Questo testo viene pubblicato nella sezione “Rivista Nuova Euterpe” del sito “Blog Letteratura e Cultura” perché selezionato dalla Redazione della Rivista “Nuova Euterpe”, n°02/2024. L’autore ha autorizzato alla pubblicazione senza nulla avere a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro.
