Affrontando il discorso sull’affascinante connubio di poesia e spiritualità, il pensiero non può non correre alla tradizione poetica sufi di ambito islamico. Al suo interno spicca in particolare l’opera di Rumi, tra i massimi poeti mistici della letteratura persiana.
Una breve, ma necessaria premessa: il sufismo, la corrente mistica dell’Islam, affonda le sue radici in un’epoca assai lontana, man mano che prese a diffondersi la nuova fede a partire dalle grandi conquiste arabe; sufi è il mistico musulmano, così chiamato per via degli indumenti di lana ruvida indossati dai primi asceti (la parola araba sūf, infatti, significa “lana”). La poesia sufi si contraddistingue per il suo messaggio di pace universale, l’amore verso Dio, cui ci si rivolge in maniera incessante, e la sua contemplazione, lungo un percorso ascetico e spirituale che conduce l’uomo a prendere coscienza della propria dimensione cosmica. In generale, si tratta di un tema alquanto complesso, nonché di nicchia, ma ciò non impedisce di leggere con estremo piacere le importanti opere letterarie nate in seno appunto al sufismo. E tra queste, come anticipato sopra, non può mancare quella di Rumi.
“Dopo la morte, non cercare la tomba mia nella terra: nel petto degli uomini santi è il sepolcro mio!”
Nato in una famiglia di lingua persiana in territorio afghano agli inizi del nostro XIII secolo, Jalal ad-Din Muhammad Balkhi meglio noto con il nome di Rumi, fu teologo e poeta, nonché fondatore della confraternita sufi dei famosi dervisci danzanti. A parte una serie di spostamenti in varie località del mondo islamico in determinati periodi della sua esistenza, egli visse a Konya, nell’attuale Turchia, dove morì nel 1273.
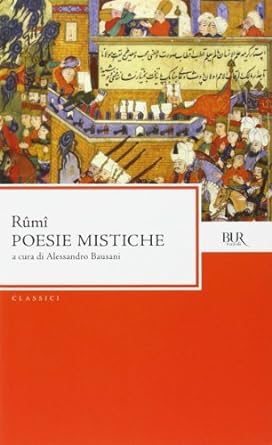
Due sono le sue opere principali, entrambe di notevoli dimensioni: il lungo poema a rime baciate denominato Masnavi e il Dīwān; un breve, ma significativo estratto di quest’ultimo titolo è rappresentato dalla raccolta antologica Poesie mistiche, pubblicata agli inizi degli anni Ottanta dalla casa editrice Rizzoli a cura e traduzione di Alessandro Bausani (1921-1988), nome senza dubbio tra i più importanti dell’orientalistica italiana.
Il Dīwān (Canzoniere) di Rumi è costituito da un numero impressionante di odi per un totale di circa cinquantamila distici distribuiti in numerosi volumi. L’opera, per forma e contenuti, rientra nei canoni classici della lirica persiana, riprendendo metri e simboli a essa tutt’altro che estranei. Un’emozione particolare, tuttavia, permea i versi del poeta che risuonano con pregevole originalità, mentre spezzano rigidità per così dire tecniche e conducono – come sottolinea il curatore dell’antologia – “a licenze poetiche non sempre perfettamente «canoniche»”.
“[…] O viandante! Non legare il cuore a nessuna dimora,/ perché soffrirai quando te ne strapperanno via./ E poi che tante dimore hai percorso/ da quando eri goccia di sperma fino all’adolescenza,/ prendile a scherzo, che a scherzo le possa lasciare:/ rinuncerai a poca cosa e alto compenso ne avrai!/ Prendi invece sul serio Colui che ti ha preso sul serio;/ Primo è Lui ed ultimo: cerca Lui solo! […]”.
L’Islam, cultura alla quale Rumi appartiene per nascita, in queste pagine è presenza certa e costante attraverso riferimenti espliciti (come alla Fātiha, sura aprente del Corano, alla qibla, la direzione verso cui il devoto musulmano prega ogni giorno, o ancora alla Ka’ba meccana stessa) che contribuiscono a dar vita a scenari orientali di notevole fascino in un intreccio di immagini variegate che abbracciano distese di cieli e deserti, colori di aurore e tramonti, ombre di carovane, voli di falco e profumi di giardini fioriti; quello di Rumi, popolato tanto da maestri spirituali quanto da cammellieri, è un mondo semplice dove l’anelito verso il divino si mostra quasi assillante. Le odi in questione, come del resto la poesia sufi in generale, fanno però propria anche la tolleranza in materia religiosa, tant’è che alla morte del poeta, secondo gli studiosi, presero parte ai funerali sia i musulmani che le comunità di ebrei e cristiani di Konya.
“Vieni, deh vieni! ché da quando partisti più non mi resta né ragione né fede,/ e ogni calma e ogni pace partirono da questo povero cuore.”
La scrittura di Rumi si rivela intrisa di una spiritualità profondissima; un senso di devozione autentica e sincera che, inoltre, si prodiga dispensando consigli: tra i vari, evitare l’attaccamento alle cose materiali, viaggiare anzitutto dentro se stessi, addirittura non intraprendere lunghi viaggi (all’epoca ancor più lunghi e rischiosi) per andare in pellegrinaggio nella lontana Arabia, malgrado l’hajj alla Mecca – da compiersi almeno una volta nella vita – sia uno dei pilastri fondamentali dell’Islam.
“O gente partita in pellegrinaggio! Dove mai siete, dove mai siete?/ L’Amato è qui, tornate, tornate!/ L’Amato è un tuo vicino, vivete muro a muro:/ che idea v’è venuta di vagare nel deserto d’Arabia?”
Nell’insieme, un’opera poetica antica che, grazie al lavoro di selezione e traduzione di Alessandro Bausani, riesce ancora a offrire un testo molto interessante e coinvolgente anche al lettore di oggi. Un classico della letteratura persiana (e mondiale) intramontabile!
Questo testo viene pubblicato nella sezione “Rivista Nuova Euterpe” del sito “Blog Letteratura e Cultura” perché selezionato dalla Redazione della Rivista “Nuova Euterpe”, n°02/2024. L’autrice ha autorizzato alla pubblicazione senza nulla avere a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro.

Lascia un commento